Intervista a Massimo Coraddu, Fisico, consulente di parte procedimenti giudiziari poligoni Quirra e Teulada e consulente tecnico delle associazioni che si ribellano alla fabbrica di armi RWM e alla sua espansione.
Lo stabilimento RWM Italia Spa, la cosiddetta “fabbrica di bombe” che si trova nel Sud Sardegna, è stata convertita dal 2010 in una struttura militare, con la produzione orientata all’esportazione di armi. Nonostante le controversie ambientali e normative, l’azienda ha ottenuto le autorizzazioni per l’ampliamento dello stabilimento. In questa intervista parliamo della questione con Massimo Coraddu, fisico e consulente che conosce tutti i risvolti di questa vicenda.
 La RWM Italia Spa, un azienda di proprietà della multinazionale degli armamenti Rheinmetall, ha acquistato nel 2010 dalla SEI (Società Esplosivi Industriali) uno stabilimento nel sud della Sardegna, nel Sulcis, in una valle al confine tra il territorio dei comuni di Domusnovas e Iglesias.
La RWM Italia Spa, un azienda di proprietà della multinazionale degli armamenti Rheinmetall, ha acquistato nel 2010 dalla SEI (Società Esplosivi Industriali) uno stabilimento nel sud della Sardegna, nel Sulcis, in una valle al confine tra il territorio dei comuni di Domusnovas e Iglesias.
Sino al 2010 era uno stabilimento per la produzione di esplosivi per applicazioni civili (cave e miniere), a cui, dieci anni prima, nonostante le proteste e l’opposizione di buona parte della popolazione, era stata affiancata anche una linea di produzione per esplosivi e ordigni militari. Nel giro di un paio d’anni la nuova gestione dell’RWM ha riconvertito lo stabilimento a una produzione esclusivamente militare, cancellando del tutto la produzione di esplosivi per scopi civili. Con una politica commerciale assai spregiudicata l’RWM ha infatti orientato la sua produzione verso l’esportazione di armi, in prevalenza verso paesi extra-europei, anche impegnati in sanguinosi conflitti, di fatto i clienti più interessati a ricevere forniture di bombe, mine, missili e proiettili.
Quali sono i casi più eclatanti di RWM rispetto alla produzione e all’export di armi?
Clamoroso il caso delle forniture di bombe per aereo all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, un ordine pluriennale per circa 20.000 bombe con un importo di 400 milioni di euro, ordigni che sono stati impiegati per bombardare la popolazione Yemenita nel conflitto in corso dal 2016.
Quali sono le responsabilità dei vari governi che si sono susseguiti?
L’esportazione era stata autorizzata dall’esecutivo guidato da Matteo Renzi ma, in seguito ai bombardamenti indiscriminati contro la popolazione civile, il primo governo Conte ha poi sospeso le licenze di esportazione nel luglio 2019, tra le proteste di RWM che lamentava gravi danni economici, che non risultano però dai bilanci aziendali, sempre floridi, purtroppo. Per la cronaca, il governo Meloni, a Giugno 2023, ha ripristinato le licenze di RWM per l’esportazione di bombe per aereo verso l’Arabia Saudita.
Come cambia il fatturato di RWM da quando vengono sbloccate le licenze di export di armi verso le petromonarchie dell’Arabia Saudita?
L’esportazione di armi verso paesi in guerra è risultato un business assai redditizio per la RWM-Rheinmetall, visto che all’epoca della dismissione definitiva della produzione civile, nel 2012, il fatturato dell’azienda ammontava a circa 42 milioni di euro, con 6 milioni e mezzo di profitti, mentre nel 2019, anno in cui sono state sbloccate le licenze di esportazione verso le petro-monarchie arabe, il fatturato era cresciuto a oltre 114 milioni con oltre 25 milioni di profitti. La stessa crescita vertiginosa non aveva però interessato la manodopera impiegata, visto che nello stesso periodo i dipendenti dello stabilimento RWM di Domusnovas Iglesias erano aumentati di appena 30 unità, passando da 67 a 97. La crescita del business RWM non si è arrestata neppure con la sospensione delle sue più lucrose licenze di esportazione, visto che i fatturati hanno continuato a crescere: nel 2022 (ultimo bilancio disponibile) l’azienda ha registrato infatti 179 milioni di euro con quasi 19 milioni di utili, mentre il numero di dipendenti dello stabilimento è aumentato di una unità, arrivando a 98.
Oltre all’Arabia Saudita e agli altri Emirati in quali vari paesi volti a seminare guerra e terrore è indirizzata la produzione RWM?
L’azienda infatti, negli ultimi anni, ha sostenuto le esportazioni di bombe a Sauditi ed Emiratini, provvedendo ad allargare e diversificare il ventaglio dei suoi clienti, includendo altri paesi impegnati in conflitti armati: ha fornito bombe ad alta penetrazione alla Turchia, ha stretto accordi con l’azienda israeliana Uvision per la produzione e la commercializzazione dei droni-killer della serie Hero (utilizzati anche nel recente conflitto Arzebajian-Armenia) e recentemente ha fatto sapere di essere impegnata anche nella produzione di proiettili di artiglieria da fornire all’Ucraina per alimentare il conflitto in corso…
Come si vede si è avuto un vertiginoso aumento di fatturati e profitti senza crescita di occupazione, infatti l’azienda fa massiccio ricorso alla fornitura di manodopera interinale per coprire i picchi di produzione, senza assumere nuovo personale, e sbarazzandosi disinvoltamente dei lavoratori interinali alla prima incertezza.
Perché è stato necessario l’ampliamento dello stabilimento produttore di bombe?
La crescita degli ordini, a partire dallo scoppio della guerra in Yemen nel 2016, ha avuto però come conseguenza la saturazione della capacità produttiva dello stabilimento di Domusnovas-Iglesias, rendendo necessario il suo ampliamento. Di conseguenza l’azienda ha programmato, a partire dal 2017, un imponente piano di potenziamento degli impianti, con la realizzazione di nuovi reparti di produzione, magazzini, strade e piazzali e persino di un nuovo poligono per effettuare test esplosivi.
Perché l’area RWM è interessata da un forte rischio idrogeologico?
La realizzazione di tali nuove strutture risultava però assai problematica a causa della collocazione dello stabilimento, che in buona parte non si trova neppure in un area con destinazione industriale, ed è oltretutto privo di servizi di acquedotto e fognatura, non possiede un depuratore per il trattamento dei reflui industriali ed è servito da un unica strada di accesso di sezione molto ridotta, sulla quale transitano mezzi pesanti carichi di ordigni ed esplosivi. Oltretutto si trova incassato in una valle dalle pareti ripide e franose, attraversata da un fiume ad elevato rischio di esondazione (il Rio Figu) che divide in due lo stabilimento passando in mezzo agli impianti.
L’area è molto impattante in termini ambientalisti anche perché nei pressi si trova un importante territorio naturalistico. Puoi spiegare in cosa consiste?
Per queste ragioni l’area in cui si trova la fabbrica RWM risulta interessata da un rischio idrogeologico elevato, aggravato anche dalle passate attività minerarie dismesse da decenni, senza essere mai state messe in sicurezza, ed è quindi interessata da diversi vincoli. Se si aggiunge che a poche centinaia di metri dallo stabilimento si trova anche una importante area naturalistica protetta (la Z.S.C. ITB041111 “Monte Linas Marganai”) si capisce come l’area sia assolutamente inadatta per un attività così impattante e pericolosa e che il progetto per l’ampliamento degli impianti non poteva e non doveva essere accolto.
La RWM è riuscita nei suoi obiettivi di ampliamento nonostante queste problematiche ambientaliste?
L’azienda è invece riuscita a portare avanti i suoi piani di ampliamento, nonostante le problematiche evidenziate e le diffuse proteste, ricorrendo ad alcuni sotterfugi e stratagemmi risultati poi irregolari e illegittimi. In particolare ha frazionato il suo piano di ampliamento di potenziamento degli impianti in un gran numero di interventi (tra il 2017 e il 2021 se ne contano circa un centinaio …), per i quali ha richiesto altrettante autorizzazioni edilizie, come se si trattasse di singoli progetti indipendenti e scorrelati. Oltretutto ha sistematicamente negato che nel suo stabilimento di Domusnovas-Iglesias si producessero esplosivi attraverso procedimenti chimici, nonostante l’azienda fosse in possesso di licenze di fabbricazione di esplosivi di tipo PBX, rilasciati dal ministero dell’interno, e che i manuali pubblicati dai collaboratori dell’azienda mostrassero chiaramente come per la produzione di questi esplosivi fossero coinvolti processi chimici di polimerizzazione.
E la Valutazione di Impatto Ambientale?
Grazie a queste evidenti forzature RWM ha ottenuto che le amministrazioni coinvolte (comuni, Provincia e Regione) rilasciassero tutte le licenze edilizie per l’ampliamento dei suoi impianti senza nessuna Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che oltretutto è obbligatoria per le industrie chimiche che producono esplosivi.
Come si è posta la popolazione nella produzione di armi nel Sulcis? come si è svolta la protesta degli abitanti e dei cittadini?
Alla produzione di armi nel Sulcis si è sempre opposta una parte significativa della popolazione, sin dall’avvio delle prime linee di produzione da parte della società SEI. Tale opposizione si è poi rivitalizzata e rafforzata a partire dal 2015, con le notizie dell’impiego delle bombe prodotte in Sardegna nella guerra in Yemen, e dei progetti di ampliamento di RWM. Questa opposizione si è sempre espressa in vari modi: manifestazioni sia nell’area della fabbrica, con l’intento di ostacolarne le produzioni, sia di fronte alle istituzioni responsabili di favorirne l’ampliamento, ma anche azioni legali finalizzate a bloccare licenze di esportazione e progetti di ampliamento.
Quindi RWM non è stata mai sottoposta alla VIA – Valutazione Impatto Ambientale?
In particolare, dal 2019 al 2021 abbiamo portato avanti un lungo contenzioso legale, nei tribunali amministrativi, per dimostrare che RWM aveva ottenuto le licenze edilizie per ampliare il suo stabilimento di Domusnovas-Iglesias in modo irregolare e illegittimo. Nel novembre del 2021 il Consiglio di Stato ci ha finalmente dato ragione, sentenziando che il frazionamento del piano di ampliamento di RWM in una miriade di singoli progetti non era legittimo, che quello di RWM è uno stabilimento chimico che produce esplosivi e che quindi il suo piano di ampliamento doveva essere sottoposto complessivamente a Valutazione di Impatto Ambientale, cosa mai avvenuta.
Si può anche parlare di abuso edilizio? Ad esempio di reparti abusivi dell’azienda?
Di conseguenza il Consiglio di Stato ha annullato le autorizzazione alla realizzazione di alcune delle opere più importanti realizzate dall’azienda, compresi il nuovo poligono per test esplosivi e i nuovi reparti per la produzione di ordigni ed esplosivo di tipo PBX. L’azienda nel frattempo, mentre i tribunali decidevano sui ricorsi, ha realizzato in gran fretta i lavori di ampliamento, terminati nel 2021, e si ritrova quindi ora con i reparti finiti ma abusivi, privi di autorizzazione edilizia, e che quindi non possono entrare in funzione.
Quindi la RWM non si è rassegnata all’idea di poter rinunciare all’ampliamento?
RWM-Rheinmetall non si è affatto rassegnata all’idea di non poter avviare i nuovi reparti e ha chiesto alla Regione Sardegna di effettuare una VIA a posteriori delle opere realizzate illecitamente, sostenendo che un eventuale esito positivo autorizzerebbe l’azienda ad aprire i reparti e avviare la produzione. Si tratta di una evidente forzatura della normativa, visto che in questo modo la VIA, che di regola andrebbe effettuata prima della realizzazione delle opere e non a posteriori, agirebbe come una sorta di sanatoria delle opere realizzate illecitamente, tuttavia la Regione Sardegna nell’estate del 2022 ha avviato la procedura per la VIA “postuma” del progetto di ampliamento dello stabilimento RWM (in realtà solo di una parte di esso), e la procedura è ancora in corso.
Dunque si può parlare di rischio idrogeologico e mancata tutela paesaggistica?
Naturalmente le stesse organizzazioni che si erano opposte all’ampliamento si oppongono ora anche alla VIA-”postuma” per lo stabilimento RWM di Domusnovas-Iglesias, sostenendo che la procedura è illegittima e che, in ogni caso, non può avere un esito positivo, a causa dei numerosi vincoli che insistono sull’area, non solo legati al rischio idrogeologico, ma anche alla tutela paesaggistica, alla mancata destinazione industriale dell’area, all’impatto sulla vicina area naturalistica protetta (Z.S.C. ITB041111 “Monte Linas Marganai”).
L’azienda vuole quindi eliminare un reticolo idrografico per ampliare i suoi spazi e quindi la produzione bellica?
In questo contesto si inserisce la richiesta di RWM di cancellare dal “reticolo idrografico” alcuni corsi d’acqua presenti all’interno della sua proprietà. Tale richiesta, a gennaio 2024, è stata rivolta all’Autorità di Bacino Idrografico, un ufficio regionale che si occupa di sicurezza idrogeologica, con il supporto dei comuni di Iglesias e di Domusnovas.
RWM vuole eliminare tutti i corsi d’acqua che ne impediscono l’espansione?
L’azienda chiede in pratica di eliminare sulla carta tutti i corsi d’acqua interni alla sua proprietà che confluiscono nel Rio Figu, il fiume a elevato rischio di esondazione che attraversa lo stabilimento. Alcuni dei corsi d’acqua di cui si chiede la cancellazione si trovano però all’interno dello stabilimento, e le norme di salvaguardia avrebbero obbligato l’azienda a rispettare delle fasce di sicurezza di ampiezza variabile tra 20 e 50 metri, cosa che non è avvenuta, visto che attualmente l’alveo di questi corsi d’acqua appare profondamente alterato dalle costruzioni realizzate, sino a scomparire del tutto in alcuni tratti. Oltretutto tali corsi d’acqua confluiscono nel Rio Figu a cui, a causa dell’elevato rischio idrogeologico, è associata una fascia di rispetto larga 150 metri, nella quale si trova una zona a rischio idrogeologico (zona cosiddetta Hi4) dove, per ragioni di sicurezza, non possono assolutamente essere realizzati impianti industriali come quelli di RWM. Ciò nonostante, anche in tempi recenti, l’azienda per espandersi ha realizzato in quest’area a elevato rischio idrogeologico imponenti sbancamenti (per decine di migliaia di metri cubi) e ha costruito grandi strutture. Ancora ci chiediamo come sia stato possibile che abusi di questa entità siano stati realizzati alla luce del sole, senza che nessuna delle autorità competenti muovesse obiezioni.
Vi è una forte esposizioni a impattanti rischi idrogeologici?
I corsi d’acqua di cui l’azienda chiede la cancellazione confluiscono nel Rio Figu proprio nelle aree Hi4, ad elevato rischio idrogeologico, senza che la relazione aziendale che ne chiede la cancellazione rilevi questo fatto fondamentale. A dire la verità la richiesta presentata dall’azienda contiene carte non aggiornate (risalenti a prima del 2000), in cui tutti gli ampliamenti dello stabilimento RWM realizzati nel frattempo non appaiono neppure!
Due settimane fa le organizzazioni che si sono sempre opposte all’ampliamento di RWM, hanno mandato all’ Autorità di Bacino Idrografico un documento critico sulla richiesta di cancellazione dei corsi d’acqua dalla proprietà RWM, in cui si fanno presente le anomalie esposte pocanzi. L’Autorità di Bacino ha risposto ieri (17 Aprile), accogliendo sostanzialmente le nostre osservazioni, sospendendo l’esame della richiesta di cancellazione e chiedendo chiarimenti ai comuni di Iglesias e Domusnovas. Data la contemporanea presenza dell’area di un rischio idrogeologico molto elevato e di una industria “a rischio di incidente rilevante” (classificata così in base alla direttiva “Seveso III” dell’UE), a noi sembra ovvio che la richiesta di cancellazione dei corsi d’acqua, e delle relative fasce di tutela, non possa essere accolta, e che anzi vada accertata la presenza di eventuali abusi.
Quali sono le proposte e le decisioni per evitare rischi idrogeologici?
Vista così, la richiesta presentata da Rheinmetall-RWM per la cancellazione dei corsi d’acqua dalla loro proprietà, potrebbe apparire come un maldestro tentativo di alleggerire i vincoli idrogeologici presenti nell’area e rendere più facile una sorta di “sanatoria” di fatto degli abusi compiuti. Tuttavia una decisione definitiva non è ancora stata presa, anche la procedura di VIA “postuma” è ancora in corso, e l’opposizione a questa produzione mortifera e al suo ampliamento è forte e determinata.
RWM vuole forzare le normative esistenti sia sulla fornitura dei paesi belligeranti sia sulla tutela del paesaggio e dei suoi abitanti.
In definitiva appare evidente come una industria che produce armi ed esplosivi destinati ad alimentare i conflitti in corso riesca spesso a forzare le normative esistenti, sia quelle che dovrebbero impedire la fornitura di armamenti ai paesi in guerra, sia quelle che dovrebbero tutelare la sicurezza della popolazione, dell’ambiente e del territorio.
Nonostante le evidenti violazioni, sanzionate anche dai tribunali, sono stati realizzati in un area a elevato rischio idrogeologico impianti ad alto rischio, destinati a fabbricare ordigni micidiali. Anche in presenza di sentenze ormai passate in giudicato, l’azienda non si rassegna e ricorre a ogni mezzo, compresa la “cancellazione” legale dei corsi d’acqua dalla sua proprietà, pur di “sanare” la situazione e ottenere l’apertura e la messa in produzione dei nuovi impianti realizzati illecitamente.
L’intera società non deve essere corrotta nella propria mentalità, orientandola a una economia di guerra, ossia bellica e militarista.
Quando si parla di capacità di corruzione dell’industria degli armamenti, non si vuole intendere tanto l’eventuale corruzione di singoli individui e/o funzionari pubblici, quanto piuttosto la capacità di corrompere l’intera società, che viene progressivamente orientata a una economia bellica, rinunciando di fatto a fondamentali garanzie di salute e sicurezza per la popolazione. Questo progressivo scivolamento verso una economia di guerra avviene sotto i nostri occhi, attraverso procedimenti anche legali, o semi-legali, che portano alla progressiva erosione delle norme e delle garanzie che dovrebbero tutelare la sicurezza della popolazione, il territorio e l’ambiente.
Come si pone la resistenza di queste popolazioni contro i colossi dell’industria militare?
La resistenza della popolazione contro questi colossi degli armamenti è impari, la società civile trova difficoltà a opporsi alle schiere di avvocati e tecnici al soldo delle società armiere, le amministrazioni pubbliche sono per lo più orientate alla difesa difesa degli interessi dei produttori di armi, e giustificano il loro atteggiamento con la vaga promessa di una manciata di “posti di lavoro”. La storia dello stabilimento Rheinmetall-RWM, in questo senso, è esemplare.
La resistenza contro la resistibile ascesa dell’industria delle armi è tuttavia irrinunciabile, ne va della nostra sopravvivenza.
Anche sul sito dell’Associazione Italia che cambia
Sitografia per approfondire:
Canale Facebook https://www.facebook.com/laura.tussi
Canale YouTube https://youtube.com/@LauraTussi?si=vToObZGDLPkXKGAJ
Canale Instagram https://instagram.com/cracolicifabrizio
Canale TikTok https://www.tiktok.com/@fabrizio.cracolici?_t=8imKGq9A35U&_r=1
Canale Mastodon @laura@sociale.network
Bibliografia essenziale:
-
Laura Tussi e Fabrizio Cracolici, Resistenza e nonviolenza creativa, Mimesis Edizioni.
-
Laura Tussi e Fabrizio Cracolici, Memoria e futuro, Mimesis Edizioni. Con scritti e partecipazione di Vittorio Agnoletto, Moni Ovadia, Alex Zanotelli, Giorgio Cremaschi, Maurizio Acerbo, Paolo Ferrero e altr*
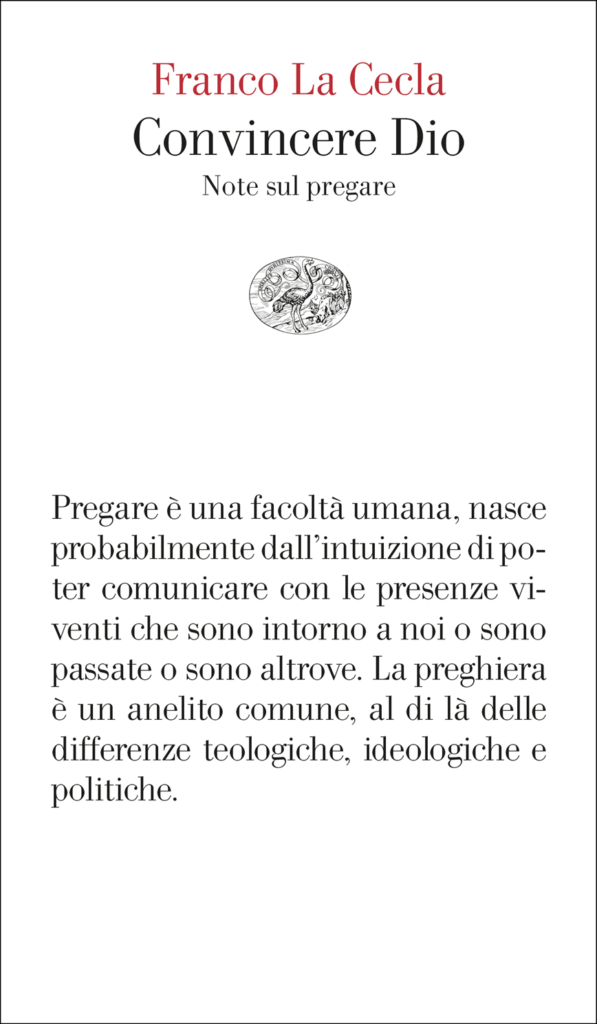 “Ci troviamo in una situazione paradossale in cui, masochisticamente, un Occidente che pensava di essere la civiltà piú avanzata ha abdicato all’esplorazione coraggiosa dell’esistenza. Siamo condannati da un presunto realismo a rinunciare alle stesse spinte che vengono dai nostri processi mentali, sensoriali, emozionali. Come se qualcuno ci avesse comandato di fare a meno di tutte le illusioni in nome di una concretezza che oramai non trova piú il terreno da cui sarebbe sorta. Il materialismo ansioso, di cui la rivoluzione industriale e il capitalismo si sono ammantati e che ha sostentato le religioni laiche nate al loro interno, puzza della deriva stanca del secolo XIX e oggi appare solo una ridicola ideologia occidentale”. Così prosegue La Cecla: “ Non conosciamo alcuna società contemporanea a noi, che sia in Oriente o tra i popoli nativi dell’Occidente o tra le culture del Sud e del Grande Nord, che non abbia un tipo di pratica per comunicare con l’invisibile. E se ci proiettiamo nel passato, per millenni non troviamo alcuna civiltà di cui abbiamo resti, tracce, lasciti che non si sia occupata in maniera quotidiana e pervasiva di allargare i propri orizzonti al di là dell’immediato fruibile ed esperibile. Nell’idea di esperienza di queste società è sempre presente un tipo di «aldilà», che accompagna e sostanzia il qui e ora. La nostra società è l’unica che si nega questa facoltà, frutto di una menomazione essenziale, come se avesse deciso di vivere in un quadro dell’adesso impoverito di tutte le influenze, le azioni, il sussurro, le ispirazioni che vengono da altrove. Una situazione di solitudine e di ascetismo assurdo, tanto piú che la nostra società crede quasi ciecamente in qualcosa di assolutamente invisibile – il futuro –, a cui sacrifica spesso il benessere e il buon vivere presente. Il futuro, qualcosa di intangibile e inafferrabile, su cui proiettiamo noi stessi come se fosse una terra promessa, da cui ci aspettiamo messaggi, compimenti di desideri, che viviamo come molto piú reale e convincente dell’oggi. Ma ultimamente «quello che sarà» è diventato opaco e improbabile, una pattumiera del presente, che ha ridotto le promesse a quelle di una sopravvivenza ai disastri causati da noi adesso. Questo forse spiega perché siamo una società che sta finendo. Credere nell’aldilà o credere nel futuro sono due cose simili (gestite in modo diverso: il primo è un tipo di ascolto, il secondo una proiezione del nostro chiacchiericcio).”
“Ci troviamo in una situazione paradossale in cui, masochisticamente, un Occidente che pensava di essere la civiltà piú avanzata ha abdicato all’esplorazione coraggiosa dell’esistenza. Siamo condannati da un presunto realismo a rinunciare alle stesse spinte che vengono dai nostri processi mentali, sensoriali, emozionali. Come se qualcuno ci avesse comandato di fare a meno di tutte le illusioni in nome di una concretezza che oramai non trova piú il terreno da cui sarebbe sorta. Il materialismo ansioso, di cui la rivoluzione industriale e il capitalismo si sono ammantati e che ha sostentato le religioni laiche nate al loro interno, puzza della deriva stanca del secolo XIX e oggi appare solo una ridicola ideologia occidentale”. Così prosegue La Cecla: “ Non conosciamo alcuna società contemporanea a noi, che sia in Oriente o tra i popoli nativi dell’Occidente o tra le culture del Sud e del Grande Nord, che non abbia un tipo di pratica per comunicare con l’invisibile. E se ci proiettiamo nel passato, per millenni non troviamo alcuna civiltà di cui abbiamo resti, tracce, lasciti che non si sia occupata in maniera quotidiana e pervasiva di allargare i propri orizzonti al di là dell’immediato fruibile ed esperibile. Nell’idea di esperienza di queste società è sempre presente un tipo di «aldilà», che accompagna e sostanzia il qui e ora. La nostra società è l’unica che si nega questa facoltà, frutto di una menomazione essenziale, come se avesse deciso di vivere in un quadro dell’adesso impoverito di tutte le influenze, le azioni, il sussurro, le ispirazioni che vengono da altrove. Una situazione di solitudine e di ascetismo assurdo, tanto piú che la nostra società crede quasi ciecamente in qualcosa di assolutamente invisibile – il futuro –, a cui sacrifica spesso il benessere e il buon vivere presente. Il futuro, qualcosa di intangibile e inafferrabile, su cui proiettiamo noi stessi come se fosse una terra promessa, da cui ci aspettiamo messaggi, compimenti di desideri, che viviamo come molto piú reale e convincente dell’oggi. Ma ultimamente «quello che sarà» è diventato opaco e improbabile, una pattumiera del presente, che ha ridotto le promesse a quelle di una sopravvivenza ai disastri causati da noi adesso. Questo forse spiega perché siamo una società che sta finendo. Credere nell’aldilà o credere nel futuro sono due cose simili (gestite in modo diverso: il primo è un tipo di ascolto, il secondo una proiezione del nostro chiacchiericcio).” La lotta partigiana con alla testa le Brigate Garibaldine liberò Firenze l’11 agosto 1944. Il Comandante della Brigata Sinigaglia descrisse così i “tre momenti” della lotta partigiana: guerra di liberazione contro l’occupante nazista, guerra civile contro i collaborazionisti fascisti, lotta di classe contro il sistema che aveva prodotto la guerra. Per queste ragioni il Comandante della Brigata Sinigaglia ha ritenuto incompiuto il compito della Resistenza e sin dall’immediato dopoguerra ha continuato a lottare contro l’insediamento di basi USA e NATO in Italia.
La lotta partigiana con alla testa le Brigate Garibaldine liberò Firenze l’11 agosto 1944. Il Comandante della Brigata Sinigaglia descrisse così i “tre momenti” della lotta partigiana: guerra di liberazione contro l’occupante nazista, guerra civile contro i collaborazionisti fascisti, lotta di classe contro il sistema che aveva prodotto la guerra. Per queste ragioni il Comandante della Brigata Sinigaglia ha ritenuto incompiuto il compito della Resistenza e sin dall’immediato dopoguerra ha continuato a lottare contro l’insediamento di basi USA e NATO in Italia.

 Tutto ciò avvenne prima che fossero tutti rapidamente uccisi con le armi, decimati dai lavori forzati e dalle malattie che accompagnarono le spedizioni di Colombo e dei suoi successori. Lo sterminio degli indiani Taïno di Haiti – in realtà il genocidio, perché di genocidio si trattò – chiuse una porta alla possibilità dell’evoluzione pacifica delle società umane. A questo proposito, la loro storia potrebbe trovare posto nel libro di David Graeber, L’alba di tutto: una nuova storia dell’umanità, con la sua descrizione delle molte società umane distrutte, in particolare, dall’imperialismo e dal capitalismo occidentale.
Tutto ciò avvenne prima che fossero tutti rapidamente uccisi con le armi, decimati dai lavori forzati e dalle malattie che accompagnarono le spedizioni di Colombo e dei suoi successori. Lo sterminio degli indiani Taïno di Haiti – in realtà il genocidio, perché di genocidio si trattò – chiuse una porta alla possibilità dell’evoluzione pacifica delle società umane. A questo proposito, la loro storia potrebbe trovare posto nel libro di David Graeber, L’alba di tutto: una nuova storia dell’umanità, con la sua descrizione delle molte società umane distrutte, in particolare, dall’imperialismo e dal capitalismo occidentale. È interessante osservare da vicino le famose “condizioni” poste dalla Francia nel 1825 per negoziare questo debito e confrontarle con le “condizioni” poste dalla Francia al momento dell’indipendenza delle colonie africane negli anni ’60…. Nel 1960, non era più dignitoso chiedere il rimborso ai coloni, soprattutto perché la continua presenza francese nella maggior parte dei paesi non lo giustificava. Si riscontrano inoltre i vantaggi di accordi commerciali a favore dell’ex colonizzatore e, soprattutto, la presenza di banche francesi e del famoso franco CFA [Communauté Financière Africaine, NdT] come moneta di controllo economico e finanziario. Nel 1825, Haiti era già nelle prime fasi del neocolonialismo in Africa e altrove.
È interessante osservare da vicino le famose “condizioni” poste dalla Francia nel 1825 per negoziare questo debito e confrontarle con le “condizioni” poste dalla Francia al momento dell’indipendenza delle colonie africane negli anni ’60…. Nel 1960, non era più dignitoso chiedere il rimborso ai coloni, soprattutto perché la continua presenza francese nella maggior parte dei paesi non lo giustificava. Si riscontrano inoltre i vantaggi di accordi commerciali a favore dell’ex colonizzatore e, soprattutto, la presenza di banche francesi e del famoso franco CFA [Communauté Financière Africaine, NdT] come moneta di controllo economico e finanziario. Nel 1825, Haiti era già nelle prime fasi del neocolonialismo in Africa e altrove. “
“
 La Magni*fica ha cercato e cerca di essere uno spazio per persone che sopravvivono alla violenza machista, di genere o di matrice omofoba. Questo è un altro aspetto molto importante. E da poco, insieme a “Favolosk3”, abbiamo aperto una cassa di sorellanza in cui versiamo una parte di quello che riusciamo a ricavare. La cassa di sorellanza aiuta nelle spese che possono riguardare le conseguenze di episodi di violenza personale: come le visite da professioniste della salute mentale, o un appoggio medico, o un percorso di transizione medicalmente assistito, o farmaci per la terapia ormonale, come il Sandrena, aumentato di costo del 250%, o farmaci salvavita.
La Magni*fica ha cercato e cerca di essere uno spazio per persone che sopravvivono alla violenza machista, di genere o di matrice omofoba. Questo è un altro aspetto molto importante. E da poco, insieme a “Favolosk3”, abbiamo aperto una cassa di sorellanza in cui versiamo una parte di quello che riusciamo a ricavare. La cassa di sorellanza aiuta nelle spese che possono riguardare le conseguenze di episodi di violenza personale: come le visite da professioniste della salute mentale, o un appoggio medico, o un percorso di transizione medicalmente assistito, o farmaci per la terapia ormonale, come il Sandrena, aumentato di costo del 250%, o farmaci salvavita. ddomesticava i pareri tecnici, minacciava o blandiva i funzionari, arrivava a modificare la legislazione ambientale. Una “squadra” che oggi pare dissolta, ma tutti i presupposti che l’hanno fatta nascere non sono solo sopravvissuti, ma cresciuti; probabilmente altre “squadre”, magari più prudenti, sono all’opera, ma dubitiamo che siano svanite; le cronache dal Terzo Valico, dalla linea Torino Lione, dallo Stretto di Messina ci dicono di come queste megaopere alimentino gli appetiti del sistema che vive di grandi opere, soprattutto quelle inutili.
ddomesticava i pareri tecnici, minacciava o blandiva i funzionari, arrivava a modificare la legislazione ambientale. Una “squadra” che oggi pare dissolta, ma tutti i presupposti che l’hanno fatta nascere non sono solo sopravvissuti, ma cresciuti; probabilmente altre “squadre”, magari più prudenti, sono all’opera, ma dubitiamo che siano svanite; le cronache dal Terzo Valico, dalla linea Torino Lione, dallo Stretto di Messina ci dicono di come queste megaopere alimentino gli appetiti del sistema che vive di grandi opere, soprattutto quelle inutili. empre Giani, ci vuol condurre con lo scavo dei tunnel.
empre Giani, ci vuol condurre con lo scavo dei tunnel.
 Ma sono soprattutto i modi di agire di Guerrieri che attraggono il lettore, il suo non abituarsi ad accettare il fatto di doversi rapportare con chi dovrà vivere in prigione, non a caso non festeggerà mai la condanna di qualcuno, con il ” fine pena mai “; i suoi scontri caratteriali con il pm, anche se in questo caso si rivela essere amico, o il capo della mobile di turno; a lui non piace che i sottoposti agli interrogatori siano fatti innervosire senza motivo alcuno, se non quello, recondito, di ottenere informazioni utili conseguenti ad un crollo psicologico.
Ma sono soprattutto i modi di agire di Guerrieri che attraggono il lettore, il suo non abituarsi ad accettare il fatto di doversi rapportare con chi dovrà vivere in prigione, non a caso non festeggerà mai la condanna di qualcuno, con il ” fine pena mai “; i suoi scontri caratteriali con il pm, anche se in questo caso si rivela essere amico, o il capo della mobile di turno; a lui non piace che i sottoposti agli interrogatori siano fatti innervosire senza motivo alcuno, se non quello, recondito, di ottenere informazioni utili conseguenti ad un crollo psicologico.

 Inoltre, se verranno incentivate la libera circolazione e la sosta in San Salvi, come si potrà impedire che i futuri abitanti dei nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Sociale previsti nel padiglione interessato dal cosiddetto “ Progetto di rigenerazione urbana” non pretendano dei parcheggi pertinenziali per le abitazioni, sottraendo ulteriore spazio al parco, in una logica privatistica ed esclusiva. Con questa dissennata scelta viabilistica, che conferma l’intoccabile autocrazia dell’automobile, viene naturale chiedersi quanto sia reale e coerente l’obiettivo strategico perseguito dall’Amministrazione comunale di ridurre il traffico privato a beneficio del trasporto pubblico, se anche in un’area di pregio a vocazione naturalistica, come San Salvi, dalle dimensioni limitate e attraversabile in tempi brevi anche a piedi, non possa essere, se non nell’immediato, in un prossimo futuro liberata quasi totalmente dal traffico. Sarebbero necessarie, prioritariamente, delle misure di pianificazione trasportistica per ridurre progressivamente la dipendenza dal mezzo privato, e spostare le esigenze di mobilità dall’automobile al mezzo pubblico, per decongestionare non solo l ‘area ma anche la stessa viabilità di contorno. Si pensi, a tale fine, alle potenzialità offerte dalla stazione ferroviaria a San Salvi, prevista da decenni e ancora da realizzare o all’opportunità di un servizio di minibus per gli scolari della scuola elementare Andrea del Sarto per eliminare le tante auto che entrano quotidianamente in San Salvi per accompagnare e riprendere i bambini fino al cancello della scuola; così come della necessità di parcheggi esterni al perimetro dell’area per la quota di coloro che gravitano per lavoro su San Salvi e non possono rinunciare all’auto, o per i suoi futuri locatari di cui si è sopra accennato.
Inoltre, se verranno incentivate la libera circolazione e la sosta in San Salvi, come si potrà impedire che i futuri abitanti dei nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Sociale previsti nel padiglione interessato dal cosiddetto “ Progetto di rigenerazione urbana” non pretendano dei parcheggi pertinenziali per le abitazioni, sottraendo ulteriore spazio al parco, in una logica privatistica ed esclusiva. Con questa dissennata scelta viabilistica, che conferma l’intoccabile autocrazia dell’automobile, viene naturale chiedersi quanto sia reale e coerente l’obiettivo strategico perseguito dall’Amministrazione comunale di ridurre il traffico privato a beneficio del trasporto pubblico, se anche in un’area di pregio a vocazione naturalistica, come San Salvi, dalle dimensioni limitate e attraversabile in tempi brevi anche a piedi, non possa essere, se non nell’immediato, in un prossimo futuro liberata quasi totalmente dal traffico. Sarebbero necessarie, prioritariamente, delle misure di pianificazione trasportistica per ridurre progressivamente la dipendenza dal mezzo privato, e spostare le esigenze di mobilità dall’automobile al mezzo pubblico, per decongestionare non solo l ‘area ma anche la stessa viabilità di contorno. Si pensi, a tale fine, alle potenzialità offerte dalla stazione ferroviaria a San Salvi, prevista da decenni e ancora da realizzare o all’opportunità di un servizio di minibus per gli scolari della scuola elementare Andrea del Sarto per eliminare le tante auto che entrano quotidianamente in San Salvi per accompagnare e riprendere i bambini fino al cancello della scuola; così come della necessità di parcheggi esterni al perimetro dell’area per la quota di coloro che gravitano per lavoro su San Salvi e non possono rinunciare all’auto, o per i suoi futuri locatari di cui si è sopra accennato.