La sottrazione dello spazio pubblico, decretata dalla pandemia, è l’ultimo capitolo di un processo di spoliazione che ha impoverito le città. È questo il momento per ripensare al valore sociale e antropologico dello spazio collettivo, e prospettare il futuro urbano.
“Vivremo on line”, è la breve, epigrafica riflessione di un amico filosofo, nel momento in cui veniva decretata la detenzione domestica, estesa a sessanta milioni di italiani. Impareremo, daremo lezioni, lavoreremo, consumeremo, socializzeremo dall’interno delle mura domestiche (chi una casa la possiede).
Lo spaccato di un futuro distopico e tecnofascista sta assumendo connotati concreti. Gran parte della popolazione mondiale, reclusa in nome della propria sopravvivenza, è stata deprivata degli spazi collettivi. Scuole e aule universitarie, teatri e cinema, chiese e musei, ma anche strade e piazze, boschi, mare e campagna, d’un sol tratto sono diventati off limits per tutti. Esclusi naturalmente gli addetti al mantenimento in vita del genere umano, dai medici agli agricoltori.
 Ognuno ha provato la povertà di senso di una vita compresa (e compressa) nello spazio domestico. L’esempio paradigmatico: la scuola online. Docenti in salotto e allievi nella cameretta: terminali domestici di un rapporto smaterializzato.
Ognuno ha provato la povertà di senso di una vita compresa (e compressa) nello spazio domestico. L’esempio paradigmatico: la scuola online. Docenti in salotto e allievi nella cameretta: terminali domestici di un rapporto smaterializzato.
La mancanza di luoghi comuni, di ambienti pubblici, di socialità esercitata nello spazio comune, ha acuito il lavoro “ombra” gravante sulle spalle delle donne, ha acuito le divergenze sociali. Gli abbienti in case comode, ampio terrazzo e vista sul paesaggio. I subalterni invece in appartamenti mal concepiti, periferici, ammassati in blocchi disumani. Molti hanno dovuto convivere con la tragedia delle invalidità, delle psicosi, dell’alcol, della violenza domestica.
Uscire ha comportato produrre un giustificativo da mostrare alle forze dell’ordine, rischiare la delazione del vicino di casa, avventurarsi nel grande laboratorio securitario della sopravvivenza.
Ma lo spazio pubblico non è solo il “fuori”. È viceversa il cuore pulsante di una società civile.
Lo spazio pubblico è, secondo Simone Weil (1949), un’«esigenza dell’anima»: la partecipazione e l’uso dello spazio pubblico hanno valore sociale: per la Weil, il lusso di questi ambienti comuni (inteso come grandezza dell’architettura, sua ricchezza semantica, generosità dei volumi e delle superfici) dovrà essere universalmente godibile, dovrà arrivare anche ai più umili. Se Hannah Arendt (1958) ancorava la vita politica (l’«agire insieme») alla sussistenza dello spazio pubblico (il «mondo comune»), più recentemente Françoise Choay ha rimarcato che il valore simbolico dello spazio pubblico è capace di confermare «il nostro stato di cultura e le nostre identità umane nel tempo». Dunque, l’esistenza e il diritto allo spazio comune è garanzia di azione politica, di continuità culturale e antropologica.
Edoardo Salzano ha più volte sottolineato come il diritto universale allo spazio pubblico, in Italia si sia conquistato attraverso il conflitto sociale e la lotta politica. La lotta, eminentemente femminista, innescò la scintilla: un decreto del 1968 (millenovecentosessantotto…) attribuiva ad ogni residente una quota minima di attrezzature pubbliche: giardini, scuole, teatri, ambulatori ecc.; e formulava amministrativamente tale diritto sotto forma di “standard urbanistici”.
Negli anni del neoliberismo, il decreto 1444/1968 è stato progressivamente smantellato in favore di una governance urbana di matrice aziendalista. La dotazione minima in termini di servizi e attrezzature è stata ridotta a “monetizzazione” da investire in generica “riqualificazione urbana”(operazione che ha poi favorito l’innalzamento dei valori immobiliari per mano del pubblico). Il decreto “del fare” (2013) ha lasciato mano libera alle regioni che possono oggi derogare dalle disposizioni che garantivano sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali.
Negli stessi anni, la città è stata privatizzata (anche) nella sua consistenza fisica: strade, piazze ed edifici demaniali, questi sistematicamente svenduti a vantaggio dell’interesse particolare. È nell’esperienza comune, tra i mille esempi possibili, l’erosione dello spazio di agibilità all’interno delle cosiddette “grandi stazioni”, dove viaggiatori e pendolari sono costretti a percorsi di risulta tra una boutique e l’altra. Nelle piazze monumentali, ridotte a scenario ad uso dei consumatori, in palcoscenici di eventi mercantili, si manifesta esemplarmente lo slittamento – subdolo – dall’uso pubblico al “recinto” privato.
A più di cinquant’anni dall’introduzione di un’eguaglianza nazionale in termini di spazi pubblici, nelle città disossate dalla privatizzazione, nei recinti mercificati, nell’isolamento domestico, è necessaria la riattivazione di un dibattito sulla qualità dell’ambiente comune e pubblico. Che auspicabilmente porti a una rivendicazione sociale del diritto allo spazio pubblico, e quindi politico.
*Ilaria Agostini


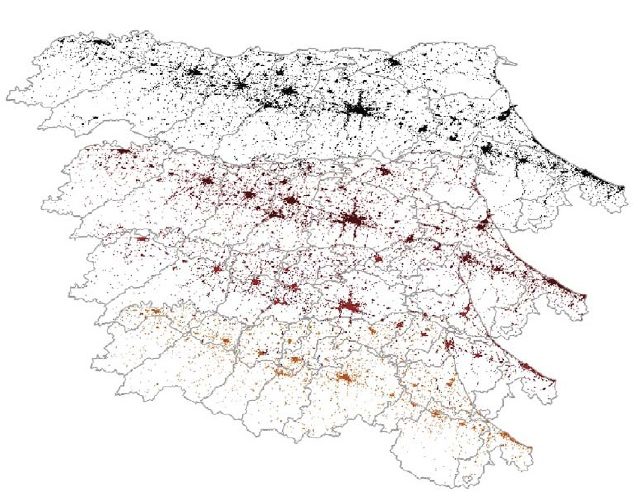




Pingback: Firenze: mettiamo a frutto la crisi. Manifesto per la riconquista popolare della città | www.salviamoilpaesaggio.it
Pingback: Ilaria Agostini, Francesco Indovina: Da Firenze a Venezia alla riconquista della città : Inchiesta