Se circoscritta al momento del voto e a pratica consensuale, la partecipazione popolare non funziona, e produce anzi un effetto boomerang. La partecipazione funziona invece quando il destino dei territori è inscritto in processi di democrazia diretta e in una diffusa coscienza territoriale. Funziona quando le scelte dal basso e le pratiche partecipative non sono solo una concessione del principe.
Recentemente, a Firenze, è stata invocata dal basso la “partecipazione dei cittadini” come rimedio ai mali di una pessima gestione urbana. “Partecipazione dei cittadini” che è stata in effetti (parzialmente) concessa. Ma non per decidere collettivamente – ad esempio – di un bene monumentale pubblico, come l’ex convento, poi ospedale di militare in costa San Giorgio, passato in mano privata per farne un albergo stralusso. La partecipazione popolare è stata concessa per delineare il futuro Piano Regolatore.
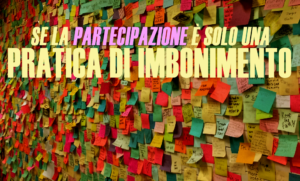 Il senso è: “non vi concediamo la parola su ciò che vi sta a cuore, ma vi diamo libertà di espressione nel piano generale di ridisegno della città”. Una scelta dal sapore demagogico: la brioscia invece del pane.
Il senso è: “non vi concediamo la parola su ciò che vi sta a cuore, ma vi diamo libertà di espressione nel piano generale di ridisegno della città”. Una scelta dal sapore demagogico: la brioscia invece del pane.
Perché se “concessa” dall’alto, perché se attinente a complesse questioni di carattere eminentemente tecnico, la partecipazione non può funzionare? Proviamo a capire.
In generale, gli episodi di partecipazione diretta sono diffusi nei paesi nord-europei dove è più forte il senso dell’interdipendenza sociale. In Italia, per ragioni storiche e per motivi legati alla macchina amministrativa, è più diffuso attendersi che siano le istituzioni e il governo centrale a risolvere questi problemi. Se, in alcune città e in alcune regioni (pensiamo, ad esempio, al piano paesaggistico della Puglia), la partecipazione cittadina è stata attiva riuscendo perfino a condizionare alcune scelte del governo locale, oggi il modello è sempre più accentrato, e difficilmente delega o incoraggia la cittadinanza a intervenire direttamente sulle grandi questioni di urbanistica e pianificazione. Ma anche su problemi minori.
Si potrebbe affermare che oggi nelle amministrazioni locali non c’è spazio politico per la partecipazione, poiché esse vi vedono limitato il proprio potere discrezionale o vi intravedono il conflitto tra volontà generale e aspirazioni imprenditoriali o clientelari. Chi dal basso ci ha creduto, dopo anni di attivismo dei comitati nei percorsi partecipativi, si è reso conto che la partecipazione non è decollata. I casi a Firenze sono molteplici: Meccanotessile, Manifattura Tabacchi, Caserma Cavalli, Panificio militare, piazza Annigoni, Le Piagge, San Salvi, Oltrarno etc.
Le istituzioni locali ricorrono a questi percorsi di coinvolgimento, o in caso di elezioni politiche, o in caso di ricerca del consenso su scelte già attuate nei loro fondamenti. In questi casi le pratiche di partecipazione non responsabilizzano gli abitanti, ma anzi risultano strumentali e dannose poiché tendono a ottenere un consenso passivo. Divengono pratiche di raggiro, generano sfiducia popolare nell’apparato politico-amministrativo, se non dissuasione nel coinvolgimento e nell’impegno personale.
Perché le pratiche di partecipazione siano efficaci è necessario che le società locali siano coinvolte in un processo ampio, incrementale, di formazione di una coscienza culturale e tecnica, che siano partecipi di un dibattito tematico, aperto e non orientato. Funzionano se le popolazioni sono abituate a forme di democrazia diretta, come avviene ad esempio in Val di Susa. In questi casi gli abitanti sono abituati a decidere insieme, il che li rende direttamente responsabili degli interventi che si progettano e si realizzano sul territorio.
Partecipare significa autogoverno, progettualità sociale, corresponsabilità nelle scelte sulla città, coappartenenza ai luoghi di vita, e protagonismo collettivo non privo di conflittualità. Altrimenti partecipare significa solo imbonimento.
Ilaria Agostini ed Enzo Scandurra
Ilaria Agostini Enzo Scandurra
Ultimi post di Ilaria Agostini Enzo Scandurra (vedi tutti)
- Se la partecipazione è solo una pratica di imbonimento - 15 Giugno 2021







Ilaria, a Firenze si assiste sempre a gruppi di intellettuali l’un contro l’altro armati. Oppure a una cittadinanza che, se non le viene calpestato l’orticello, si disinteressa della cosa pubblica. In questo momento in cui Idra si dà da fare in modo molto definito e profondo, raggruppando personalità nel mondo della storia, della storia dell’Arte, dello studio del territorio etc, ti pare il caso di dire che questo lavoro non serve a niente? Sarebbe astuto ingrossare le file di un’azione molto studiata, che almeno dichiara che i neoliberisti che ci governano usano parole come PARTECIPAZIONE, stravolgendone il significato. Non solo lo dice, ma anche lo dimostra.
Grazie cara Lucia. Una riflessione su come potrebbe funzionare la partecipazione se ci fosse la volontà politica di farla funzionare, mi pare possa dare linfa all’azione di chi legittimamente richiede di prendere parte alle scelte. Nel prossimo numero, mercoledì 30 giugno, escono le considerazioni di Rossano Pazzagli, professore di storia all’università, che si aggiunge a questo filone di ragionamenti, nello spirito critico che caratterizza la nostra rivista.
Ilaria