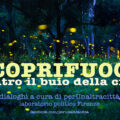Quasi undici anni fa, il Consiglio dei Ministri nominò il primo di una lunga serie di commissari ad acta della sanità della regione Calabria per il rientro dal debito: si trattava dell’allora presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, l’énfant prodige del MSI che, nel 2018, fu condannato in Cassazione a una pena di 4 anni e 7 mesi per falso in atto pubblico.
Dal 2010 ad oggi non si contano i commissari che – nonostante i pesanti tagli agli investimenti, i mancati turn over del personale sanitario, il blocco delle assunzioni, la chiusura di piccoli e medi ospedali che fungevano da presidi territoriali – hanno portato il disavanzo a cifre da capogiro. Oltre ai 160milioni di debiti certificati dai tavoli interministeriali alla fine dello scorso anno, ci sono i debiti verso i fornitori e i buchi di bilancio delle varie aziende ospedaliere e sanitarie, che ammontano a quasi due miliardi di euro. Basti pensare già all’azienda sanitaria di Reggio Calabria – la più indebitata d’Europa, sciolta nel 2019 per infiltrazioni della criminalità organizzata – di cui non possediamo i bilanci degli ultimi otto anni.

Nel parere con cui nel 2018 la prefettura di Reggio Calabria chiedeva al governo di sciogliere l’azienda sanitaria provinciale per infiltrazioni della criminalità organizzata, si legge che la ‘ndrangheta fa affari soprattutto grazie agli «acquisti e alla fornitura di beni e servizi a mezzo di reiterate proroghe, rinnovi ed acquisti fiduciari […] a favore di imprenditori contigui alle consorterie criminali». La ‘ndrangheta pilota appalti e forniture verso imprenditori fidati grazie alla «presenza di soggetti che hanno messo a disposizione delle cosche di riferimento il ruolo istituzionale ricoperto, in un’ottica di totale asservimento della funzione pubblica».
Il resto è cronaca di quest’ultimo anno e mezzo di pandemia, l’ennesima mancata occasione per risollevare le sorti della sanità locale, ma che forse è stata utile almeno per accendere i riflettori su una delle tante piaghe della Repubblica Italiana. In Calabria ancora si muore nelle ambulanze in attesa davanti al pronto soccorso. E non solo di covid, purtroppo. Manca il personale, quello in essere è stremato da turni massacranti, mancano i macchinari, gli approvvigionamenti di materiale necessario sono discontinui e carenti. Risultano più difficoltosi che altrove il contenimento e il tracciamento del virus – 560 i positivi nell’ultima settimana -, la campagna vaccinale procede a rilento, obbligando anche anziani e soggetti fragili ad affrontare spostamenti di centinaia di chilometri per la prima dose di vaccino.

Nelle condizioni in cui si trova il sistema sanitario regionale bastano poche decine di ricoverati per Covid per provocare un collasso del sistema ampiamente prevedibile. Di contro, in tutta la regione, si assiste da anni a un fiorire di studi di medici specializzati che lavorano stabilmente in strutture pubbliche o private nelle regioni settentrionali “all’avanguardia”. Quasi obbligati dalle infinite liste d’attesa dei pochi ospedali rimasti, i malati calabresi che possono permetterselo sono costretti a sborsare cifre da visita specialistica – su cui chiaramente i medici, se fatturano, pagano le tasse alla regione di riferimento – e, nei casi più gravi, a farsi operare o ricoverare negli ospedali dove quei medici sono impiegati. Col risultato che, ogni anno, la Calabria è costretta a rimborsare la prestazione alla regione “ospitante”, aumentando i propri debiti e vedendo partire il 20,5% della sua popolazione per “turismo sanitario”. Nel solo 2018, la Calabria ha dovuto versare per questa ragione 319 milioni di euro. Un legame a doppio filo tra politica, massoneria deviata e mafie, sottolineato anche dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Gino Strada, che fa continui appelli al ritorno alla sanità pubblica e ad una sua gestione statale e condivisa, l’unico modo per spazzar via gli affari fatti sulla pelle dei cittadini. Dopo mesi di pandemia, è chiaro a tutti che un sistema sanitario a scartamento ridotto e derubato dal business delle strutture private a scapito della medicina di territorio non tutela il diritto alla salute e alle cure gratuite sancito dalla nostra Costituzione. E questo vale per la Calabria ultima della classe, ma anche per le regioni che vantavano eccellenze e ora fanno la conta delle migliaia di morti.
In undici anni, il deficit sanitario calabrese si è ridotto di soli 6,291 milioni di euro circa (passando da 104,304 milioni al 31 dicembre 2009 a 98,013 milioni al 31 dicembre 2019). Undici anni (qui un po’ di cifre nel dettaglio) in cui, però, i cittadini calabresi hanno continuato a finanziarie copiosamente la sanità, non ricevendo in cambio neanche il minimo sindacale.
Per rendersi conto della profonda ramificazione e degli ingenti interessi che investono la sanità della regione, basti pensare che il più noto omicidio compiuto dalla ‘ndrangheta negli ultimi vent’anni è avvenuto proprio nell’ambiente sanitario. Il 16 ottobre 2005, due infermieri legati al clan Cordì di Locri, Alessandro e Giuseppe Marcianò, uccisero con cinque colpi di pistola l’allora vicepresidente del consiglio regionale Francesco Fortugno, mentre stava votando alle primarie del centrosinistra. I Marcianò cercavano probabilmente di proteggere gli affari del proprio clan nelle cliniche locali (a tal proposito, vedi l’inchiesta “Onorata Sanità” e il libro Codice Rosso di Badolati-Sabato.
In quest’ultimo anno, la questione della sanità calabrese è tornata d’attualità anche nelle aule del Parlamento. Il deputato Francesco Sapia (Alternativa c’è, ex-5stelle) ha presentato una proposta di legge per azzerare i disavanzi sanitari della Calabria e cancellare il debito storico della sanità regionale, arginando il fenomeno dell’emigrazione sanitaria.

E non rimangono inermi neanche il mondo dell’associazionismo e i cittadini che, al contrario di come spesso vengono dipinti da parte della stampa e dell’opinione pubblica, in questi giorni hanno messo in campo varie azioni. Dalla raccolta firme attiva in tante città calabresi alla storica occupazione delle sedi dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda Sanitaria di Cosenza ad opera del collettivo FEM.IN. Cosentine in lotta, per chiedere la riaperture delle strutture chiuse – sono 18 quelle pronte o quasi pronte, ma inutilizzate a causa dei tagli – e le assunzioni di personale sanitario a tempo indeterminato, per una sanità accessibile e di qualità per tutti. Jessica, volto ormai riconoscibile delle giovani e determinate FEM.IN., è una delle tante attiviste che ha partecipato ieri al presidio organizzato davanti al Ministero della Salute a Roma, dove sono state sottoposte ai segretari del ministro Speranza e di Pierpaolo Sileri le istanze della comunità calabrese: poche e insoddisfacenti le soluzioni offerte, che includono l’affiancamento di 37 persone alla struttura commissariale e i finanziamenti previsti dal Decreto Calabria, 60 milioni per il 2021-22 e altri 60 per il 2023. Nessun accenno, quindi, al piano di assunzioni e alle riaperture delle strutture chiuse.
Accanto a loro in questa enorme battaglia c’è tutta la Cosenza solidale, tra cui semplici cittadine e cittadini, l’associazione La Terra di Piero, i collettivi studenteschi universitari e il Movimento Le Lampare, che da novembre è attivo nel presidio permanente dell’ospedale “Vittorio Cosentino” di Cariati – due strutture di 13mila mq complessivi, nuove ma usate solo in minima parte per uffici e piccole pratiche ambulatoriali. Mimmo Formaro, uno degli attivisti che hanno dato vita all’occupazione, racconta che, anche lì, la cittadinanza c’è e lotta da anni per la riapertura di un presidio che coprirebbe un territorio molto esteso, che comprende il basso ionio cosentino, l’alto crotonese e la Sila Greca. Un bacino di 100mila abitanti durante l’inverno, che triplica in estate.
Undici anni fa, l’ospedale di Cariati fu una delle 18 strutture colpite dai tagli lineari dell’allora commissario Scopelliti e, attualmente, è soltanto un “punto di smistamento” dei malati, che vengono indirizzati verso altre sedi, anche a centinaia di chilometri. Ma, come spesso accade, è stato il lavoro di sinergia dal basso a far diventare la lotta riconosciuta e riconoscibile anche fuori dai confini di una delle regioni più povere d’Europa e a trasformare questi presidi in vere e proprie piazze di confronto tra le varie comunità che vivono il territorio.
Ieri si è andati avanti, con un nuovo presidio vicino all’ospedale cosentino, perché la mobilitazione non può e non deve fermarsi.
Gabriella Falcone
Ultimi post di Gabriella Falcone (vedi tutti)
- Pepe Mujica, il riposo del guerriero - 26 Maggio 2025
- La Calabria in lotta per la sanità pubblica - 18 Aprile 2021
- Calabria greca. Abbandono e “restanza” - 23 Febbraio 2021