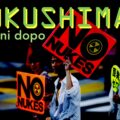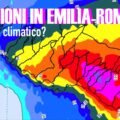Fin dal suo avvio, la cosiddetta transizione ecologica si fonda soprattutto sulla sua declinazione energetica. Proprio la transizione energetica, tuttavia, oltre a subire continue battute d’arresto, presenta aspetti profondamente contraddittori rispetto allo scopo di affrontare realmente la grave questione ambientale in cui si dibattono le nostre società.
L’Unione Europea e le altre istituzioni che la promuovono indicano nel passaggio dall’uso prevalente di energie fossili all’impiego crescente di energie rinnovabili un processo determinante per raggiungere la “sostenibilità” dello sviluppo economico. Quest’impostazione tende a non considerare che anche gli impianti per la produzione di energia rinnovabile richiedono risorse minerali non rinnovabili, spesso dal fortissimo impatto ambientale come le terre rare, talvolta associate a materie radioattive; oppure – nel caso di impianti energetici che utilizzano biomassa – tale impostazione non considera che la produzione industriale della biomassa stessa generalmente comporta deforestazione e distruzione di ecosistemi, paesaggi, biodiversità, economie locali, oltre che uso di prodotti chimici altamente inquinanti e consumi idrici ed energetici enormi.
 In tal modo le istituzioni promotrici della transizione energetica tendono di fatto a sottovalutare che la sostenibilità dello sviluppo economico non è pregiudicata solo dall’uso di energie fossili ma soprattutto dalla mancanza di limiti che nella nostra società caratterizza la crescita, il moltiplicarsi e l’intensificarsi di attività di produzione, consumo, circolazione, commercializzazione e comunicazione di ogni tipo.
In tal modo le istituzioni promotrici della transizione energetica tendono di fatto a sottovalutare che la sostenibilità dello sviluppo economico non è pregiudicata solo dall’uso di energie fossili ma soprattutto dalla mancanza di limiti che nella nostra società caratterizza la crescita, il moltiplicarsi e l’intensificarsi di attività di produzione, consumo, circolazione, commercializzazione e comunicazione di ogni tipo.
Dall’elusione sostanziale di questo enorme problema consegue – fra l’altro – che la diffusione scriteriata, per terra e per mare, di impianti fotovoltaici ed eolici venga spesso assunta come una necessità ineludibile poiché la nuova offerta di energia che occorre garantire non può che adeguarsi a una domanda destinata a crescere indefinitamente.
Non a caso, perciò in Italia un gran numero di territori, aree agricole, contesti paesaggistici e naturalistici sono già stati e continuano ad essere invasi e compromessi da una vasta presenza di parchi fotovoltaici ed eolici, mentre al tempo stesso la quantità di richieste di autorizzazione di nuove installazioni non cessa di crescere. Fra i molti esempi possibili basti citare quello delle migliaia di ulivi espiantati in Puglia in aree rinomate per la qualità della produzione olearia (e mai colpite dal batterio Xylella), per far posto a gigantesche distese di pannelli fotovoltaici; esempio emblematico di una tendenza giustamente sintetizzata dai cittadini che la disapprovano con formule come: «in nome del green si sacrifica il verde» o: «per salvare l’ambiente si distrugge l’ambiente».
Quest’inquietante scenario, d’altra parte, è reso decisamente allarmante dalla prospettiva che si va delineando con la definizione da parte degli enti regionali delle cosiddette “aree idonee” ad ospitare in un futuro prossimo nuovi impianti fotovoltaici ed eolici. A parte qualche incerta attenzione a ridurre il rischio che ne derivi la compromissione del patrimonio ecosistemico e paesaggistico, in generale l’urgenza di aumentare l’offerta di energia da fonti rinnovabili sembra spingere le istituzioni ad assecondare le mire speculative dei grandi investitori del settore rendendo possibile la diffusione di impianti anche in contesti caratterizzati da specificità irrinunciabili per gli equilibri eco-antropici dei territori.
Si tratta, in realtà, di uno scenario che ci dice ancora poco del quadro mistificante e inaccettabile in cui si svolge la cosiddetta transizione energetica, un quadro nel quale l’uso stesso delle energie non rinnovabili è tutt’altro che destinato ad arrestarsi, come dimostrano alcuni fatti evidenti su cui è opportuno soffermarsi con precisione.
In fase di avvio della transizione energetica, l’Unione Europea ha inopinatamente stabilito che sia il gas metano sia l’energia nucleare possono essere considerati “sostenibili” per la minore quantità di anidride carbonica (CO2) emessa dal metano rispetto ad altre energie fossili, e per il presunto carattere “pulito” dell’energia nucleare dovuto alla sua mancanza di emissioni dello stesso tipo. Una decisione che si spiega considerando che l’Unione Europea assume come criterio principale di valutazione dell’efficacia ecologica della transizione la semplice “decarbonizzazione” e come suo obiettivo primario la generica “neutralità climatica”. In tal modo l’Unione contribuisce al surrettizio affermarsi dell’idea, fuorviante ma ormai invalsa, che la crisi ecologica sia riducibile al cambiamento climatico e che la sua causa principale sia l’emissione di CO2; per cui l’insostenibilità complessiva del modello dominante di sviluppo, la profondità e la dimensione della crisi ecologica, la molteplicità dei suoi fattori e dei suoi aspetti vengono regolarmente ignorate o sottovalutate a tutto vantaggio della declinazione meramente energetica delle politiche ecologiche ritenute prioritarie.
Resta comunque che l’uso del metano e delle altre energie fossili non è affatto destinato a rimanere “temporaneo”. Lo dimostra – fra l’altro – l’inarrestabile attivismo dei colossi mondiali dell’estrazione e della fornitura di queste risorse energetiche: basti pensare alla scoperta recente del più grande giacimento di gas metano del Mediterraneo, al rilancio delle devastanti tecniche estrattive basate sul fracking, all’aggressività con la quale gli USA tendono ad aumentare le proprie esportazioni di gas e idrocarburi in Europa, alla competizione che tale aggressività è destinata a innescare con gli altri paesi produttori, al fatto che in Italia è stato portato a termine – contro la volontà di gran parte delle comunità e delle istituzioni locali – il Gasdotto Trans-Adriatico (TAP) e che attualmente è in fase di realizzazione un nuovo gasdotto lungo l’appennino centro-meridionale.
Analogamente, il “tramonto” dell’energia nucleare, che molti continuano ingenuamente a dare per certo, oggi non solo è rinviato sine die dalle politiche europee, ma è decisamente contraddetto dal proliferare di strategie politico-economiche tendenti al massiccio rilancio di quest’energia mediante nuove tipologie di reattori. Malgrado i disastri del XX secolo e l’insuperata questione della gestione millenaria delle scorie, l’energia nucleare viene nuovamente presentata come destinata a divenire “sicura” e persino “inesauribile”, salvo dover scoprire un giorno la catastrofica infondatezza di questa promessa. Ad essere “sicuro”, invece, è che quest’energia oggi viene candidata a rispondere – in aggiunta e persino in alternativa alle energie rinnovabili – alla crescita illimitata dei fabbisogni energetici dello sviluppo fine a sé stesso al quale nessuna delle classi economiche e politiche dominanti sembra disposta a rinunciare. Non a caso, infatti, nel nostro paese Enel, Ansaldo Energia e Leonardo recentemente hanno costituito la società Nuclitalia, con il beneplacito del governo in carica, allo scopo di individuare “reattori nucleari di nuova generazione” da installare sul territorio nazionale.
È questo insieme di circostanze che la Società dei territorialisti e delle territorialiste intende denunciare con forza ponendo in luce alcune questioni sulle quali non è possibile transigere.
- I paesaggi, i patrimoni agricoli, gli ecosistemi terrestri e marini dei luoghi messi a disposizione dei grandi investitori dell’energia fotovoltaica ed eolica sono beni comuni, tutelati dalla Costituzione, ai quali non si può rinunciare acriticamente se non accettando l’idea che gli approcci tecnocratici e speculativi alla transizione energetica possano davvero garantire la sostenibilità di un sistema produttivo, economico e sociale sempre più orientato ad accrescere i suoi impatti su ambiente, territori, risorse naturali e specificità eco-antropiche dei
- L’esigenza di adottare le energie rinnovabili può e deve essere soddisfatta innanzitutto: a) utilizzando aree industriali dismesse, coperture di insediamenti produttivi e commerciali, di parcheggi ed edifici pubblici e privati; b) attraverso la produzione di piccola dimensione, integrata alle strutture esistenti e finalizzata prioritariamente a soddisfare il fabbisogno locale; c) promuovendo il risparmio energetico e il coinvolgimento degli abitanti dei territori mediante la creazione di comunità energetiche e attivando relazioni virtuose e dirette fra produzione e consumi energetici. Di conseguenza la conversione – più che la “transizione” – energetica ed ecologica deve perseguire primariamente la riduzione progressiva dei fabbisogni di energia.
- La transizione energetica, come è venuta configurandosi, è ormai una prospettiva che di fatto asseconda o non contrasta effettivamente la riverniciatura green della speculazione economica e il rilancio dell’uso di energie non rinnovabili, garantendo così il perpetuarsi di un modello di sviluppo insostenibile, indifferente alle specificità ambientali dei luoghi di vita delle comunità umane e non umane.
Con questo documento, dunque, la Società dei territorialisti e delle territorialiste vuole sollecitare le forze politiche, culturali e sociali sensibili all’aggravarsi della crisi ambientale, a impegnarsi attivamente per il superamento di questo stato di cose.
Essa esprime il proprio sostegno ai movimenti e alle organizzazioni di cittadini che difendono i territori, i paesaggi e l’ambiente dagli effetti devastanti dell’installazione di nuovi impianti di energia rinnovabile o non rinnovabile e propongono modelli alternativi di conversione energetica ed ecologica basandosi innanzitutto sulla propria condizione di abitanti che si prendono cura degli ecosistemi e dei luoghi in cui vivono.
Questa presa di posizione, perciò, vuole essere anche il primo passo di un confronto ampio e approfondito sul piano teorico, pratico e progettuale, che coinvolga soggetti, aggregazioni sociali e istituzioni portatrici di esperienze realmente tendenti a interpretare la conversione ecologica e la questione energetica come necessità di rigenerare la ricchezza ecosistemica e storico-antropica dei territori, dei luoghi, delle città, degli ambienti.
Società dei territorialisti/e
* L'”imbroglio” che si intende porre in luce qui appare come una versione aggiornata di quello denunciato già negli anni Settanta da uno dei pionieri dell’ecologismo critico quale è stato Dario Paccino, nel suo L’imbroglio ecologico. L’ideologia della natura (1972).