Il ruolo dei fondi di investimento (o fondi di fondi di investimento, per la maggioranza USA) dietro operazioni speculative come le cosiddette rigenerazioni urbane o il business degli affitti brevi o dietro un caso come quello GKN è già stato affrontato sulle pagine de La Città Invisibile. Probabile quindi che abbiate sentito almeno citare i due scritti complementari di Alessandro Volpi I padroni del mondo (Laterza, giugno 2024) e Nelle mani dei fondi (Altreconomia, novembre 2024).
I fondi si sono espansi (in Europa soprattutto a partire dal 2010) non con soldi loro, è necessario ricordarlo, ma usando risparmio affidato in gestione sia da investitori di grandi dimensioni, sia da milioni di piccoli risparmiatori.
Il pianeta è percorso da queste masse di denaro gestito in caccia di investimenti redditizi che influiscono sui prezzi anche dei beni essenziali, sul modo di gestire le industrie e i servizi, sulla gestione dei debiti pubblici, e alimentano il gonfiarsi continuo di valori borsistici senza sufficiente base reale nell’economia produttiva, preparando nuove crisi future.
 Un aspetto fondamentale è che questi fondi presi nel loro insieme non si fanno la guerra, almeno non al livello molecolare della gestione degli investimenti e della caccia ai dividendi, anzi sono collegati tra loro da partecipazioni incrociate, scatole cinesi che rendono quasi impossibile ricostruire chi comanda davvero. Questo stato di cose non sopprime i conflitti all’interno del capitale, soprattutto ai massimi livelli di scelte geopolitiche vere e proprie. Secondo Volpi per esempio lo scontro parossistico tra democratici e repubblicani-trumpiani del 2024, e anche attuale, si può spiegare anche con il conflitto tra diversi settori finanziari USA. Peraltro sia Trump sia la finanza antitrumpiana formano un unico coro patriottico quando si tratta di chiedere che l’UE non tassi le big tech USA (Amazon, Google ecc.) che per l’appunto sono in buona parte proprietà dei fondi americani, e i governi europei fanno buon viso a cattivo gioco sperando così di mantenere un buon rating per il proprio debito pubblico.
Un aspetto fondamentale è che questi fondi presi nel loro insieme non si fanno la guerra, almeno non al livello molecolare della gestione degli investimenti e della caccia ai dividendi, anzi sono collegati tra loro da partecipazioni incrociate, scatole cinesi che rendono quasi impossibile ricostruire chi comanda davvero. Questo stato di cose non sopprime i conflitti all’interno del capitale, soprattutto ai massimi livelli di scelte geopolitiche vere e proprie. Secondo Volpi per esempio lo scontro parossistico tra democratici e repubblicani-trumpiani del 2024, e anche attuale, si può spiegare anche con il conflitto tra diversi settori finanziari USA. Peraltro sia Trump sia la finanza antitrumpiana formano un unico coro patriottico quando si tratta di chiedere che l’UE non tassi le big tech USA (Amazon, Google ecc.) che per l’appunto sono in buona parte proprietà dei fondi americani, e i governi europei fanno buon viso a cattivo gioco sperando così di mantenere un buon rating per il proprio debito pubblico.
Già, perché i fondi sono presenti anche nel capitale delle agenzie di rating, che valutano entità di cui gli stessi fondi sono compartecipi, compresi i debiti pubblici degli Stati, ed è impossibile non constatare l’esistenza di conflitti di interessi enormi, ma stranamente molto poco rilevati dalla stampa economica dominante.
Oltre al business delle assicurazioni sanitarie e previdenziali, per i fondi un ottimo modo per realizzare profitti senza rischio sono le partecipazioni alle società, spesso a a capitale misto pubblico-privato, che gestiscono servizi pubblici, reti energetiche e di comunicazione, infrastrutture. Si tratta di monopoli naturali artificialmente trasformati in pseudomercati grazie alle privatizzazioni neoliberiste e dove il pagamento delle bollette e dei pedaggi da parte degli utenti garantisce un afflusso stabile di denaro. E questo ci conduce al punto di interesse che propongo e che ha molto a che fare con la domanda: che cosa significa attrezzarsi per comprendere la crisi ecologica, la crisi sociale e la questione energetica che formano un unico groviglio.
Dobbiamo tenere conto della finanza per capire qualche cosa di più di come il capitale affronta crisi energetica, crisi ecologica, transizione energetica, transizione ecologica, e usa quindi anche il green deal nelle sue varie incarnazioni, comunque riconducibili a una sorta di “keynesismo verde” cioè al cosiddetto “sviluppo sostenibile” secondo lo schema che sta alla base dell’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change).
Questo mio articolo vuole essere solo l’apertura di un lavoro di inchiesta in cui è impegnata la redazione de La Città Invisibile. Allineo qui in modo grezzo alcuni elementi su cui occorre approfondire la conoscenza.
I fondi di investimento, le banche e la finanza in generale sono presenti sia nel capitale “fossile” (e in particolare nei giganti petroliferi privati a capitalizzazione in parte diffusa come Exxon o Total) sia nel capitale “verde”. Del resto i grandi gruppi fossili si stanno tutti più o meno rideclinando come società sostenibili: per esempio Total ha cambiato il suo nome in TotalEnergies per sottolineare una missione aziendale ormai conforme ai dettati dell’IPCC: “TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni al centro dei suoi progetti e delle sue operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni”.
Si parla spesso dello scandalo degli incentivi al fossile, ma è forse nel settore “verde” che ci sono particolari possibilità di guadagno incentivato, è lì che le normative vigenti sia in UE che in Usa che altrove hanno creato ai fini della transizione energetica nuove forme di capitalismo assistito e sostenuto dalla politica, con finanziamenti diretti o con la tolleranza legale verso le varie forme di “tosatura” degli utenti.
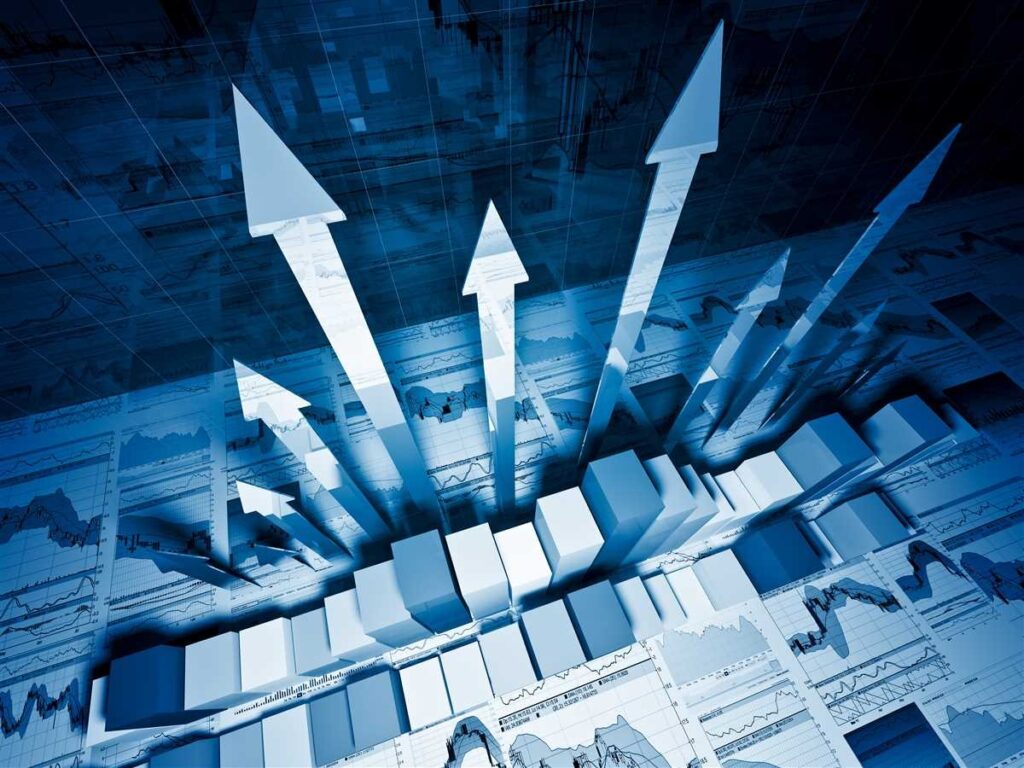 In Italia i fondi sono entrati in questi anni nelle società pubbliche del settore energia e delle reti e nelle multiutility con la loro logica, che è quella di cercare rendimenti finanziari sicuri a breve termine e quindi piegare a questa esigenza anche i principi di erogazione dei servizi. Lo stesso “cartello” condiziona in questo modo l’intera filiera dell’energia compresa quella delle rinnovabili. Tutto il settore dell’energia è stato caratterizzato dal 2023 da extraprofitti collegati a un aumento delle bollette delle luce e del gas nel mercato privatizzato.
In Italia i fondi sono entrati in questi anni nelle società pubbliche del settore energia e delle reti e nelle multiutility con la loro logica, che è quella di cercare rendimenti finanziari sicuri a breve termine e quindi piegare a questa esigenza anche i principi di erogazione dei servizi. Lo stesso “cartello” condiziona in questo modo l’intera filiera dell’energia compresa quella delle rinnovabili. Tutto il settore dell’energia è stato caratterizzato dal 2023 da extraprofitti collegati a un aumento delle bollette delle luce e del gas nel mercato privatizzato.
Con l’esaurimento della fase dei finanziamenti diretti a pioggia, il maggior incentivo reale ai produttori di energia da fonti rinnovabili (che di solito del resto producono contemporaneamente con il fossile, in Italia soprattutto metano) consiste in un dispositivo poco noto al grande pubblico ma potente, l’extraprofitto garantito dal sistema del “prezzo marginale”. In ognuno dei momenti della giornata in cui l’incontro della domanda e dell’offerta determina il prezzo di borsa (cioè all’ingrosso) dell’energia elettrica, l’ultimo impianto che entra in funzione fissa con il suo “prezzo marginale” anche il prezzo dell’energia prodotta da tutti gli impianti entrati in funzione prima, e l’ultimo impianto a entrare in servizio nel 62% dei casi in Italia (fonte: Terna) risulta al momento essere quello a gas, per cui la corrente prodotta con le rinnovabili a basso costo viene pagata nel 62% dei casi con il prezzo di quella prodotta al massimo costo.
Nel 2023 il governo Italiano aveva, molto sommessamente, richiesto un disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica prodotto con le rinnovabili da quello prodotto con il gas, il che avrebbe fatto abbassare subito le bollette (dove il prezzo della materia prima energetica sarebbe stato determinato così da una media tra due prezzi all’ingrosso distinti), ma la cosa a livello UE è stata bloccata sia dall’opposizione degli Stati nordici, sia da quello più sotterraneo del mondo della “finanza verde”. Da notare che proprio il vertice di Confindustria richiede il disaccoppiamento, e qui c’è evidentemente un conflitto interno allo stesso mondo industriale tra produttori di energia e utenti di energia.
In Italia poi l’ultimo traguardo della privatizzazione energetica a vantaggio dei produttori e dei parassitari rivenditori al dettaglio è stata (al coro di: ce lo ha imposto l’Europa!) la cessazione definitiva di quello che restava del settore di maggior tutela per luce e gas, il che ha determinato un prevedibile salto in su dei prezzi.
Esiste poi tutto l’opaco settore delle compravendite di materia prima (gas) e di energia con contratti di lungo termine extraborsistici su cui è molto difficile anche fare inchiesta. Nella loro narrazione pubblicitaria i grandi gruppi produttori di energia (Enel, Eni) e le multiutility si rivolgono al potenziale nuovo cliente trattandolo come prosumer, cioè dicendogli “sappiamo che sei un individuo attivo e progressivo, interessato alla transizione, e che parteciperai mediante l’autoproduzione, l’accumulo e la regolazione”; immagine totalmente sconnessa dalla realtà del piccolo utente e della piccola azienda, ma che permette di sostenere la narrazione della sostenibilità aziendale e soprattutto di affogare le tariffe in un mare di offerte di contorno e di forme contrattuali impossibili da confrontare e quindi da valutare, tanto più che ciò avviene dentro un contesto di bombardamenti molesti di offerte contrattuali fatte da strani procacciatori, dato che le autorità di regolazione non si sognano nemmeno di abolire la possibilità di attivare contratti per via telefonica o via mail.
Le multiutility (a parte quelle come Sorgenia che è da sempre un gruppo interamente privato e di proprietà dei fondi di investimento) da A2A a Iren a Hera ad Acea sono (quasi) tutte quotate in borsa e partecipate dai grandi fondi finanziari e c’è un piccolo listino di borsa loro dedicato dove sono affiancate a Italgas, Enel e Terna (FTSE Italia All-Share Utilities Index), che comprende oltre alle multiutility i gestori delle grandi reti e infrastrutture direttamente dipendenti dal MEF cioè lo Stato italiano.
Sugli investimenti diretti statali in generale, cioè non solo nelle utilities, si veda questo recente rapporto parlamentare: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/CP1024S.pdf?_1744010487004. Tra le 39 grandi società capofila cioè partecipate del MEF di primo livello schedate in questo rapporto sono ben note Enel, Eni, Leonardo, Poste, Cassa depositi e Prestiti, Ferrovie Italiane, ma si tratta sempre di gruppi complessi per cui nel secondo livello si possono trovare imprese sempre enormi come Fincantieri, Saipem, Anas, Telespazio, Italgas, e addirittura Terna. Quest’ultima per esempio (controllata da Cassa Depositi e Prestiti – controllata dal MEF- con il 30 % del capitale ma avendo ben il 56% partecipazione di investitori istituzionali cioè fondi e banche) gestisce la rete “pubblica” ad alta tensione di cui i produttori si servono per veicolare la corrente e gestisce gli investimenti miliardari (23 miliardi il piano annunciato da poco) che servono a ristrutturare questa rete in modo da poter accogliere le immissioni dai nuovi tipi di fonte energetica, compreso un possibile futuro contributo nucleare come ha dichiarato l’amministratrice delegata il 15 marzo 2025. E qui ci sarebbe da indagare in che misura questo gigantesco investimento corrisponda a un servizio (fatto con il denaro ricavato dalle nostre bollette) a favore della società in generale e all’ambiente, e in che misura vada invece a favore degli interessi privati dei produttori di energia elettrica e ai loro investitori finanziari. Per esempio tutte le pale eoliche piantate in Puglia e Basilicata in base ai calcoli di guadagno dei privati richiedono poi la costruzione di una dorsale adriatica “pubblica” per veicolare la corrente al Nord industriale.
La parte pubblica riscuote la sua parte di dividendi di queste società a capitale misto, ma questi soldi vanno ad alleviare in modo minimo e contingente l’indebitamento pubblico, sia quello dello Stato sia quello dei Comuni nel caso delle multiutility, mentre non viene esercitata attraverso la partecipazione azionaria alcuna guida strategica, almeno non a favore della collettività. La parte pubblica azionista insomma si comporta secondo la stessa logica puramente finanziaria dei fondi.
Prendendo l’esempio di A2A, dove la proprietà maggioritaria è dei due Comuni fondatori di Milano e di Brescia, gli investitori istituzionali (fondi d’investimento e altre istituzioni finanziarie) ne detengono il 30,8% del capitale sociale. A2A ci tiene significativamente a sottolineare che circa il 35% delle azioni detenute dagli investitori istituzionali è “riconducibile a fondi che integrano l’analisi ESG nei propri processi di investimento”, qualunque cosa questo significhi. A2A ha annunciato risultati eccellenti per il 2024, ciò nonostante dopo la relazione di risultato il titolo ha perso qualcosa in Borsa, segno che gli investitori si aspettano da un gruppo come questo risultati finanziari e dividendi ancora più alti.
E del resto è proprio quello che promette enfaticamente il direttore generale, facendo del pagamento di dividendi crescenti di anno in anno una dichiarata strategia aziendale, accanto a quella della “transizione energetica e verso l’economia circolare”. Il quale direttore generale secondo il sito di A2A percepisce 723.000 euro di compenso (più 80.000 in quanto consigliere). Questo dei compensi dei top manager è un punto chiave per capire che cosa è una multiutility a capitale misto pubblico-privato, perché ovviamente sono compensi enormemente superiori a quelli dei dirigenti delle vecchie società partecipate e anche degli stesso Sindaci dei Comuni partecipanti (e anche del Presidente della Repubblica, se è per questo); il limite legale posto agli stipendi pubblici viene bypassato grazie alla formula societaria di S.p.A.
Da questi pochi materiali affastellati per una futura inchiesta si deduce che se dal punto di vista della lotta alle emissioni climalteranti si può parlare di un’unica questione energetico-ambientale, questa non può essere analizzata né affrontata come un fatto socialmente neutro e interclassista.
La riconfigurazione del capitale contemporaneo avviene in parte approfittando della crisi ecologica, cioè in generale attraverso il cosiddetto green deal che crea nuove forme di estrazione di valore e di dominio sociale, come appropriazione del terreno ex agricolo per l’agrovoltaico, digitalizzazione e sistemi pervasivi di sorveglianza, ulteriore artificializzazione di tutti gli aspetti dell’esistenza, della superficie della Terra e dello spazio circostante, trasferimento di ricchezza dal contribuente al privato. I costi economici anche immediati del green deal vengono fatti ricadere sul lavoro dipendente e sulle piccole imprese tramite i prezzi (molto artificiali) e tramite lo Stato in quanto il settore energetico “privatizzato” tende a porsi come monopolio assistito con i nostri soldi tramite il sistema fiscale e i vari tipi di incentivi diretti e indiretti e attraverso regolazioni tecnocratiche, per noi europei pilotate in sostanza da Bruxelles e per lo più ignote al grande pubblico.
Già si annuncia la ricaduta sulle nostre bollette del costo dei futuri sistemi di accumulo e già i produttori di energia da gas stanno questuando dal governo per ottenere compensi per la tenuta “a disposizione” delle centrali necessarie a riequilibrare il sistema in caso di caduta delle fonti intermittenti..tanto per fare due esempi di ricaduta dei costi verso il basso, mentre i profitti vanno verso l’alto.
Questo capitale assistito nel suo insieme, concresciuto con lo Stato e le strutture tecnocratiche tipo UE, FMI, WTO ecc., non ha neanche un carattere “nazionale” prevalente, e neanche europeo, ma è partecipato dagli agglomerati finanziari globali, quindi in particolare dai famosi fondi di investimento, e registra nuove forme di monopolio multinazionale anche dal punto di vista industriale (vedi politica mondiale di investimenti di Enel, per fare un esempio, ma anche delle multiutility che si pongono già come monopoli in pectore di tipi internazionale attraverso le forme più classiche di esportazione dei capitali).
L’Europa come area geografica comprese quindi UK Svizzera e Norvegia è l’unica parte del mondo in cui le emissioni di CO2 si stanno riducendo, però non è chiaro quanto di questa riduzione sia da attribuire alle misure filoambientali e quanto invece all’esternalizzazione industriale e alla stagnazione economica. Per quanto riguarda i gruppi energetici operanti in UE specificamente, tutti hanno iscritto nella loro missione aziendale e nei rendiconti gli obiettivi di sostenibilità, quindi la sostituzione progressiva delle fonti fossili con quelle rinnovabili, e questo processo di sostituzione sta effettivamente andando avanti, con alcuni limiti di fondo.
Il settore della produzione di energia elettrica (che riguarda però solo circa un quinto dei consumi energetici) è quello in cui la decarbonizzazione ha fatto maggiori progressi, specie in Europa ma ciò nonostante anche in questo settore la decarbonizzazione trova dei limiti strutturali tra i quali sono da annoverare: a. la perdurante necessità di centrali a rapida accensione (quindi di solito a gas) per garantire il backup delle rinnovabili intermittenti e in generale la necessità di centrali rotanti (turbine, alternatori) di grande massa per mantenere la stabilità della frequenza delle linee di alta tensione del sistema elettrico (vedi caso del blackout spagnolo); b. gli impianti di energia rinnovabile vengono costruiti e installati facendo comunque ricorso a energia per la maggiori parte non rinnovabile; c. la concentrazione capitalistica e la concorrenza oligo- e monopolistica portano a costruire anche nel campo del fotovoltaico, dell’eolico e delle biomasse impianti sempre più giganteschi connessi alle linee di alta tensione (per es. eolico offshore) lasciando in un angolo del tutto marginale lo sviluppo dell’autoproduzione diffusa connessa alla media tensione e in particolare la produzione delle comunità energetiche, che rischiano così di restare solo un abbellimento secondario ed evanescente del sistema.
In generale la vocazione caratteristica della maggior parte dei singoli gruppi aziendali produttori di energia rimane quella di fornire energia da più fonti, sia termiche che rinnovabili, e presto forse il nucleare, il che corrisponde alla tendenza generale del sistema energetico mondiale reale (al di là delle narrazioni verdi) a utilizzare e addizionare tutte le fonti energetiche disponibili.
In questo contesto, già arduo da decifrare, occorre chiedersi che cosa rappresenti come impatto la svolta europea (cioè UE+UK) verso gli armamenti cioè verso il keynesismo militare. Rappresenta una messa in soffitta del green deal, tanto da farcelo rimpiangere pur con tutti i limiti che ha avuto? Ufficialmente no (si assisterà piuttosto a un orrido ibrido ideologico…) ma, come dimostra anche il contemporaneo rilancio del nucleare, il sistema militare-industriale è particolarmente energivoro, e si basa sia per i mezzi terrestri, sia per gli aerei e i missili su motori esclusivamente a combustione. Questi dovranno essere messi in progettazione con enormi investimenti, e di solito gli investimenti sui mezzi militari vengono ammortizzati mediante le applicazioni civili, per esempio un motore aereo nasce prima come versione militare poi viene adattato all’uso civile, di conseguenza il keynesismo militare avrà una ricaduta anche sulle filiere tecnologiche dell’intero sistema industriale e in generale richiederà applicazioni ad alta densità energetica, ben poco compatibili con le prestazioni intermittenti e non sempre programmabili delle energie rinnovabili.
Nel campo invece della tecnologia dei materiali e delle applicazioni cibernetiche è vero che le varie soluzioni sono generalmente pluriuso (controllo ambientale, smart cities, sorveglianza della popolazione, guerra). Lo dimostrano esempi come il satellite per il controllo della salute forestale lanciato di recente con il conclamato contributo tecnologico di Leonardo. E di cose del genere le oligarchie approfitteranno sempre di più per presentare la tecnologia militare come tecnologia anche filoambientale.
Paolo Chiappe
Ultimi post di Paolo Chiappe (vedi tutti)
- Giovanna Sissa e le emissioni invisibili del sistema digitale - 4 Giugno 2025
- La finanza, l’energia, la crisi ecologica - 12 Maggio 2025
- Crisi climatica: considerazioni per pensare in modo autonomo - 18 Gennaio 2025





