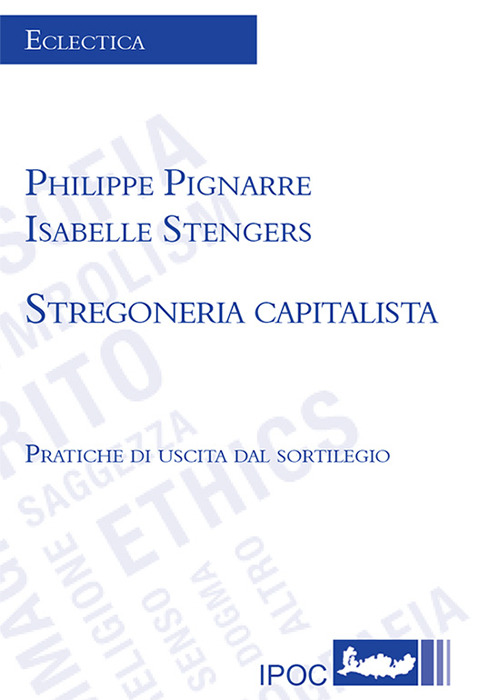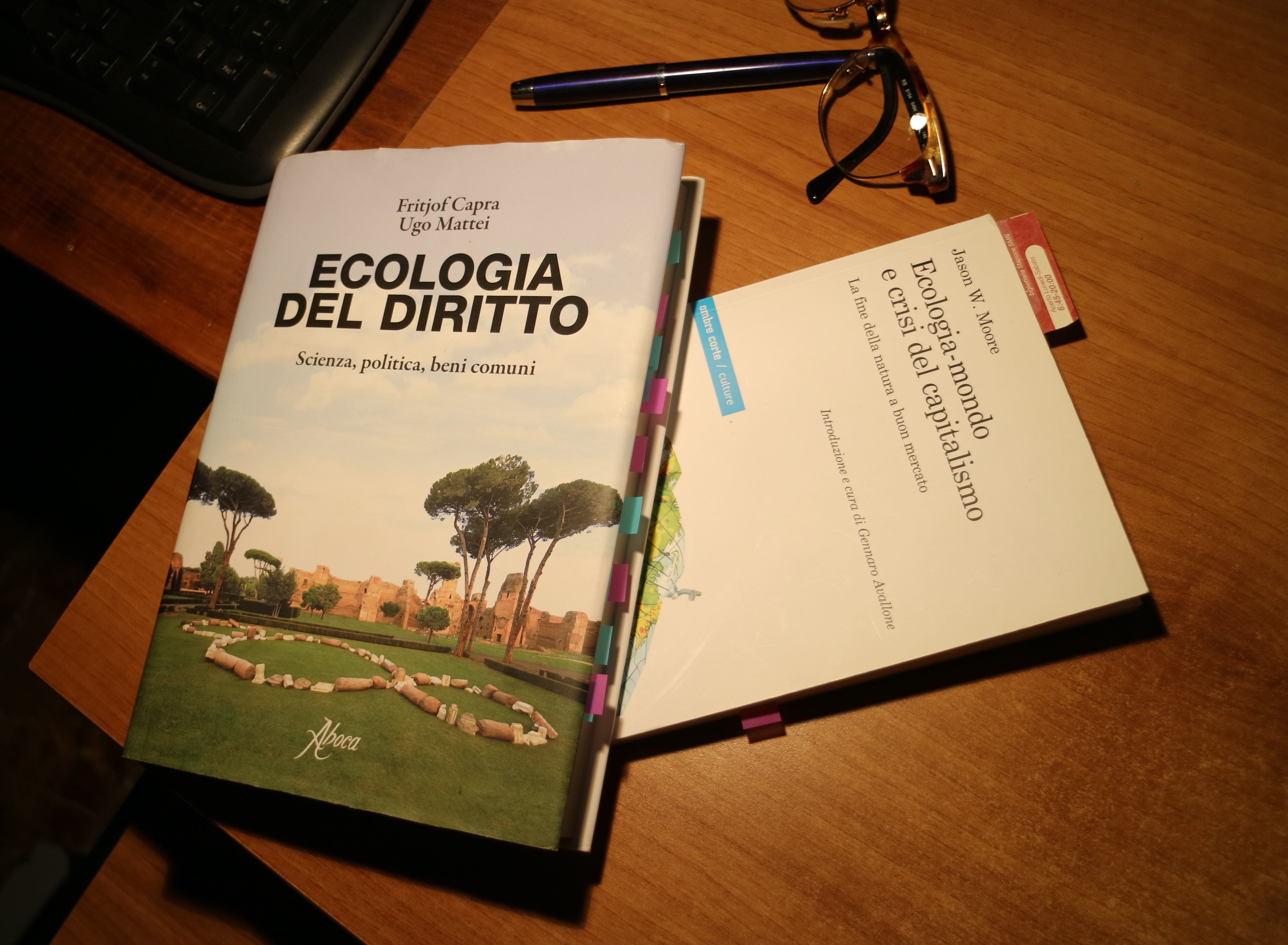Si tratta di un saggio scritto a quattro mani da Déborah Danowski (docente di filosofia a Rio de Janeiro) e Eduardo Viveiros de Castro (uno dei più innovativi antropologi contemporanei, ha insegnato a Cambridge, Chicago, Sao Paulo ed è attualmente docente di Antropologia sociale all’Università di Rio de Janeiro). È il primo di cinque saggi che pensavamo di segnalare al fine di arricchire la cassetta degli attrezzi di chi vuole esercitare una qualche forma di pensiero critico, ma anche perché i cosiddetti problemi ambientali irrompono con un’urgenza che non è più possibile dilazionare. L’insieme di questi testi, pubblicati in Italia nel 2017, rimanda al bisogno di un cambio di paradigma anche all’interno del pensiero critico rispetto alla cultura del capitale e al suo modo attuale di manifestarla e cioè al neoliberismo imperante. Un cambio di paradigma che opera su alcuni fondamenti del pensiero occidentale e della scienza ad esso connessa (quello che Derrida chiamava “fallogocentrismo” e in particolare il pensiero cartesiano). Per fare questo, non basta rovesciare i suoi presupposti (gli assiomi), ma occorre anche trovare un altro sistema della validazione (verifica delle verità) che renda conto dei nuovi problemi, del nuovo rapporto tra noi e gli altri, che smascheri anche le vecchie e nuove vesti che il capitalismo-mondo usa od ha usato per esercitare sino a qui il suo monopolio assoluto. Che ci permetta infine di pensare non ad un mondo a noi esterno, ma ad un mondo che ci comprenda.
 Una riflessioni sull’Antropocene a partire da una constatazione: l’Antropocene è l’era attuale, la nostra era, frutto di una rivoluzione già avvenuta. Gli annunci di catastrofi a venire legate per lo più al riscaldamento del pianeta a causa dei gas serra, della manomissione del ciclo dell’azoto, del consumo di acqua dolce, del consumo e del cambiamento dello sfruttamento del suolo, dell’acidificazione degli oceani (ormai oltre i limiti di sicurezza), si determinerebbero a partire da scelte e azioni imputabili alla specie umana avvenute precedentemente e che riguardano il nostro futuro; un futuro determinato da eventi che risiedono dunque principalmente nel passato e che ci obbligano ad una pressante e imperativa “necessità di una mitigazione”. (p. 29, si cita Bruno Latour).
Una riflessioni sull’Antropocene a partire da una constatazione: l’Antropocene è l’era attuale, la nostra era, frutto di una rivoluzione già avvenuta. Gli annunci di catastrofi a venire legate per lo più al riscaldamento del pianeta a causa dei gas serra, della manomissione del ciclo dell’azoto, del consumo di acqua dolce, del consumo e del cambiamento dello sfruttamento del suolo, dell’acidificazione degli oceani (ormai oltre i limiti di sicurezza), si determinerebbero a partire da scelte e azioni imputabili alla specie umana avvenute precedentemente e che riguardano il nostro futuro; un futuro determinato da eventi che risiedono dunque principalmente nel passato e che ci obbligano ad una pressante e imperativa “necessità di una mitigazione”. (p. 29, si cita Bruno Latour).
Antropocene significa che l’umanità segna il mondo con la sua presenza. Certo la specie umana, ma quale antropos? Quello individuato da quel modello sociale uscito vincente alla fine del millennio scorso, per il quale non ci sarebbe nessuna alternativa possibile ad un’organizzazione dei rapporti sociali e politici che non coincidano con la democrazia di modello occidentale basata sul libero mercato e sullo sviluppo infinito della produzione, con il conseguente e proporzionale aumento anche dei consumi energetici resi possibili dall’uso, come fonte principale, dei combustibili fossili. Si ha forse per la prima volta una determinazione del futuro che risiede tutta in un passato, dove il presente, al presente, non ci sono azioni pertinenti se non la partenza di una strategia che sia di mitigazione. L’uomo è (dis)facitore di mondo, ma non del proprio mondo (l’ambiente), ma del mondo complessivo, non soltanto di quello che lo riguarda, ma anche quello degli altri (dell’altro). Questo è un dato di fatto dalle conseguenze epistemologiche di grande portata. Sono in discussione l’opposizione natura-cultura e le articolazioni delle coppie natura-mondo, umanità-mondo, ambiente (umwelt, milieu)-mondo. Con il mondo, la sua origine e la sua fine, che diventano materiali di una apertura che fonda nuovi paradigmi a partire da nuove relazioni tra i singoli elementi. Noi e l’ambiente in un gioco che si svolge con profondità di campo così sottili, tali da obbligare una messa a fuoco selettiva, per la quale lo sfondo è ora primo piano; o dove noi vaghiamo in un ambiente senza sfondo, senza una forma stabile. In una nebbia del senso dove “l’uomo facitore di mondo” (Heidegger) viene invece modellato dall’ambiente-mondo ormai sfuggito al suo dominio.
È l’irruzione di Gaia che dà al Sistema Terra una soggettività per la quale colui che vive in un ambiente – che è ambientato – ora determina l’ambiente, ora ne è determinato in un gioco a rimpiattino tutto da seguire. Noi e il mondo; noi e la possibilità della fine del mondo.
Diventa poi difficile pensare e mantenere fisso il senso di un noi, di un noi come specie o di un noi come etnia antropocentrica prima e “occidentale poi”. Con definizioni moralmente includenti, ma che lungo i sintagmi della definizione, non fanno che escludere. E l’escluso può essere predato, messo a profitto. Si può allora mercanteggiare su tutto. «L’operaio-macchina cognitiva collegato alla rete, zombificato dalla somministrazione continua di droghe chimiche e semiotiche, produttore-consumatore d’Immateriale, eternamente indebitato» (p. 115) diviene l’interprete e l’abitatore di questo mondo o di questo post-mondo.
Ma adesso ci sono ulteriori interrogativi. Noi fuori del mondo. L’esistenza stessa di un mondo prima di noi, o ancora l’esistenza di un noi prima del modo. Concetti poco frequentati dalle parti del “nostro” mondo, ma largamente esplorati dal pensiero amerindio. (p. 57). Qui, probabilmente, il contributo di Viveiros de Castro è stato della massima importanza.
Ma, al limite, anche nel senso letterale del termine, qualcosa sui limiti del mondo, è possibile trovare contributi anche all’interno del pensiero occidentale, là dove si parla del mondo prima dell’umanità o dopo l’essere umano. Nel primo caso si tratta perlopiù di mondi edenici esistiti prima dell’umanità o prima del peccato di Adamo. «L’Eden è un mondo-senza-umani che è un mondo-per-gli-umani; gli umani sono gli ultimi ad arrivare, e sono, in questo senso, la “fine” (la finalità) del mondo» (p.64). O i mondi escatologici della fine nelle varie religioni. Ma anche degli innumerevoli mondi distopici inerenti il dopo. Dopo qualsivoglia catastrofe, dove l’uomo è rappresentato dai pochi superstiti che non incarnano più lo spirito della specie. Gli autori citano opere di letteratura e film, da Ubik di P.H. Dick, a Il mondo senza di noi di Alan Weisman e La strada di Cormac McCarthy, per passare ai film: Melancholia di Lars von Trier, 4:44 Ultimo giorno sulla terra, di Abel Ferrara e Il cavallo di Torino di Bela Tarr e Agnes Hranitzky (i torrent dei quali si trovano facilmente in rete).
Con interpretazioni per le quali emerge un tema indirettamente comune quale la separazione tra l’essere umano e il mondo dove quest’ultimo scompare «assorbito dal Soggetto e trasformato nel suo Oggetto, […] ma anche quella della scomparsa del soggetto, assorbito dal mondo e trasformato in cosa tra le cose, artefatto organico assemblato da un orologiaio cieco» (p. 75).
Ma intorno alla fine del mondo – ipotizzata, immaginata o illustrata che sia – i contributi sono innumerevoli. Ci sono anche ipotesi ottimistiche per le quali il genio tecnologico permetterà di vivere in un ambiente configurato su misura. È l’idea del superamento del sostrato biologico, quando la capacità dei calcolatori (in termini di quantità di dati e in quelli di intelligenza artificiale) avrà raggiunto e potrà quindi superare la capacità di elaborazione di tutta la materia grigia del pianeta, allora sarà possibile conservare i propri dati e trasferirli in rete per essere utilizzati, o meglio, incarnati in nuovi corpi sintetici, facendo di fatto essere la morte stessa soltanto un’opzione. Si metterebbe in campo, in questo caso, quella capacità umana di essere facitori di mondi che, scavalcando la base biologica dell’esistenza umana, si ipotizza possa produrre un mondo, nello stesso modo con il quale si sceglie una qualsiasi location, con il vantaggio di una indifferenza totale alle problematiche vitalistiche. Si realizzerebbe perciò il sogno di una totale indipendenza umana dai bisogni, che è poi la dimensione di una nostalgia edenica di un tempo originario, o il premio escatologico finale. A questo punto l’essere umano, in quanto facitore di mondo, potrà effettivamente giocare all’infinito con questa possibilità, disegnando ogni specie di mondi virtuali che, dentro questa dimensione, avranno la tangibilità di un mondo reale. Unico problema sarà quello per il quale «i limiti dei parametri del Sistema Terra saranno abbastanza generosi da concedere il tempo necessario al grande salto in avanti» (p. 107).
Su questo versante, cioè sull’atteggiamento non contrastante da tenere di fronte ad una annunciata catastrofe, si è sviluppata un’altra corrente di pensiero, quella degli accelerazionisti per i  quali il mondo attuale sarebbe di fatto moribondo, ma che occorrerebbe ancora del tempo affinché i processi in corso portino a compimento la sua fine annunciata. Questa posizione parte da un’interpretazione per la quale non sarebbe esistito un mondo bucolico a priori che il capitalismo starebbe minando, ma che il mondo è quello che è, perché non c’è un fuori al capitalismo stesso – perché è il capitalismo stesso che coincide con il mondo – per cui, l’unica alternativa possibile, è quella di mettere la macchina in over drive, far accadere l’apocalisse, lasciare che il capitale-mondo imploda, per annunciare l’avvento del regno a venire. Questo atteggiamento sarebbe il risultato di aver portato alla estrema conseguenza il discorso dei compimenti storici cari anche ad una componente marxista per la quale l’evenemenzialità della storia stessa ha a che vedere con una forma di predestinazione che fa sì che, prima o poi, il capitalismo come forma di organizzazione della produzione, come forma mondo, imploda e venga soppiantato da un sistema che superi la divisione in classi (socialismo, dittatura del proletariato, comunismo infine).
quali il mondo attuale sarebbe di fatto moribondo, ma che occorrerebbe ancora del tempo affinché i processi in corso portino a compimento la sua fine annunciata. Questa posizione parte da un’interpretazione per la quale non sarebbe esistito un mondo bucolico a priori che il capitalismo starebbe minando, ma che il mondo è quello che è, perché non c’è un fuori al capitalismo stesso – perché è il capitalismo stesso che coincide con il mondo – per cui, l’unica alternativa possibile, è quella di mettere la macchina in over drive, far accadere l’apocalisse, lasciare che il capitale-mondo imploda, per annunciare l’avvento del regno a venire. Questo atteggiamento sarebbe il risultato di aver portato alla estrema conseguenza il discorso dei compimenti storici cari anche ad una componente marxista per la quale l’evenemenzialità della storia stessa ha a che vedere con una forma di predestinazione che fa sì che, prima o poi, il capitalismo come forma di organizzazione della produzione, come forma mondo, imploda e venga soppiantato da un sistema che superi la divisione in classi (socialismo, dittatura del proletariato, comunismo infine).
Qui il conflitto è paradossalmente simmetrico. Alcuni settori della sinistra vedono con malcelato diniego certe istanze ambientaliste, così come, in certi ambientalismi, sarebbe possibile trovare un’indifferenza quasi totale alle rivendicazioni nel campo dei diritti dei lavoratori. La via di uscita da questa contraddizione sarà l’irruzione di un altro concetto forgiato questa volta da Jason Moore: quello di Capitalocene (Jason W. Moore, Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell’era della crisi planetaria, Ombre corte, Verona 2017).
Il mondo amerindio. All’inizio non c’era niente, ma le persone esistevano già, non c’era nulla del mondo, solo umani. Questa specie degli inizi era morfologicamente duttile. Una duttilità caosmica aperta appunto a un certo disordine (antropofagia, incesto). Poi alcune persone si trasformano, prendono un’altra forma rimanendo però persone. E le forme sono quelle di altre specie biologiche, di fiumi, monti ed altri elementi geografici; di pioggia, vento ed altri fenomeni metereologici; e pietre e corpi celesti, stelle e meteore. La parte che rimane del popolo delle origini, di quelle persone che non hanno cambiato forma, è l’umanità quale la conosciamo, quella storica e quella contemporanea. Lo sviluppo dell’universo fu un processo di diversificazione tale però che gli indio attuali sono coloro che sfuggirono alle trasformazioni. Miti simili sono presenti anche fuori delle Americhe: “in quel tempo non c’erano alberi, torrenti, animali o cibo”. Il mondo era completamente ricoperta di persone. Dopo, un uomo (autorevole, un big man) decise di trasformare alcune persone in specie differenti e in fenomeni naturali. Quelli rimasti, sono i nostri antenati (Nuova Guinea). Si tratta dunque, all’origine, di un’umanità senza mondo o di un mondo dalla forma umana. Un’umanità che è dunque anche sostanza del mondo, sua attanza. È il contrario del Giardino dell’Eden. In questi miti gli esseri umani arrivano prima e da loro si genera il resto della creazione. «È la Natura che nasce o si “separa” dalla Cultura e non il contrario» (p. 148). Esiste dunque un’arcaica latenza umanoide in ogni cosa del mondo. Ogni oggetto e anche un altro soggetto. In questo mondo il concetto di impronta ecologica (mangiare presuppone, ad esempio, la distruzione di altre forme di vita) è certamente più palese. L’antropomorfismo di queste popolazioni si pone all’opposto dell’antropocentrismo del pensiero occidentale. Qui il concetto di crescere o quello di progredire non hanno alcun senso, al massimo verrà loro in mente di conservare lo stato di fatto del mondo, di conservare il mondo. È qui che prende senso l’affermazione: “Vivir bien, no mejor”.
La catastrofe climatica segna quello che si potrebbe chiamare “un fallimento multiplo del governo cosmopolitico (il nomos) dei Moderni” (Bruno Latour). «L’umanità non si trova sul lato opposto dell’essere, non è il contrario o il negativo del mondo, così come il mondo non è il “contesto” (l’”ambiente”) di un Soggetto che lo contro definisce come Oggetto» (p.185).
Déborah Danowski – Eduardo Viveiros de Castro, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle Paure della fine, Nottetempo, Milano 2017, pp. 320, € 17.00.
*Gilberto Pierazzuoli
Gilberto Pierazzuoli
Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)
- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024
- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023
- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023