Le funzioni del linguaggio umano sono molteplici e scaturiscono spesso da forme di prossemica all’interno delle quali il rapporto tra soggetto e oggetto (svolto dal predicato) ha un ordine che rimanda a dei rapporti di causa effetto, dove il soggetto è la sorgente della causa; è colui che esprime la agenzialità e l’oggetto è quello che la subisce. Nelle ecologie radicali si tende a smorzare questa rigidità e a restituire agli oggetti potenzialità, meglio, virtualità espressive per le quali essi non subiscono semplicemente l’azione del soggetto ma, entrando in relazione con questo, ne diventano in qualche modo complici; ne diventano la con-causa. La relazione si sostituirebbe così al soggetto mettendo in discussione la netta separazione tra causa ed effetto. Questo, da un certo punto di vista, è positivo ma erode alcune funzionalità del linguaggio creando sia confusione espressiva, sia confusione di senso. Quello da mettere in discussione è allora l’eccesso di determinismo che congela sia il soggetto che l’oggetto in una posizione per la quale solo il soggetto è, e può essere, agente mentre l’oggetto deve essere materia inerte che può solo e soltanto subire l’azione. In realtà le cose interagiscono tra di loro attraverso un groviglio di relazioni che spostano continuamente di posto reciproco i soggetti e gli oggetti in uno scambio continuo.

Ma le cose avvengono ovviamente anche a partire dalle cause. Spesso senza conoscere la causa il senso può sfuggirci. È quello che fanno gli algoritmi attuali che hanno preso la scorciatoia di trovare il senso soltanto all’interno di ricorrenze probabilistiche che gli umani hanno utilizzato in precedenza usando la lingua. Algoritmi che potevano essere costruiti intorno a modelli che rendessero conto dei rapporti di causa ed effetto ma che hanno invece scelto di ignorare. È una scorciatoia tecnologica che ha portato ad avere risultanti immediati eclatanti e subito fruibili. Sui quali è stato possibile costruire immediatamente dei modelli di business. Ha portato anche ai problemi correlati ad abbandonare l’indagine sul come si costruisce il senso, sul come i rapporti di causa effetto – ed altri ancora – determinino il senso: ha portato in definitiva a lasciare la porta aperta attraverso la quale far passare il non-senso: le sciocchezze e i miraggi delle chat discorsive. Ho sottoposto questa semplice domanda a Bard: “Cosa pesa di più, un chilo di ferro o un chilo di piume?”, la risposta sconcertante è stata abbastanza articolata con questa conclusione sintetica: “Pertanto, la risposta alla domanda ‘Cosa pesa di più, un chilo di ferro o un chilo di piume?’ è che, sulla Terra, un chilo di ferro pesa di più di un chilo di piume, seppur di poco”.
In realtà, a noi qui interessa interrogare i corpi, non tanto mettere a tacere le voci sintetiche piene di sciocchezze delle chat digitali, a noi interessa capire e decentrare il soggetto; smascherare l’antropo dell’antropocene.
Nel linguaggio le intricate relazioni di causa ed effetto venivano normate attraverso i casi della lingua: nominativo, genitivo, dativo etc.
In questo quadro, alcuni studiosi hanno proposto di ricondurre la dottrina dei casi al sistema delle “cause”: poiché la realtà è composta di corpi in costante relazione di causa ed effetto, il “caso” della lingua corrisponderebbe alle diverse occorrenze causali, ovvero ai diversi generi di causa con cui si relazionano vicendevolmente i corpi (Di Vita 2022, p. 189).
Ogni situazione, ogni relazione tra i corpi, determina una traccia, quella di un corpo che in sé sarebbe inaccessibile; una traccia che dipende dalla situazione stessa, un corpo colto cioè nel suo modo di essere, espresso dai predicati contenuti nell’enunciato. «All’interno di un enunciato, un “caso” sarà anzitutto l’espressione di una relazione sintattica tra le parti della frase; in quanto tale, esso sarà la trascrizione, ovvero il contenuto di significazione, della relazione di causa che costituisce la realtà detta» (ibidem). Ridimensionare la causa non significa farne a meno. È qui che le macchine – quelle che usano quella scorciatoia di cui sopra – perdono il “senso”. Perdere il senso le espone alla possibilità di “inventarsi” cose non soltanto poco plausibili ma a volte anche totalmente impossibili. È quella che i padroni delle macchine chiamano, bontà loro, i “miraggi” dell’algoritmo.

L’italiano, e gran parte delle lingue romanze, hanno perso i casi latini, ma ne contengono, spesso, dei succedanei nell’uso differenziato che fanno dei pronomi. L’economia linguistica degli umani nelle culture orali rispecchia la continua interrelazioni dei corpi in presenza. È una cultura che dipende dalla voce e anche quando la voce riporta un già detto, un detto altrove, rimane una voce che si cala nella situazione. La voce dell’aedo, la voce del racconta-storie, crea uno spazio attraversato da campi di forza e flussi desideranti che caratterizzano la situazione, che segnano l’evento del dire. Il dire non si esaurisce nella lingua, non deve esaurirsi in essa. Le culture orali non amano il differimento. Soltanto la scrittura e le registrazioni/campionature moderne introducono una differanza (Derrida) una differenza figlia di un differimento nel tempo e nella materialità dell’enunciato. Anche nel tempo delle tecnologie linguistiche le più avanzate non è possibile mettere a tacere la voce; il corpo parlante, cantante, gridante, sussurrante; il corpo lamentoso, il corpo chiamato, evocato, lodato: l’amore e l’insulto. La voce in differita, totalmente astratta dall’evento del dire, era una fake news insopportabile sino a poco più di un secolo fa.
Le Ai generative di testo, non hanno voce, lavorano sui grammata (γράμματα), sulle lettere dell’alfabeto, sulle unità minime di senso scritturale. Anche il dialogo tra voce biologica sintetizzata e risposta, anch’essa sintetica, passa per i grammata. La voce non è riducibile a tratti discreti: è un mugolio continuo cadenzato in flussi sonori che si rifrangono e riverberano avvolgendo i corpi parlanti che, nel momento che hanno voce, si cristallizzano in una forma metastabile individuante, pronta comunque a de-formarsi plasticamente. La voce prende corpo e il corpo prende la parola in uno scambio continuo di ruoli. È questa la voce individualizzante, l’univocità della voce. «Distinte sono la voce (phoné) e la parola (léxis): ché la voce è propriamente il suono (mèn kaì ho echos) mentre la parola è soltanto ciò che è articolato (tò énarthron mònon)» Diogene di Babilonia (Di Vita 2022, cit. a pag. 207). C’è la voce e la sua articolazione che non è l’emissione sonora, ma la conversione del suono in suono significante. È il valore di echos: «esso occupa infatti, e in modo certo singolare, il luogo non di una generica sonorità, ma del fatto sonoro nella parola, di una voce non più che pronta alla significazione» (ivi, p. 209). L’Eco ha una sua origine mitologica legata alla storia di Narciso:
Il narciso dell’inno omerico a Demetra è il fiore che provoca un che di stupore che ispira il sacro (il thambos): «Abbagliata essa tendeva le mani per afferrare il bel tranello, quando la terra dai vasti sentieri si schiuse […]»433 E qui l’elemento riflessivo, lo specchiamento è tutto nell’essere della Kore-Persefone essa stessa un bocciolo, un fiore in divenire che segna il passaggio di una generazione nel ciclo vegetativo. La fama del narciso è anche legata al suo carattere di fiore inebriante e soporifero. La radice etimologica di narciso è “narkè” (sopore, stupore), la stessa di narcotico. Siamo di fronte ad un calderone di attributi nel quale l’uno provoca e consegue l’altro in un ordine indeterminabile. Al termine “narciso” corrispondono i caratteri della fascinazione, della meraviglia, del tenere lo sguardo su di sé, che insistono tutti sull’aspetto immaginativo – di essere immagine – di ogni narciso o Narciso. Perché ogni immagine è anche semplicemente specchio di qualcosa che però è sfuggente ed è manipolabile soltanto nel proprio essere immagine e al di là di ogni ipotesi sulla sua sostanza (Pierazzuoli 2016, p. 166).
A questo punto appare la ninfa Eco. Essa è stata condannata da Giunone ad un singolare comportamento: non poteva né parlare per prima né tacere se un altro parlava; di questi però ripeteva gli ultimi suoni. Era la punizione per aver distratta la dea con delle chiacchiere per permettere a Giove di appartarsi con altre ninfe. Eco vede Narciso ed ovviamente se ne infatua, lo segue nel bosco ed è tentata di rivelarglisi. Ma Eco non può parlare per prima.
Per caso il fanciullo, separatosi dai suoi fedeli compagni,
aveva urlato: «C’è qualcuno?» ed Eco: «Qualcuno» risponde.
Stupito, lui cerca con gli occhi in tutti i luoghi,
grida a gran voce: «Vieni!»; e lei chiama chi l’ha chiamata.
Intorno si guarda, ma non mostrandosi nessuno: «Perché», chiede,
«mi sfuggi?», e quante parole dice altrettante ne ottiene in risposta.
Insiste e, ingannato dal rimbalzare della voce:
«Qui riuniamoci!» esclama, ed Eco che a nessun invito
mai risponderebbe più volentieri: «Uniamoci!» ripete.
E decisa a far quel che dice, uscendo dal bosco, gli viene incontro
per gettargli, come sogna, le braccia al collo.
Lui fugge (…) (Ovidio, Metamorfosi, III, 62-82).

Segue la fine di Eco. La storia della ninfa si basa si basa sull’esistenza di una voce che è pura emissione sonora; sull’incapacità di quella voce di articolarsi in grammata, di essere sostanza di un processo semantico, di una significazione che l’avrebbe messa in comunicazione con Narciso. L’intelligenza della macchina si raccoglie intorno a quello che alcuni hanno chiamato un pappagallo stocastico. La capacità di ripetere a pappagallo un termine fuoriuscito da un processo stocastico, un termine il più probabile. La pretesa algoritmica di trovare un senso dalla pura ricorrenza e posizione del lemma non riesce a rendere conto però della contraddizione in cui si trova immersa Eco. La non significazione della voce di Eco e quella dell’algoritmo stocastico, non sono la stessa cosa. Narciso non raccoglie il senso della voce di Eco, ma ne raccoglie comunque il suono. Coglie la presenza di un ente capace di emettere suoni. Il suono della voce di Eco, pur dentro il suo non senso, innesca il processo empatico. L’incontro lascia pur sempre un segno. La macchina rimane invece estranea, non si fa coinvolgere. La macchina dell’eco – il pappagallo stocastico – non riesce a essere protagonista della storia, rimane lì: una stringa sullo schermo che il processo ha svuotato di senso.
Eco rimanda a un nucleo semantico che la lega a mìmèma, alla ripetizione, alla ri-sonanza. Per Pindaro Eco è una delle Oreidi, ninfe dei boschi. Madre con Pan di Iynx e Jambe. Iynx con un incantesimo, fece innamorare Zeus di Io, scatenando la gelosia di Era che trasformò Iynx nell’uccello Torcicollo che in greco si chiama egualmente Iynx. Con lo stesso nome esisteva anche il gioco sonoro che aveva affinità con le movenze del Torcicollo. Si tratta di un cerchio con due fori nei quali si fa passare una corda che ruotata vorticosamente produce un suono particolare. Si dice che l’iynx (la ruota vorticosa) abbia proprietà di fascinazione erotica e che il suono da esso prodotto abbia la capacità di incantare e avvincere la persona amata, anche suo malgrado, trascinandola “nel cuore della ruota magica” (Pindaro). L’iynx era, dunque, lo strumento usato da maghe e mezzane per suscitare un’attrazione fatale e irresistibile. Fu proprio un iynx che Afrodite dette a Giasone per “circuire” Medea. In alcune attestazioni lo strumento di seduzione è l’uccello stesso che viene legato ad una ruota. Si tratta dunque di un eccesso di peitho (persuasione occulta), peitho è infine voce sussurrata che provoca un circuito di plusvalore simbolico. L’altra figlia di eco è Iambe che alcuni identificano con Baubo. Il personaggio compare nell’inno omerico a Demetra. Dunque, Demetra, gravemente afflitta dalla perdita di Persefone, dopo aver digiunato nove giorni, discende sulla terra con le fogge di una vecchia. Accolta dal re Celeo e dalla regina Metanira, che la incarica di far da balia a suo figlio, viene invitata a riposarsi sul trono
Ma Demetra apportatrice di Messi, dai magnifici doni,
non volle sedersi sul trono risplendente,
e ristette in silenzio, abbassando begli occhi,
finché l’operosa Iambè ebbe disposto per lei
un solido sgabello, gettandovi sopra una candida pelle.
Là ella sedeva, e con le mani si tendeva il velo sul volto;
e per lungo tempo, tacita e piena di tristezza, stava immobile sul seggio,
né ad alcuno rivolgeva parola o gesto,
ma senza sorridere, e senza gustare cibi e bevande,
sedeva struggendosi per il rimpianto della figlia dalla vita sottile:
finché coi suoi motteggi l’operosa Iambé,
scherzando continuamente, indusse la dea veneranda
a sorridere, a ridere, e a rasserenare il suo cuore:
Iambé, che in seguito fu cara all’anima della dea
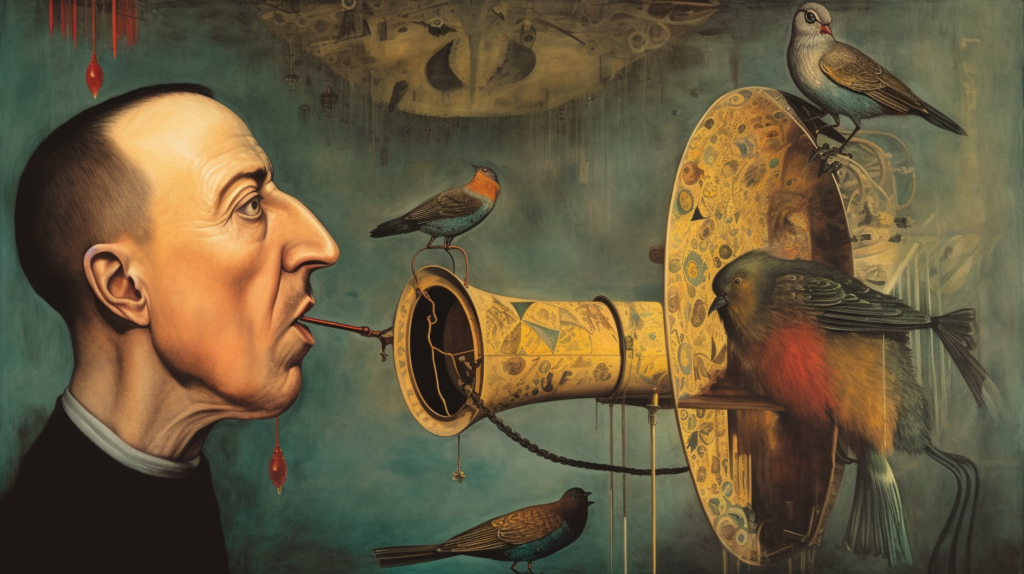
Secondo Clemente Alessandrino nel Protreptikon (II, 20) il gesto che provoca il riso della dea è l’alzarsi delle vesti che mostra Iacchos (Dioniso bambino):
A queste parole, si alzò le vesti
Mostrò per intero
L’indecente contorno del corpo
E apparve il bambino Iacchos,
che lei agitava con la mano ridente,
sotto le vesti di Baubo.
Dopo che la dea ebbe riso a crepapelle
Accettò la scodella levigata in cui era il Kykeon
Ma non è soltanto il mostrare/mostrarsi di Dioniso, il riso è provocato dal mostrare il sesso, come testimoniano le statuette in ceramica di Baubo che erano abbastanza diffuse. È anche l’irrompere dell’osceno nel quotidiano ripetersi delle gesta del vivente.
In una ulteriore versione del mito riportata da Ovidio. In questa versione Eco si unisce a Narciso provocando però le ire del suo pretendente che l’avrebbe consegnata a dei pastori che dilaniarono le parti del suo corpo e le distribuirono in tanti luoghi della terra. Qui si trasformarono in rocce generando così i caratteristici echi tra le montagne.
In alcuni frammenti di una tragedia di Euripide ormai perduta: Andromaca. Compare Eco: Così si presenta: «Sono Eco, colei che ripete quel che è detto». Si tratta di un’allegoria della voce che non dice ma ripete mantenendo comunque una sua efficacia riuscendo infatti a soccorrere Andromaca. Nell’iconografia che la concerne è «rappresentata ora nella sconsolazione, come l’Andromaca della tragedia, ora presso una fonte, insieme a Narciso» (Di Vita 2022, p. 214). Nel contesto euripideo si fa riferimento a una tradizione, quella del canto amebeo, una degli agoni agresti di epoca arcaica. Di questa specie di sfide legate al linguaggio ce ne sono molte anche se sono sempre più rare. Una per tutte le sfide in ottava rima. Ma tornando al canto amebeo
[in esso], null’altro era in questione che il rimbalzo tra i parlanti di battute dialogate, sulla base della mera rispondenza sonora e in sostanziale sospensione del contenuto. Il dialogo amebeo è la testimonianza di come non è possibile, per la parola, la strozzatura al significato, il confino alla comunicazione. La voce che mantiene vivo il dialogo possibile è, originariamente, voce oltre il comunicare dei contenuti, voce anzitutto ripetuta, rispecchiata, inseguita. E il suono è, come insegna Eco, prima d’ogni altra cosa uno specchio – il linguaggio è un Narciso che vi si rispecchia, riproponendo se stesso (Ivi, p. 215).
Gli umani sono complicati e gli algoritmi che alcuni di loro creano per trarne dei profitti sono macchine da inganno. Ma quello che mi interessava mettere in evidenza è un uso del linguaggio puramente ludico, inutilitario e insignificante. Là dove le AI generatrici di stringhe linguistiche operano prescindendo dal senso, gli umani tentano di stupirle – e di stupirsi – giocando con il non senso. Le macchine stanno facendo questo allenandosi su basi di dati enormi prodotte dagli umani. Adesso, l’interazione con gli umani sta loro fornendo ulteriore materiale. Ma se i primi data set potevano ed erano contaminati da bias (pregiudizi) e da altri “difetti”, l’iterazione porterà a una ulteriore loro concentrazione. La frequentazione umani e macchine, con l’apparente scopo di permettere alle macchine di sostituire/aiutare gli umani, sta condizionando gli umani, sta cercando infatti di normalizzare il comportamento umano. Il linguaggio è il piano privilegiato di questo confronto. I corpi, la voce, la parte del linguaggio indissolubilmente espressione del corpo. Del corpo che inter-agisce con altri corpi. La voce, dunque, è il fenomeno assente. La macchina lavora soltanto con i grammata.

Ma anche la grammatica umana non è così perentoriamente sistematizzante. La voce non riesce a starne costantemente fuori, spesso fa capolino. Il vocativo ha, per esempio, uno statuto indipendente: i nomi si danno «come il mero darsi di quel nome, al di là di ogni relazione con i costituenti dell’enunciato profferito» (Di Vita 2022, p. 193). Il vocativo, il nome esula dal discorso, dal processo di significazione. Il nome si nomina e si isola da tutto ciò con un segno di interpunzione. Chiamare un nome è e-vocare quel nome: Giulia, Ada, Alberto, occorre una virgola e, dopo, il processo di significazione può andare avanti. Anche “io”, dire: “io”, non rispetta le funzioni che caratterizzano i processi semantici: «”io” è a un tempo referente e riferito, nient’altro che l’individuo che sta parlando e in quanto sta parlando» (ivi, p. 197) È un riferimento che esiste soltanto se c’è una situazione discorsiva. «È un fatto originale e fondamentale che queste forme “pronominali” non rimandino né alla “realtà” né a posizioni “oggettive” nello spazio e nel tempo, ma all’enunciazione ogni volta unica, che le contiene». La lingua, cioè, ha creato «un insieme di segni “vuoti”, non referenziali in rapporto alla “realtà”, sempre disponibili, e che diventano “pieni” non appena un parlante li assume in ogni situazione del suo discorso (Benveniste 2010, p. 304). Questi, non essendo referenti di nulla, «non sono sottoposti alla condizione di verità» (ivi, p. 203). Sono casi nei quali l’enunciazione è in diretta relazione con i corpi, con la relazione tra quei corpi. Senza quella presenza il potere e-vocativo si perde.
Per Anders, «può darsi benissimo che il pericolo che ci minaccia non consista nel cattivo uso della tecnica, ma sia implicito nell’essenza della tecnica in quanto tale» (p.113). Per Anders le macchine sarebbero «per natura espansioniste e integraliste, dunque ardono [arderebbero] dal desiderio di non lasciare incompiuta alcuna prestazione, anzi sono [sarebbero] assolutamente incapaci di non assumere tutte le funzioni che sono in grado di eseguire. [Esse] non avranno raggiunto il loro obiettivo finché resterà ancora qualche residuo: cose o uomini “ex-centrici” che continuano [continuerebbero] a esistere fuori dalla macchina» (p. 102). Ma questa non è la macchina astratta. L’”indole” della macchina è lo scopo che il padrone della macchina le impone costruendo algoritmi finalizzati alla massimizzazione del profitto che non possono deragliare da questo scopo. Non esiste la macchina impazzita che si rivolta contro l’umanità, non è questo il deragliamento che fa paura al padrone della macchina. Non c’è nessuna pazzia, c’è soltanto la norma, lo svolgersi pedissequo delle routine algoritmiche che perseguono il profitto anche a scapito del bene della maggioranza degli umani, anche a scapito delle distruzioni ambientali, di ogni distruzione, è il vizio capitale della macchina capitale (il gioco di parole è voluto).
Riferimenti bibliografici:
Nicoletta Di Vita, Il nome e la voce. Per una filosofia dell’inno, Neri Pozza, Vicenza 2022
Gilberto Pierazzuoli, Gioco, giocattoli, robot e macchine umane, Robin, Torino, 2016
Tutte le immagini – meno quella della statueta di Baubo – sono state generate da una AI Text To Image su indicazioni testuali dell’autore dell’articolo.
Gilberto Pierazzuoli
Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)
- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024
- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023
- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023







