Un gruppo di scugnizzi che viene a bussare alla porta di un Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario con un pallone sotto il braccio, che urla in coro “possiamo giocare a pallone qua dentro?”. Genitori che, tra una pasta al forno e qualche caffè zuccherato, chiedono “ma oltre a farli giocare a pallone, li potete aiutare con i compiti?”. Un semaforo per l’attraversamento pedonale istallato dal Comune grazie alla (prima) mobilitazione collettiva del quartiere, che ha visto scendere in piazza gli abitanti, le associazioni, i negozianti, i bambini del doposcuola con semafori di cartapesta, i ragazzi del catechismo e le signore del rosario delle 7 di sera. Una realtà, che letteralmente bussa alle tue porte e ti impone problematiche, temi, bisogni da soddisfare collettivamente. Una forte autocritica, che ci ha portato ad ascoltare prima che a proclamare, a fare prima che a promettere, ad agire collettivamente prima di muoversi autonomamente.
Questi sono (alcuni) degli ingredienti che solo quattro anni fa hanno dato inizio alle pratiche mutualistiche e solidali all’interno dell’Ex Opg Je So’ Pazzo di Napoli che oggi vengono portate avanti dall’intera comunità di Potere al Popolo!. Se dovessimo riassumerlo in una definizione, declinare la propria pratica politica territoriale attraverso il mutualismo vuol dire in prima istanza avviare, all’interno delle proprie sedi, o meglio, all’interno delle Case del Popolo, un percorso di organizzazione e costruzione di attività solidali di risposta ai bisogni fondamentali degli abitanti della zona o della città in cui si opera: ambulatorio popolare, camera del lavoro, sportello legale per i migranti o per i lavoratori, scuola d’italiano, biblioteca e aula studio, attività di contrasto alla povertà -le cosiddette reti di solidarietà-, attività sportive, teatro popolare, doposcuola per bambini etc., sono alcuni esempi delle attività che ogni giorno all’interno delle Case del Popolo di Potere al Popolo! vengono portate avanti in maniera assolutamente volontaria e gratuita (ovviamente con peculiarità specifiche per ogni territorio).
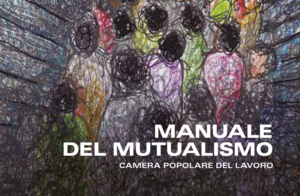 Ma oltre alla mera (e quasi scontata) definizione, quale è il senso più profondo di investire il tempo, le energie fisiche e mentali dei propri militanti e le risorse organizzative e logistiche del movimento in attività del genere? Che senso ha, per un’organizzazione politica, promuovere all’interno dei propri spazi corsi di yoga, tango, scuole di lingua e reti per l’assistenza ai senza fissa dimora? Che differenza c’è tra il mutualismo e l’assistenzialismo fine a sé stesso?
Ma oltre alla mera (e quasi scontata) definizione, quale è il senso più profondo di investire il tempo, le energie fisiche e mentali dei propri militanti e le risorse organizzative e logistiche del movimento in attività del genere? Che senso ha, per un’organizzazione politica, promuovere all’interno dei propri spazi corsi di yoga, tango, scuole di lingua e reti per l’assistenza ai senza fissa dimora? Che differenza c’è tra il mutualismo e l’assistenzialismo fine a sé stesso?
A queste fondamentali domande cerchiamo di dare una risposta all’interno del nostro “Manuale del Mutualismo” (Ex Opg Je So’ Pazzo (2018), Manuale del Mutualismo, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bruxelles 2018), una cassetta degli attrezzi in cui abbiamo raccolto le riflessioni e le pratiche di questi primi quattro anni di pratiche.
Sia chiaro: noi non svolgiamo attività sociali gratuite semplicemente perché siamo bravi ragazzi e abbiamo un cuore grande, indubbie doti morali nella società di oggi, ma che non bastano a trasformarla. Abbiamo costruito pratiche di solidarietà e mutualismo per intercettare, come accennavamo, i nostri: i lavoratori, i disoccupati, l’ampio fronte delle classi popolari del paese. L’attività sociale è dunque da intendersi non in senso assistenzialistico, per sopperire alle mancanze dello Stato, ma principalmente come scuola di lotta. La questione è quindi comprendere il valore politico di questo tipo di attività, cioè come si possa passare da un piano meramente sociale a un piano vertenziale e quindi politico.
Ma andiamo con ordine: portare avanti attività mutualistiche e solidali vuol dire in prima istanza rispondere ai bisogni fondamentali delle persone, di “mettere una toppa” agli effetti nefasti che la crisi economica del 2008 ha causato sul corpo sociale del Paese, soprattutto sulle classi popolari: la precarietà lavorativa o la totale disoccupazione ha portato a una progressiva proletarizzazione di ampi strati della società italiana, andando ad acuire le diseguaglianze economiche e sociali e portando a un progressivo impoverimento. A questo si aggiungono le politiche di tagli e privatizzazioni di ampi settori del welfare, a causa dei quali grosse fette della popolazione -soprattutto al Sud e nelle periferie- non hanno accesso ai servizi di base fondamentali, come la sanità, l’istruzione e il diritto all’abitare, compresi quelli “non vitali” come l’accesso alla cultura, ai servizi sportivi e d’intrattenimento. Fornire una prima soluzione dal basso a tutti questi problemi vuol dire innanzitutto rispondere ai bisogni reali del corpo sociale che si intende rappresentare.
La naturale conseguenza di questo tipo di attività è la possibilità di ricreare una comunità, una rete di riferimento che combatte l’individualismo, la competizione e la solitudine che si crea in ampie fasce della popolazione, organizzare un’arma efficace contro la guerra tra poveri. Questa è una sfida importante, perché in questo mondo ci insegnano tutt’altro, a farcela da soli o a sentirci incapaci, ma nessuno ci dice quant’è molto più gratificante e produttivo fare le cose insieme, aiutandosi a vicenda, imparando l’uno dall’altro, uscendo finalmente dall’io per costruire un noi. Una comunità che sperimenta piccole forme di autogoverno sul territorio e che quindi riesce a raggiungere grandi risultati organizzandosi autonomamente e instaurando pratiche di collaborazione, di solidarietà, di superamento della competizione. Una comunità che mette in pratica la vera essenza della parola “politica”, una forma di autoaiuto collettivo, un antidoto alla sofferenza.
Tutto questo immenso lavoro ha anche dei risultati immediati sull’immagine e la visibilità dell’organizzazione: le persone iniziano infatti ad avere fiducia, a vedere quel determinato gruppo, movimento, Casa del Popolo, come qualcosa di credibile, affidabile, competente, utile, come un punto di riferimento sul territorio. Ma ancora di più, è l’opportunità per entrare in contatto e coinvolgere tutti quei soggetti sul territorio che altrimenti sarebbero esclusi dalla tua attività politica: comitati di quartiere, associazioni, collettivi, reti di solidarietà, fino ad arrivare alle Parrocchie, sono gruppi con cui diventa possibile mobilitare gli abitanti, portare avanti lotte e rivendicazioni comuni, diffondere non solo le pratiche, ma anche i contenuti, la lettura delle cause dei problemi, l’elaborazione collettiva delle soluzioni.
Tramite le pratiche mutualistiche infatti, coloro che normalmente sono gli oggetti, i meri destinatari delle decisioni politiche e che molto spesso subiscono gli effetti della crisi, della precarizzazione e della povertà sulla propria pelle, diventano soggetti dell’agire politico, protagonisti in prima persona. Noi crediamo infatti che solo i lavoratori delle città e delle province, gli abitanti dei territori dove insistono il disastro ecologico e l’abbandono sociale, solo chi vive sulla propria pelle gli effetti del razzismo e dell’emarginazione, solo loro possono descrivere con piena consapevolezza le ingiustizie che subiscono, solo loro possono raccontare il vero funzionamento del pubblico e del privato. Solo così si può riuscire a comprendere più facilmente quali siano i bisogni fondamentali delle persone, o meglio, quelli che le persone ritengono come prioritari e sui
quali è possibile organizzare una vertenza e una mobilitazione. Troppo spesso infatti i movimenti, i partiti, i collettivi, hanno proiettato verso l’esterno quelli che loro consideravano essere i problemi sentiti dalle persone, che però non si sono rivelati tali.
Quest’ultimo possibile rischio è scongiurato dalla possibilità di portare avanti un reale lavoro di inchiesta sui territori. Fare inchiesta attraverso il contatto diretto e attraverso l’attività quotidiana di un ambulatorio, di uno sportello legale, di uno sportello per la residenza, vuol dire riuscire a fotografare i punti di forza e le debolezze delle classi popolari, a capire così da quale tattica cominciare, quali sono i nostri amici e i nostri nemici in ogni situazione determinata, e quali sono le componenti più disposte alla lotta. L’inchiesta utilizza strumenti di analisi quantitativa -come questionari, costruzione di database etc.- e strumenti di analisi qualitativa – basata sull’osservazione partecipante, sulle testimonianze etc.- per riuscire a capire la situazione del proprio territorio, le relazioni tra i settori sociali e produttivi, la condizione lavorativa, le contraddizioni di razza, genere ed ecologiche che si verificano, i piani d’intervento su cui poter intervenire e gli strumenti da mettere in campo.
Conoscere i problemi del proprio territorio non vuol dire esclusivamente tentare di risolverli nella propria “isola felice” della Casa del Popolo -dove al massimo si può risolvere quel particolare bisogno per quella particolare persona-, ma spinge necessariamente all’organizzazione immediata di vertenze e lotte più complessive, da portare avanti con gli stessi soggetti incontrati nell’attività sociale e da sviluppare su più livelli -dal livello locale, all’interno delle istituzioni di prossimità, a un livello più ampio di lotta nazionale contro determinate politiche, decreti, leggi etc-. Lotte e vertenze che possono portare anche vittorie che non solo vanno a rinsaldare la fiducia verso l’organizzazione e verso il metodo portato avanti, ma che sono dei reali avanzamenti per il proprio soggetto di riferimento.
Le pratiche di mutualismo portate avanti da Potere al Popolo! non intendono infatti essere una sostituzione al ruolo dello Stato, ma degli strumenti di lotta per cambiamenti più generali. Proprio per questo scopo è nata la pratica del Controllo Popolare, che per noi è la “spina dorsale” del lavoro del movimento. Nel nostro paese, ad oggi, esistono ancora servizi pubblici essenziali, ed è nostro compito difenderli, controllandone dal basso il funzionamento, criticandolo per risignificarlo sulla base della nostra esperienza di autogoverno che riflette costantemente su nuove soluzioni, e senza mai accettare passivamente l’idea che tanto non ci sono soldi perché i soldi ci sono, ma sono spesi male, alimentando un’organizzazione inefficiente del pubblico, utile solo a giustificare l’intervento del privato. Il Controllo Popolare consiste quindi nell’organizzare squadre di cittadini che vanno di persona a controllare il funzionamento delle istituzioni, conoscere i meccanismi decisionali e di nomina dei responsabili, vigilare sulle spese e sugli sprechi o appropriazioni di fondi pubblici, controllare l’effettivo rispetto di diritti umani nei diversi ambiti e, dove necessario, denunciare una prassi o una legislazione sbagliata o lesiva della dignità e dei diritti delle persone. Questo tipo di pratica è quindi una delle più forti espressioni di partecipazione e presa di parola sulla vita pubblica dal basso, ma anche una forte arma di rivendicazione e di lotta politica in molti ambiti: dai Centri d’Accoglienza Straordinaria per i migranti (CAS) agli ospedali e istituti sanitari, dalle aziende e i luoghi di lavoro, ai seggi elettorali.
Queste poche pagine non vogliono essere una ricetta da seguire punto per punto, una raccolta dei dettami che devono per forza essere rispettati. Anzi, sono semplicemente la volontà di condividere ciò che una comunità come Potere al Popolo! sta sperimentando e portando avanti giorno dopo giorno, con i propri limiti e le specificità di ogni territorio. Una cassetta degli attrezzi da utilizzare e mettere costantemente a verifica. Ma vi assicuriamo che dietro a queste riflessioni teoriche, ci sarebbero altrettante pagine da scrivere sulla bellezza, non solo politica, ma anche umana, di portare avanti queste tipo di pratiche, dei sorrisi, degli abbracci, del sudore, delle lacrime, dell’importanza di riscoprire e far riscoprire l’efficacia dell’agire collettivo. Questo comporta ovviamente “mettere le mani nella merda”, confrontarsi direttamente e in prima persona con le contraddizioni del sistema in cui viviamo, ma allo stesso tempo consente di ricreare un’identità collettiva e ricucire quello strappo violento che si è verificato tra i singoli soggetti e l’agire collettivo, di ridare cioè dignità, fiducia e bellezza alla “politica”.
*Matteo Giardiello






