Avevo circa 16 anni quando, grazie alla mia professoressa di storia, lessi il primo saggio femminista della mia vita. Ricordo di aver concluso il libro, era “Dalla parte delle bambine” di Elena Gianini Belotti, e di aver pensato: la lotta femminista è una lotta etica e giusta, perché allora non siamo tutte femministe e tutti femministi?
La mia era una domanda molto ingenua che appiattiva la questione della subordinazione delle donne nella storia. Non mi rendevo conto che il problema era rappresentato dal privilegio di alcuni a discapito di altre: gli uomini storicamente trassero vantaggi dalla loro posizione di dominio e chi gode di un privilegio difficilmente sceglie di rinunciarvi. Il movimento femminista punta al raggiungimento della parità sociale, politica, giuridica ed economica tra i sessi, ma questo cosa significa? Significa operare una ristrutturazione sociale per ridistribuire equamente diritti, possibilità e risorse (materiali e simboliche) tra uomini e donne. Un sogno per una parte della popolazione, un incubo per chi rischierebbe di perdere una posizione comoda e vantaggiosa.
Il privilegio non è però rappresentato solo dal sesso – rigorosamente maschile – esistono più tipologie di privilegio. Appartenere ad una classe sociale economicamente agiata pone le donne e gli uomini che ne fanno parte in una posizione di privilegio rispetto agli altri; è questa consapevolezza che denota una forte linea di frattura tra femministe liberali e femministe marxiste. Il colore della pelle e la provenienza geografica attribuiscono un ulteriore privilegio a chi nasce bianco e, preferibilmente, nel “nord del mondo”, aspetto sottovalutato dalle femministe liberali finché non emerse la corrente del black feminism.
 Ma di che femminismo dovremmo allora occuparci? Di quello che Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser definiscono “femminismo per il 99%”. Le tre studiose, all’interno del loro manifesto, pongono un’asprissima e provocatoria critica verso il femminismo liberale che sposa il sistema sociale e di produzione capitalistico. Il problema del capitalismo, spiegano, è che esso «ha costruito una nuova e moderna forma di sessismo, sostenuta da inedite strutture istituzionali. La sua mossa chiave è stata quella di separare la produzione delle persone dalla produzione per il profitto, assegnando la prima mansione alle donne e subordinando questa mansione all’altra», creando così una gerarchia tra lavoro produttivo e riproduttivo. Il primo è appannaggio tipicamente maschile ed è un lavoro salariato, il secondo è svolto dalle donne ed è totalmente gratuito. Il primo coinvolge la sfera pubblica, il secolo relega in una dimensione privata.
Ma di che femminismo dovremmo allora occuparci? Di quello che Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser definiscono “femminismo per il 99%”. Le tre studiose, all’interno del loro manifesto, pongono un’asprissima e provocatoria critica verso il femminismo liberale che sposa il sistema sociale e di produzione capitalistico. Il problema del capitalismo, spiegano, è che esso «ha costruito una nuova e moderna forma di sessismo, sostenuta da inedite strutture istituzionali. La sua mossa chiave è stata quella di separare la produzione delle persone dalla produzione per il profitto, assegnando la prima mansione alle donne e subordinando questa mansione all’altra», creando così una gerarchia tra lavoro produttivo e riproduttivo. Il primo è appannaggio tipicamente maschile ed è un lavoro salariato, il secondo è svolto dalle donne ed è totalmente gratuito. Il primo coinvolge la sfera pubblica, il secolo relega in una dimensione privata.
Aruzza, Bhattacharya e Fraser accusano il femminismo liberale di esser diventato un’ancella del capitalismo. Oggi il problema del capitalismo è che «dopo aver avvelenato l’atmosfera, irriso ogni pretesa democratica, teso fino al punto di rottura le nostre società e degradato le condizioni di vita della vasta maggioranza, questa forma di capitalismo ha alzato la posta in gioco per ogni lotta sociale, trasformando ogni timido tentativo di conquistare riforme modeste in battaglie all’ultimo sangue per la sopravvivenza». In quest’ottica, il femminismo ancillare al capitalismo non può che essere un “femminismo dell’1%” che si batte per il diritto di farsi avanti di un’esigua minoranza di donne. È il femminismo che vuole portare le donne in posizioni di potere per occupare i posti dove prima sedevano gli uomini, ignorando il 99% di donne che non è al potere o non è interessata al potere. Questo è il femminismo della meritocrazia sopra la parità e dell’illusione che il “merito” sia un concetto oggettivo. Il mito della meritocrazia dimentica però, o fa finta di dimenticare, che esistono variabili socio-economiche che pongono alcune donne in una posizione di privilegio rispetto alle altre e, in virtù di questo privilegio, queste donne hanno più chance di emergere sulle altre. Ma non è solo questo il problema.
Le donne bianche di classe medio-alta spesso si sono affrancate dall’obbligo del lavoro riproduttivo e di cura esternalizzando la propria oppressione verso altre donne, generalmente donne di classe economica più bassa e/o provenienti dal “sud del mondo” dando vita a quella che Arlie Hochschild ha definito “global care chain”. La sociologa si riferisce ad una serie di contatti personali attorno al mondo basati sul lavoro di cura, che può essere pagato o meno. Insomma, la liberazione delle donne bianche ed economicamente agiata passa così attraverso lo sfruttamento delle donne più povere e razzializzate. Come nel capitalismo, un’esigua minoranza rappresentata dai capitalisti sfruttava un cospicuo numero di operai in nome del profitto; nel femminismo liberale dell’1% un esiguo numero di donne sfrutta il restante 99% in virtù della propria emancipazione.
Ma allora qual è la proposta del femminismo per il 99% di Aruzza, Bhattacharya e Fraser? È un femminismo marxiano attento alle questioni di classe, un femminismo anticapitalista e antirazzista che fa propria la causa ecologista. È un femminismo politicizzato ed internazionalizzato che fa dello sciopero uno strumento di lotta. Aruzza, Bhattacharya e Fraser non sono solo tre studiose e autrici del manifesto di cui abbiamo parlato, ma sono infatti state le principali organizzatrici degli scioperi internazionali delle donne, che hanno reso di nuovo l’otto marzo una giornata di rivendicazioni politiche, negli Stati Uniti.
Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser, Femminismo per il 99%. Un manifesto, Laterza, Bari 2019, pp. 96, euro 14
*Francesca Pignataro


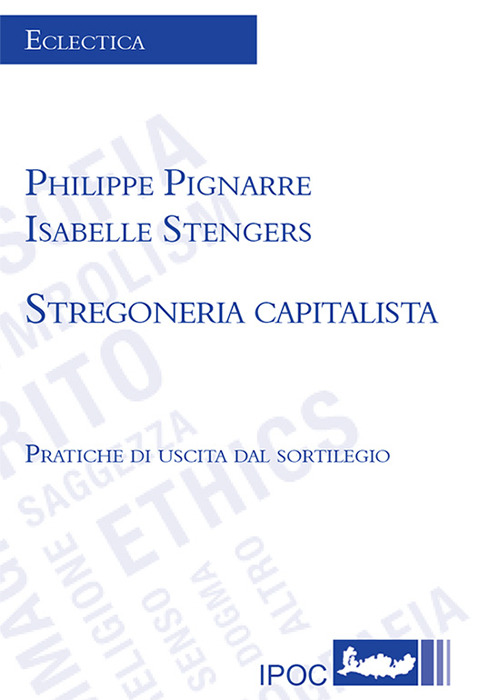




Ho letto il libro “Femminismo per il 99%. Un manifesto” velocemente, e lo sto rileggendo. Tempo fa ho letto anche “Facciamoci avanti” della Sandberg con la critica del quale si avvia il libro in questione. Mi fa sorridere la scoperta dell’acqua calda presentata: ” un femminismo anticapitalista e antirazzista che fa propria la causa ecologista”. Non so se negli USA il femminismo fosse diverso, ma in Italia in femminismo è sempre stato antirazzista, ecologista e aperto a gay e lesbiche, il resto della sigla è arrivato dopo. E in quanto al fatto che storicamente le femministe benestanti/borghesi si siano occupate solo di far migliorare le condizioni dell’1% delle donne, rispondo con questo scritto tratto dall’autobiografia della Kollontaj : “La maggior parte delle donne importanti tra i rivoluzionari marxisti provengono dallo strato sociale superiore; chiaramente l’oppressione della donna nella piccola borghesia e nel proletariato era così totale che nessuna di loro riuscì mai liberarsi dai condizionamenti culturali e comportamentali. Le Luxemburg, le Balabanov, le Kollontaj parlavano il nome di milioni di donne del proletariato contadino e industriale che non erano ancora in grado di parlare a nome proprio. Questo però significa anche che la loro scelta del socialismo e della rivoluzione nella piena coscienza della propria responsabilità sociale era già espressa nella loro comprensione e partecipazione alle sofferenze degli strati inferiori della popolazione.” Quindi a mio avviso, ben venga il femminismo intersezionale, ma si ricordi che poggia sulle spalle delle femministe da cui prende le distanze. Si ricordi poi la fine delle femministe nere che negli Usa hanno fatto da volano ai maschi neri e alle nostre partigiane che già il 25 aprile del 1945 sono state rispedite a casa e alle quali l’onorevole Longo chiedeva ” lavori semplici”.