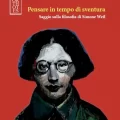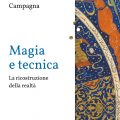Con il gentile permesso della casa editrice Punto Rosso di Milano pubblichiamo la prefazione di Ricardo Antunes al libro di Ursula Huws: Il lavoro nell’economia digitale globale. Il Cybertariato diventa maggiorenne uscito a settembre 2021 nella traduzione di Giancarlo E. Saccoman, a cura di Roberto Mapelli (pp. 206 – €20).
PREFAZIONE di Ricardo Antunes[1]*
 La pubblicazione in italiano de Il lavoro nell’economia digitale globale: il Cybertariato diventa maggiorenne, da parte di Punto Rosso, offre a lettori e lettrici un ricco contributo allo studio della classe lavoratrice in questo periodo, che è il più distruttivo del capitalismo, non solo in relazione alla natura, all’eguaglianza sostanziale tra generi, razza ed etnie, ma anche in relazione al mondo del lavoro. E fu proprio decenni addietro, quando molti studiosi seguivano l’onda della “fine del proletariato” e della perdita di rilevanza della teoria del valore, che Ursula Huws divenne una delle più importanti voci dissonanti in Europa. Remando contro quest’onda, che ebbe molto “successo” inizialmente, ma che si mostrò effimera con il passare del tempo, la Huws presenta in questo suo libro, la condensazione di importanti risultati di studi e ricerche sistematiche sulle reali condizioni di vita e lavoro della classe lavoratrice e, in particolare, del proletariato, che emerge nell’era delle tecnologie di informazione e comunicazione. Presenta prove empiriche raccolte sia nel suolo europeo, quanto in diverse parti del Sud del mondo, seguendo piste analitiche che si contrappongono alla tesi eurocentrica che la “società post-industriale” comporterebbe ineludibilmente la perdita di importanza e di rilevanza del lavoro, che diventerebbe sempre più “immateriale” e “digitale”, facendo così dissolvere la creazione di plusvalore, che risulterebbe così “incommensurabile”.
La pubblicazione in italiano de Il lavoro nell’economia digitale globale: il Cybertariato diventa maggiorenne, da parte di Punto Rosso, offre a lettori e lettrici un ricco contributo allo studio della classe lavoratrice in questo periodo, che è il più distruttivo del capitalismo, non solo in relazione alla natura, all’eguaglianza sostanziale tra generi, razza ed etnie, ma anche in relazione al mondo del lavoro. E fu proprio decenni addietro, quando molti studiosi seguivano l’onda della “fine del proletariato” e della perdita di rilevanza della teoria del valore, che Ursula Huws divenne una delle più importanti voci dissonanti in Europa. Remando contro quest’onda, che ebbe molto “successo” inizialmente, ma che si mostrò effimera con il passare del tempo, la Huws presenta in questo suo libro, la condensazione di importanti risultati di studi e ricerche sistematiche sulle reali condizioni di vita e lavoro della classe lavoratrice e, in particolare, del proletariato, che emerge nell’era delle tecnologie di informazione e comunicazione. Presenta prove empiriche raccolte sia nel suolo europeo, quanto in diverse parti del Sud del mondo, seguendo piste analitiche che si contrappongono alla tesi eurocentrica che la “società post-industriale” comporterebbe ineludibilmente la perdita di importanza e di rilevanza del lavoro, che diventerebbe sempre più “immateriale” e “digitale”, facendo così dissolvere la creazione di plusvalore, che risulterebbe così “incommensurabile”.
Sto immaginando quanto i differenti esperimenti che sono debitori del toyotismo, sia nella sua variante classica giapponese, sia nella sua ibrida versione asiatica, la cinese, siano grati ai difensori della tesi della fine della teoria del valore-lavoro e della conseguente irrilevanza della forza-lavoro per il “sistema di metabolismo antisociale del capitale”[2] nei nostri giorni. Gli amministratori delegati applaudono. Così, il principale contributo di questo libro è offrire un’ampia indagine sulla classe lavoratrice, partendo dall’insieme della produzione globale, dato che lo sfruttamento delle nuove catene produttive di valore hanno globalizzato ancora di più il capitale e il mondo del lavoro, seppellendo le tesi di coloro che sognavano un welfare state con piena occupazione, senza hard work, senza sfruttamento del proletariato e sostenuto da un supposto capitalismo “temperato” e umanizzato dalla “giustizia sociale”.
Il quadro che questo libro quindi descrive è, così, molto differente da quello scenario immaginifico. Esso ci mostra che la fisionomia che va assumendo il nuovo proletariato industriale e dei servizi è quella della crescente precarizzazione delle condizioni di lavoro e di ampliamento smisurato della disoccupazione strutturale, del “lavoro uberizzato” o delle “piattaforme”, che si espande in tutti gli angoli del mondo.
Ursula Huws dimostra, per esempio, che questo proletariato, nonostante si caratterizzi per la grande eterogeneità nella sua “forma fenomenica”, in verità marca anche una forte tendenza nefasta. Si tratta della persistente “omogeneità” (e quindi intercambiabilità) che è presente nel quotidiano delle condizioni di lavoro, malgrado il carattere multiforme delle sue attività. E questo tratto, che va permeando le condizioni di lavoro del nuovo proletariato, non ha altro significato se non quello di intensificare ancora di più le forme di sfruttamento ed espropriazione, che si ampliano nella forza globale di lavoro. Presentando queste tendenze, Ursula Huws, con estrema chiarezza, ha offerto la sua concettualizzazione originale di quello che ha denominato cybertariato.
Dato che si tratta di un ampio contingente di salariati e salariate che è sempre più globalizzato, esso contempla certamente singolarità e particolarità presenti nei diversi paesi, regioni e continenti, che stanno però percorrendo una chiara tendenza universalizzante, ben visibile quando si cerca di capire il lavoro nel Nord e nel Sud del mondo. E questa tendenza accentua sempre più il suo carattere precarizzante in relazione alla “classe-che-vive-di-lavoro”[3]. In questo modo, cercando una migliore comprensione di come si va disegnando la nuova morfologia del lavoro, il libro della Huws affronta un complesso universo tematico. Per esempio, analizza le molteplici interconnessioni esistenti tra classe e genere, lavoro manuale e digitale, riproduzione e produzione del lavoro, e tanti altri elementi empirici e analitici. Accrescere e attualizza così, in questa impresa intellettuale, ciò che già sistematicamente aveva analizzato nel suo fecondo, The Making of a Cybertariat. Virtual Work in a Real World (Monthly Review Press, luglio 2003).
 L’ampliamento dei lavori nelle piattaforme digitali, nell’industria di software, nei call center, nel telemarketing, nella logistica, negli ipermercati, negli uffici, nel turismo e negli alberghi, nei fast food, ecc., sta generando la crescita di un già significativo contingente di lavoratori e lavoratrici – il cybertariato – che eroga lavori sempre più virtuali. Comprendere, quindi, i differenti elementi che configurano nel presente il nuovo proletariato dell’era della cibernetica, dell’informatica e della telematica, è l’obiettivo a cui l’autrice da proseguimento e sviluppo in questo nuovo libro. Una delle formulazioni centrali può essere forse così riassunta: in piena era dell’informatizzazione del lavoro, nel mondo delle macchine, stiano assistendo alla nascita e ampliamento del cybertariato, il proletariato che lavora con l’informatica, nel mondo digitale che, quotidianamente, vive una pragmatica uniformata e modellata sempre più dalla precarizzazione. Nelle parole dell’autrice: «Sostengo che stiamo vivendo in un periodo in cui una serie di fattori economici, politici e tecnologici, che si rafforzano a vicenda, hanno prodotto l’attuale cambiamento radicale nel carattere del lavoro.
L’ampliamento dei lavori nelle piattaforme digitali, nell’industria di software, nei call center, nel telemarketing, nella logistica, negli ipermercati, negli uffici, nel turismo e negli alberghi, nei fast food, ecc., sta generando la crescita di un già significativo contingente di lavoratori e lavoratrici – il cybertariato – che eroga lavori sempre più virtuali. Comprendere, quindi, i differenti elementi che configurano nel presente il nuovo proletariato dell’era della cibernetica, dell’informatica e della telematica, è l’obiettivo a cui l’autrice da proseguimento e sviluppo in questo nuovo libro. Una delle formulazioni centrali può essere forse così riassunta: in piena era dell’informatizzazione del lavoro, nel mondo delle macchine, stiano assistendo alla nascita e ampliamento del cybertariato, il proletariato che lavora con l’informatica, nel mondo digitale che, quotidianamente, vive una pragmatica uniformata e modellata sempre più dalla precarizzazione. Nelle parole dell’autrice: «Sostengo che stiamo vivendo in un periodo in cui una serie di fattori economici, politici e tecnologici, che si rafforzano a vicenda, hanno prodotto l’attuale cambiamento radicale nel carattere del lavoro.
Non voglio qui sostenere che tutto il lavoro sia cambiato. Lungi da me questa idea». E aggiunge: «La mia argomentazione è, piuttosto, che una serie di caratteristiche del lavoro, che in periodi precedenti erano considerate eccezionali o insolite, ora sono date per scontate da una percentuale crescente della popolazione e, in tale processo, sono cambiate anche le aspettative su quale debba essere il comportamento lavorativo “normale”». La più visibile e percepibile conseguenza di questa tendenza, nella quale l’espansione del cybertariato è la più significativa, si trova nella destrutturazione crescente della legislazione che protegge il lavoro, per il complesso della classe lavoratrice, sempre più segnata dalla perdita dei suoi diritti, conquistati nel corso di molti decenni di lotte, processo particolarmente evidente in Italia negli ultimi anni.
Una breve consultazione all’indice de Il lavoro nell’economia digitale globale dimostra la sua ampiezza e ricchezza tematica: la distruzione delle identità occupazionali nell’Economia della Conoscenza; lavoro, identità e divisione spaziale del lavoro nella città del ventunesimo secolo; il sé e la mercificazione dell’attività intellettuale; la globalizzazione del lavoro ed il ruolo dei governi nazionali; la dialettica dell’autonomia e del controllo nel lavoro creativo; la nuova accumulazione attraverso la mercificazione dei servizi pubblici; vita, lavoro e valore. Dato che sono molte le formulazioni dell’autrice, indico soltanto alcuni elementi, tra i tanti che sono presenti in questo studio. Al contrario degli autori che “seppelliscono” la teoria del valore, sia per la perdita di rilevanza della classe lavoratrice, sia per il dominio immaginato di una specie di “produzione immateriale”, senza zavorra materiale, Huws, sebbene riconosca il significativo ampliamento del lavoro digitale o del lavoro non manuale nel mondo capitalistico contemporaneo, dimostra che, quando si concepisce la totalità del lavoro nella sua globalità, presente e in espansione nelle sue attuali catene produttive di valore, dal suo luogo di nascita nella produzione, fino al suo flusso nei diversi mercati globali, la realtà è alquanto differente. Questo anche perché, l’ampliamento esponenziale del lavoro digitale non può rendere invisibile gli incommensurabili lavori “manuali”, che si diffondono specialmente nel Sud globalizzato, dove si trova, è bene sempre ricordarlo, l’ampia maggioranza della classe lavoratrice.
L’obliterazione di questo dato della realtà della cosiddetta “società del lavoro”, per usare la concettualizzazione di Kurz[4], ha fatto sì (e ancora succede) che si sviluppasse l’errata idea che le cosiddette attività “virtuali” fossero azioni autonome e, di conseguenza, svincolate dalla loro immancabile base materiale, dove predominano le attività concrete, che in superficie invece sembrano sparire.
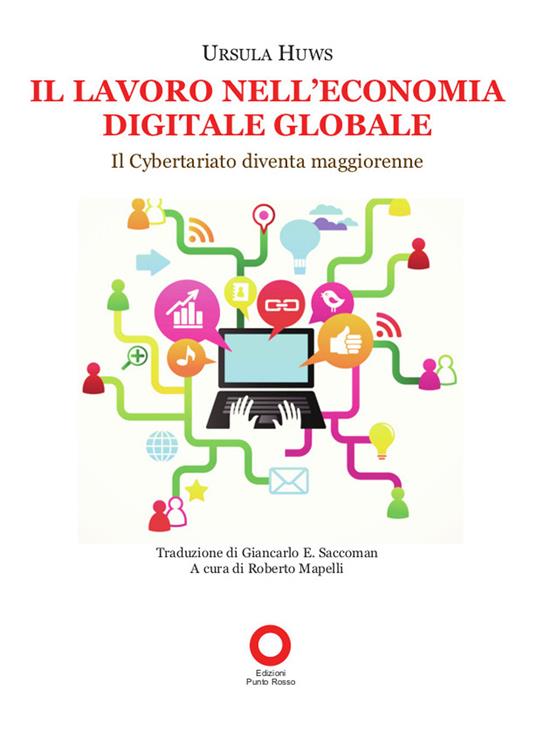 Qui è necessario aprire una parentesi: in pieno XXI secolo, stiamo vivendo un (apparente) paradosso. Da un lato, abbiamo un’esplosione ininterrotta di algoritmi, intelligenza artificiale, big data, 5G, internet delle cose (IoT), industria 4.0, ecc., che potrebbe rendere possibile una riduzione significativa del tempo e della giornata di lavoro, se il sistema di metabolismo socio-riproduttivo non fosse comandato dal capitale, ma, dall’altro lato, dato che il comando vigente non è altro, se non quello, di valorizzare il capitale, lo “spettacolo” a cui stiamo assistendo è invece quello dell’ampliamento della massa che lavora sempre più, 10 o 12 ore al giorno, se non più, per sei o sette giorni alla settimana, senza riposo, senza ferie, con salari ridotti e anche degradanti, senza sicurezza sociale e previdenziale, come si vede, per esempio, con l’espansione del lavoro uberizzato o nelle piattaforme digitali[5]. E questo allo stesso tempo in cui si amplia enormemente la forza-lavoro in eccesso (sovrappopolazione relativa, nelle parole di Marx), che non riesce a trovare alcun lavoro[6].
Qui è necessario aprire una parentesi: in pieno XXI secolo, stiamo vivendo un (apparente) paradosso. Da un lato, abbiamo un’esplosione ininterrotta di algoritmi, intelligenza artificiale, big data, 5G, internet delle cose (IoT), industria 4.0, ecc., che potrebbe rendere possibile una riduzione significativa del tempo e della giornata di lavoro, se il sistema di metabolismo socio-riproduttivo non fosse comandato dal capitale, ma, dall’altro lato, dato che il comando vigente non è altro, se non quello, di valorizzare il capitale, lo “spettacolo” a cui stiamo assistendo è invece quello dell’ampliamento della massa che lavora sempre più, 10 o 12 ore al giorno, se non più, per sei o sette giorni alla settimana, senza riposo, senza ferie, con salari ridotti e anche degradanti, senza sicurezza sociale e previdenziale, come si vede, per esempio, con l’espansione del lavoro uberizzato o nelle piattaforme digitali[5]. E questo allo stesso tempo in cui si amplia enormemente la forza-lavoro in eccesso (sovrappopolazione relativa, nelle parole di Marx), che non riesce a trovare alcun lavoro[6].
L’argomento centrale, che Ursula Huws ha colto nelle sue ricerche realizzate in diversi paesi del continente europeo, è che la riduzione del numero di lavoratori e lavoratrici è in relazione diretta all’intensificazione dello sfruttamento e all’ottenimento di plusvalore (sia relativo che assoluto) alla base della produzione, che si trova specialmente nella periferia del sistema, abbracciando paesi che vanno dalla Cina all’India, passando per Brasile, Messico, Colombia, Argentina, Sud Africa, (senza smettere di indicare qui anche l’Europa dell’Est), dove i livelli di sfruttamento del lavoro sono sempre più intensi e, in alcuni casi, illimitati. Ma è importante rilevare che lo smantellamento della legislazione sociale va a colpire anche il Nord, di cui sono esempio i casi dell’Inghilterra e degli Usa, per non parlare dell’Italia. Questo processo, intrinseco al sistema di metabolismo antisociale del capitale, ha preso forma particolare all’inizio degli anni Settanta, quando siamo entrati in una crisi strutturale[7], che ha convertito la ristrutturazione produttiva del capitale in processo permanente. E’ così che l’avanzamento tecnologico dell’era digitale ha trovato un ampio spazio per la sua espansione: tendenza che si è intensificata a partire dalla crisi del 2008-9, che ha reso possibile alle transnazionali, sempre sotto l’egemonia finanziaria, di avanzare nei loro tentativi di approfondire la “flessibilizzazione” del lavoro, un eufemismo usato per corrodere e smantellare la legislazione protettrice del lavoro.
È stato in questo contesto che le piattaforme digitali hanno potuto svilupparsi e porsi al vertice della piramide del capitale, soppiantando anche molte transnazionali tradizionali. Sono riuscite ad utilizzare alta tecnologia digitale, integrare ampi contingenti di forza-lavoro, che si trovava disoccupata, e a burlarsi della legislazione lavorista, pur esistente nei paesi dove agiscono.
Come rileva Ursula Huws, nessun smartphone, tablet o simili può funzionare senza contare su qualche forma di interazione umana. E basta ricordare che nessun cellulare potrebbe oggi essere prodotto senza ricorrere al lavoro di estrazione, molte volte realizzato nelle miniere cinesi, africane o latinoamericane, che fornisce la materia prima per la produzione. Senza questa e tante altre attività non potrebbero neanche esistere internet, algoritmi, big data, industria 4.0, 5G, ecc… Nel nostro contesto, la tesi centrale di questo libro della Huws, aiuterà molto a comprendere che c’è una connessione indissolubile e basilare tra le attività digitali e manuali, pur nella complessità raggiunta negli ultimi decenni, sia con la divisione internazionale del lavoro, sia con la divisione socio-sessuale-razziale-etnica del lavoro. E questo senza parlare dell’enorme limite di queste definizioni rigide: è sempre bene ricordare Gramsci, quando enfatizzò che non esiste dicotomia profonda tra homo faber e homo sapiens.
Secondo l’autrice, quindi, è necessario ricercare la reale interdipendenza tra le attività che essa denomina di “creazione” e quelle più di “routine”, e che si ampliano nel mondo produttivo virtuale, con i suoi strumenti di comando digitale, software ecc., che si inseriscono sempre più nelle fabbriche, nell’industria agricola, negli uffici, nei servizi, nel commercio, ecc., attività che non potrebbero esistere senza la produzione di merci che hanno origine negli spazi come gli sweatshop della Cina o negli altri paesi del Sud.
Questo che permette a Ursula Huws di concludere che, “senza la produzione di energia, computer, cellulari e tanti altri prodotti materiali, senza la fornitura delle materie prime, senza il lancio di satelliti spaziali per trasmettere i segnali, senza la costruzione di edifici, dove tutto questo è prodotto e venduto, senza la produzione e la conduzione di veicoli che permettono la loro distribuzione, senza tutta questa infrastruttura materiale, Internet non potrebbe neppure esistere e ancor meno essere connesso”.
E questo prova il fatto che il raggiungimento di un’effettiva intellezione del mondo virtuale, degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, ci obbliga a riconoscere che il lavoro digitale trova soltanto effettive condizioni per la sua espansione nell’interazione con il mondo reale del lavoro. Che, non a caso, si trova ad essere sempre più precarizzato, colpito nel suo “corpo-classe” (per usare la bella definizione di Iside Gergeji[8]), particolarmente (ma non soltanto), sia nella sua fisicità, che nella sua soggettività, in specie se si analizza la produzione nel Sud globalizzato.
Qui affiora un’altra importante ipotesi teorica (presente anche nella ricerca di Huws) che contraddice direttamente le tesi della fine del valore-lavoro. Questo perché nell’impresa cosiddetta “moderna”, sempre più liofilizzata (che nella fase dell’Industria 4.0 il capitale denomina mistificatoriamente fabbrica inclusiva[9]), il lavoro che i capitali finanziari bramano è quello sempre più flessibile, la cui remunerazione passa a dipendere dalla produttività, dove i diritti sono sempre più ristretti, l’organizzazione sindacale viene ad essere ostacolata (come abbiamo visto recentemente in Amazon, nel suo impianto in Alabama), e le giornate sempre più lunghe, in una strana confluenza tra i cosiddetti “tempi moderni” e “gli orari antiche”, secondo la bella sintesi di Pietro Basso[10]. Particolarmente nei servizi, sempre più “mercificati”, cioè, più subordinati alla logica della creazione di profitto, emerge un proletariato che partecipa (direttamente o indirettamente) sempre più alla generazione di plusvalore. Questo è il contesto in cui si amplia esponenzialmente, secondo l’autrice, l’utilizzazione delle tecnologie di informazione e comunicazione, non soltanto nelle fabbriche e nell’agricoltura, ma anche negli uffici, negozi, case, conduzione di veicoli, ecc, una volta che molte di queste attività, sempre più digitali, on-line, diventano imprescindibili per la generazione di profitto e di valore. E, dato che queste differenti attività sono realizzate da salariati e salariate, oggettivando la creazione di profitto, è necessario comprendere quelle attività lavorative che si trovano “dentro il nodo” e che, per questo, diventano «direttamente produttrici di plusvalore per il capitale». Secondo la sua stessa formulazione, «se tali attività, per quanto disperse, sono svolte da lavoratori retribuiti, alle dipendenze di imprese costituite per realizzare un profitto, allora possono essere assegnate senza problemi alla categoria di lavoro che produce direttamente plusvalore per il capitale ‘dentro il nodo’». Processo questo, va ripetuto, che accade non soltanto nelle attività industriali, ma anche in agricoltura e nei servizi mercificati. Per questo è importante riconoscere (al contrario della diffusa ed errata tesi della fine della teoria del valore) che stiamo assistendo a un enorme ampliamento delle forme di estrazione del plusvalore, tratto che si evidenzia ancor più con l’esplosione delle piattaforme digitali e del lavoro uberizzato, che aggregano ampi contingenti della classe lavoratrice in tutti gli spazi del mondo.
Certamente, molte ricerche dovranno essere realizzate affinché si abbia una migliore comprensione delle forme contemporanee della teoria del valore. E questo libro di Ursula Huws offre una fertile riflessione che certamente ci aiuterà a decifrare meglio i tanti enigmi che il sistema di metabolismo antisociale del capitale crea e ricrea per continuare nella sua processualità che, se già era distruttiva normalmente, con la pandemia.
- * Traduzione dal brasiliano di Antonino Infranca. ↑
- I. Mészáros, Para além do capital: rumo a uma teoria da transição, trad. por. Paulo César Castanheira e Sérgio Lessa, São Paulo, Boitempo, 2002 [tr. It. Ed. Punto Rosso, Milano, 2016]. Cfr. Anche R. Antunes, Capitalismo virale, tr. it. A. Infranca, Roma, Castelvecchi, 2020. ↑
- Cfr. R. Antunes, Os sentidos do trabalho, São Paulo, Boitempo, 1990 [tr. it. A. Infranca, Milano, Punto Rosso, 2016]. ↑
- R. Kurz, O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial, trad. K. Elsabe Barbosa, São Paulo, Paz e Terra, 1992, [tr. it. S. Cerea, Milano-Udine, Mimesis, 2017. ↑
- Cant C., Riding for Deliveroo: Resistance in the New Economy. Cambridge, Polity, 2019. ↑
- R. Antunes, O privilégio da servidão, capítulo 2, São Paulo, Boitempo, 2018 [tr. it. A. Infranca, Milano, Punto Rosso, 2020]. ↑
- Cfr. I. Mészáros, op. cit. ↑
- Cfr. I. Gjergji, Sociologia della tortura Immagine e pratica del supplizio postmoderno, Venezia Edizioni Ca’ Foscari – Digital Publishing, 2019. ↑
- Cfr. G. A. Pinto, “A indústria 4.0 na cadeia automotiva”. In: Anyumes, R. (Org.), Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, cap. 13, Boitempo, 2020. ↑
- P. Basso, Tempos modernos, jornadas antigas: vidas de trabalho no início do século XXI, Campinas, Ed. Unicamp, 2018 [ed. it. Milano, Franco Angeli, 1998]. ↑_______________________________________
Ricardo Antunes. Ricardo Antunes è professore ordinario di Sociologia presso l’Instituto de Filosofia e Ciências Humanas all’Università di Campinas (Unicamp), in Brasile. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze politiche presso la Unicamp nel 1980 e il dottorato di ricerca in Sociologia presso l’Università di São Paulo nel 1986. Nel 1994 diventa docente di Sociologia del Lavoro presso la Unicamp. Nello stesso ateneo diventa professore ordinario nel 2000. È stato visiting research fellow presso l’Università del Sussex in Inghilterra. Nel 2002, riceve la Cattedra Florestan Fernandes della Clacso e l’anno seguente il Premio Zeferino Vaz della Unicamp. È ricercatore del CNPQ (Consiglio nazionale per lo sviluppo scientifico e tecnologico). È membro del Comitato scientifico del Master sull’immigrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Attualmente coordina le collezioni Mundo do Trabalho della Boitempo Editorial e Trabalho e Emancipação della Editora Expressão Popular. Collabora regolarmente con riviste e giornali in Brasile e in altri paesi del mondo. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Tra questi ricordiamo: Il lavoro in trappola. La classe che vive di lavoro (2006), Il lavoro e i suoi sensi. Affermazione e negazione del mondo del lavoro (2016) e Addio al lavoro? La metamorfosi e la centralità del lavoro nell’era della globalizzazione (2019).Ursula Huws è Professoressa di Lavoro e Globalizzazione presso l’Università dell’Hertfordshire nel Regno Unito. Da molti anni conduce ricerche pionieristiche sugli impatti economici e sociali del cambiamento tecnologico, sulla ristrutturazione dell’occupazione e sull’evoluzione della divisione internazionale del lavoro. Insegna, fornisce consulenza ai responsabili politici e svolge ricerca accademica, nonché scrive e pubblica libri e articoli rivolti a un pubblico più popolare e ha diretto un gran numero di progetti di ricerca internazionali interdisciplinari. Cura la rivista internazionale interdisciplinare sottoposta a revisione paritaria Work Organization, Labor and Globalization e co-cura la serie di libri Palgrave Macmillan/Springer Dynamics of Virtual Work. Il suo lavoro è stato tradotto tra l’altro in cinese, svedese, tedesco, francese, italiano, greco, ungherese, danese, portoghese, turco, spagnolo, hindi, giapponese, coreano, maharathi e serbo-croato. Attualmente sta svolgendo ricerche sul lavoro nella “gig economy” in Europa. Qui un intervista a Ursula Huws di Into the Black Box.
Redazione
Ultimi post di Redazione (vedi tutti)
- APPELLO PER LA SALVAGUARDIA E LA RIGENERAZIONE DEI PAESI - 8 Luglio 2025
- Le case dei sogni. Inchiesta sul turismo nel centro di Napoli - 25 Giugno 2025
- L’entrata in guerra degli USA - 24 Giugno 2025