Pubblichiamo, con il gentile permesso della casa editrice, questo brano dove i due autori teorizzano una partizione sociale che possa sostituire alcune categorie che non sono più attuali. Questa una breve sinossi:
Tramontate le società nazionali, si sono create delle nuove faglie. Al posto delle classi, dei ceti, dei gruppi, si è costituita una nuova triade sociale.L’élite (sempre più in declino), una classe creativa in crescita e una estesa neoplebe molto eterogenea, formata dagli strati sociali più deboli che stanno scivolando in basso e sono a permanente rischio di secessione.
L’attuale configurazione globale delle società ha portato a trasformazioni sociali inattese.Ormai tramontate le società nazionali,si sono create nuove linee di frattura: inclusi/esclusi, cosmopoliti/locali, concentrati/estesi. Si è formata così una nuova triade sociale da analizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo. In questo libro viene misurata con dati sia nazionali che disaggregati localmente, tra Nord, Centro e Sud, tra regioni, province e città. Il quadro proposto raffigura l’Italia tra il 2008 e il 2020, ma ha una proiezione europea e mondiale. Ciò che scopriamo è che in Italia l’élite è diminuita in quantità e qualità, la neoplebe è cresciuta fino a rappresentare la maggioranza della popolazione, mentre la classe creativa è in costante aumento e potrebbe rappresentare la nuova classe dirigente, per ora senza potere. Dati che ci interrogano su questioni attualissime: quale mondo ci troveremo a gestire così polarizzato tra poche grandi concentrazioni metropolitane e immense aree di sfruttamento estensivo? Quali conseguenze sociali e politiche avranno le dinamiche tra una élite in storico declino, una massa priva di sapere e dei saperi senza potere?
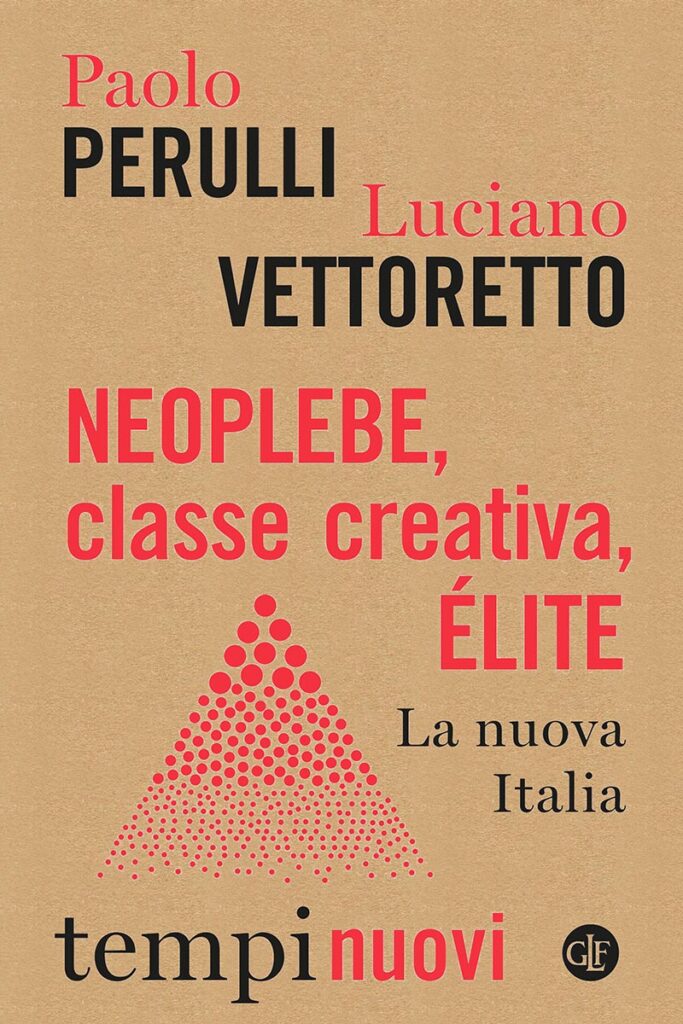
Paolo Perulli – Luciano Vettoretto, Neoplebe, classe creativa, élite, Laterza, Bari – Roma 2022, pp. 208, € 19.00
E questo il brano (pp.3-27)
********
1. La triade sociale
1. Un quadro inedito
La società italiana, come del resto quella europea e occidentale, è cambiata profondamente negli ultimi decenni senza che l’immagine che abbiamo di essa sia stata aggiornata in modo significativo. Eppure, la distanza tra la situazione di oggi e quella degli anni ’80 è impressionante. I lavori di Paolo Sylos Labini (1976, 1985) ne sono il migliore documento. Il grande economista, che nel 2003 previde la crisi finanziaria del 2007-2008 e per primo mostrò la gravità della crescita del debito, compì negli anni ’70 e ’80 la migliore analisi delle classi sociali in Italia. La borghesia imprenditoriale appariva in lieve crescita, passando dal 2% del 1951 al 3% del 1983. Esplosiva risultava essere la crescita delle classi medie urbane che, nel trentennio postbellico, passavano dal 29% al 48%. La classe operaia era stabile, passando nello stesso periodo dal 41% al 43%, mentre i coltivatori diretti crollavano dal 28% al 6%.
Secondo Sylos Labini questa forma della società industriale rifletteva cinque robuste tendenze:
– la riduzione del divario tra stipendi e salari (egualitarismo);
– l’erosione dei profitti delle grandi imprese (perdita di competitività);
– la flessione dell’orario di lavoro (aumento della produttività);
– la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese;
– la crescita dell’intervento pubblico nell’economia.
La sua previsione era che la società evolvesse verso una grande classe media articolata in tre strati di piccola borghesia, composita ma robusta, con gruppi emergenti: intellettuali e scienziati, tecnici e specialisti e quegli “intellettuali di tipo nuovo” di cui parla Antonio Gramsci (1966) con cui la classe operaia avrebbe dovuto tendere ad allearsi.
Se misuriamo queste tendenze con l’oggi, scopriamo che si sono completamente invertite. Le grandi imprese hanno aumentato i profitti oligopolistici, a partire da quelle del web. La divaricazione tra quota dei profitti e quota del lavoro a favore dei primi è diventata esplosiva. I dati su reddito e ricchezza mostrano l’accrescersi della dicotomia tra strato ricco (1%) e strati poveri. L’orario di lavoro è aumentato in ragione della crescita di forme di lavoro autonomo e flessibile che prolungano il tempo di lavoro sul tempo di vita. Le forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa si sono interrotte. L’intervento pubblico nell’economia è regredito lasciando il campo a estese privatizzazioni, almeno a partire dagli anni ’90. La dicotomia garantiti/non garantiti è diventata insufficiente a censire le posizioni deboli presenti in tutti gli strati sociali intermedi e inferiori. Il quadro generale riflette uno scivolamento verso il basso – riduzione media di reddito e ricchezza delle famiglie, nuovi poveri specie di età giovane, aumento record di giovani che non lavorano né studiano, i Neet –, mentre la ricchezza si concentra verso l’alto della scala sociale.
Nonostante questo quadro mutato, usiamo tuttora categorie come imprenditori e dirigenti per qualificare l’élite economica, parliamo di classe politica per lo strato di governo, e poi di ceti medi, di classe operaia, pur verificando che tali classi e ceti si sono sfaldati in modo irreversibile. La loro rappresentazione sfocata va di pari passo con la loro mancanza di rappresentanza.
Dunque, se vogliamo mettere a fuoco il volto della società attuale è necessario aggiornare il lessico. Ci ha provato di recente Luca Ricolfi (2019) introducendo la categoria “società signorile di massa”. Una categoria che coglie alcuni tratti di un fenomeno interessante. Individua correttamente una crescita della rendita parassitaria e del consumo vistoso. Tuttavia, non convince appieno poiché attribuisce il signoraggio a una categoria sociale spuria: una generazione che vive consumando la ricchezza di quella precedente. Di certo, però, contribuisce a spiegare sia l’ascesa sia la caduta della classe media. Ascesa, quando essa insegue la propria promozione sociale mediante il lavoro e l’impresa, cui si aggiungono le rendite rese possibili dal risparmio e dagli investimenti in titoli pubblici, che fino all’introduzione dell’euro sono stati la via dell’alimentazione della classe media. Caduta, quando essa resta vittima della finanziarizzazione e subisce in prima persona gli effetti della crisi del debito. Sappiamo quanto le crisi bancarie hanno impoverito ceti medi e perfino operai e sono di palmare evidenza gli effetti della crisi del debito che ha prodotto la riduzione dei servizi pubblici – istruzione dei figli, sanità e assistenza degli anziani – cui si cerca di far fronte con un keynesismo privato, economicamente rovinoso.
In realtà non è corretto considerare la classe media il baricentro della società, cosa che abbiamo continuato a fare tanto durante la sua lunga ascesa quanto nel suo attuale declassamento. Il quadro sociale è assai più complesso e composito, come vedremo nel dettaglio nelle pagine che seguiranno.
Quello che possiamo affermare fin da subito è che difettiamo di un’analisi a tutto tondo dei nuovi strati che consideri insieme gli aspetti acquisitivi e remunerativi di successo o di declino e il sistema di credenze e valori che sempre accompagnano il loro emergere o precipitare. Vale, intanto, per la crisi dell’élite. Abbisogna di una comprensione l’avvenuta caduta dello spirito del capitalismo, della weberiana razionalizzazione e sistemazione delle condotte di vita dei suoi protagonisti imprenditoriali, delle loro qualità carismatiche. Basta tornare al decennio appena trascorso e valutare la crisi dell’élite economica e politica espressa dalle crisi finanziarie e bancarie dopo il 2008. In questo contesto, l’élite – imprenditoriale e rentier – si è separata dalla classe media, impoverita e impaurita, tornando a una condizione ottocentesca con due zone sociali contrapposte: la città dei nobili e del potere da una parte e quella del commercio e del guadagno a rischio dall’altra. L’élite ha, infatti, mantenuto il suo stile di vita, il suo privilegio immune alle crisi ricorrenti, né ha ricostruito quel tessuto dell’etica professionale, delle ‘buone opere’ che contribuiscono al benessere sociale e della fiducia razionalmente controllata.
Ma questo discorso non vale solo per l’élite, vale anche per gli altri strati. La crisi della classe media che produce e risparmia è, come vedremo, il frutto anche della caduta dello spirito di comunità della borghesia cittadina proprio di una fase di urbanizzazione anomica, estensiva e caotica. Allo stesso modo, l’espansione recente dello strato che denomineremo ‘neoplebe’ è il frutto anche della delusione degli strati declassati nei confronti di una escatologia e di una fede collettiva in un riscatto sociale cui aspirare. Sono nuove forme della distinzione sociale, quell’habitus che riveste gli appartenenti ai diversi strati e li differenzia l’uno dall’altro e che, per essere comprese, richiedono di un lavoro di scavo à la Pierre Bourdieu (ma prima ancora à la Balzac!).
Ancora non disponiamo di buone analisi sul rapporto conflittuale tra i valori e le visioni del mondo dei diversi strati o sul riflesso di quanto accade nel mondo sulla coscienza degli attori sociali. Eppure, l’analisi conflittuale era alla base della sociologia weberiana e simmeliana, per non dire di quella marxiana, tutte in ‘divergente accordo’. Il linguaggio degli interessi di ciascun gruppo o strato era ancorato alla rispettiva Weltanschauung, al proprio punto di vista sul mondo. L’egemonia neoliberale ha rimosso le tracce di tutto questo perché crede che tutti assumano il medesimo punto di vista concorrenziale e agonista: il linguaggio della solidarietà e della coesione, il conflitto produttivo tra agire economico e agire politico, la natura istituente delle diverse azioni sociali sono tutte questioni stralciate e negate dal pensiero unico dominante. Inutile dire che andrebbe invece ricostruito un pluralismo conflittuale in seno alla società. Un pluralismo conflittuale che tenga conto degli interessi di preda di certi gruppi, della rivendicazione di riforme sociali, dell’interesse comune, così come è sempre stato fatto dai classici per le società a noi precedenti.
2. Élite, classe creativa e neoplebe
Quale composizione sociale mostra, dunque, la società italiana attuale secondo la nostra analisi? Anzitutto diciamo quale fonte abbiamo utilizzato per arrivare a tale nuova configurazione sociale.
La nostra analisi si basa sulla rilevazione dell’archivio micro.STAT operata sulle forze lavoro e prende in considerazione il periodo 2008-2020 (dati trasversali trimestrali-microdati ad uso pubblico storici secondo la definizione dell’Istat).
Si tratta di un’indagine campionaria con un grado elevato di numerosità. Al primo trimestre 2020, infatti, raccoglie più di 93.000 interviste, di cui più di 23.000 ad occupati. Partendo dal primo trimestre del 2008, la nostra analisi fa riferimento a una situazione pre-crisi finanziaria e arrivando fino al primo trimestre 2020 comprende la situazione pre-crisi pandemica.
La variabile principale utilizzata è la professione, disaggregata a livello di tre digit, ovvero il massimo livello di disaggregazione possibile e affidabile. Il criterio è il livello di competenza, definito a partire dalla natura del lavoro (manuale, intellettuale ecc.) e dal grado di conoscenza necessario per il suo svolgimento, acquisita per via formale o tramite esperienza.
I livelli di competenza sono quattro, gerarchicamente ordinati. Il primo è quello dei lavori di routine di natura manuale, svolti con mezzi di produzione elementari, spesso legati alla fatica fisica. L’ultimo è quello delle professioni che sono chiamate alla soluzione di problemi o a processi decisionali complessi tali da richiedere un esteso corpus di conoscenze teoriche e pratiche. Le conoscenze e le competenze richieste sono di solito ottenute con un percorso di istruzione pari o superiore alla laurea di secondo livello.
Tali criteri permettono di distinguere la diversa intensità di conoscenza incorporata in ciascuna professione, nonché i livelli di comando e controllo che, in via generale, ciascuna professione esercita sulle altre. Per questa via è possibile leggere le professioni come una forma della relazione non solo economica, ma anche sociale. Queste relazioni sono specchio degli intrecci tra professioni e istituzioni, funzionale in particolare per quelle legate alla formazione o all’ingresso formale in domini specifici (ordini professionali, impiego pubblico). Le professioni sono ordinate secondo livelli crescenti di disaggregazione. Il livello che usiamo nella nostra analisi utilizza 129 classi professionali che aggreghiamo in tre strati principali: élite, classe creativa, neoplebe.
Il primo strato è quello delle élites del potere politico, economico-finanziario e burocratico. Rientrano in questo strato le classi occupazionali legate ai più elevati livelli decisionali (guida, comando, controllo) nelle sfere del governo, dell’amministrazione pubblica e dei servizi di welfare, della magistratura, delle organizzazioni di interessi (partiti, sindacati ecc.), degli imprenditori e amministratori di grandi aziende, dei direttori e dirigenti generali e dipartimentali di aziende. Lo strato delle élites è completato da un sub-strato di occupazioni di controllo e comando locale dei processi di management e direzione, che definiamo ‘strato di servizio’ alle élites. Si tratta dell’insieme delle classi occupazionali che esercitano la razionalità tecnica, con un livello significativo di competenze e supervisione/controllo del lavoro esecutivo nelle diverse sfere economiche e scientifiche: sono, appunto, i tecnici (della gestione dei processi produttivi di beni e servizi, delle attività finanziarie e assicurative, dei rapporti coi mercati, della distribuzione commerciale ecc.). Un segmento spurio, ma di prevalente razionalità tecnica, non creativa, funzionale al controllo e comando delle élites. Questa nostra idea di uno strato del potere e di un sub-strato funzionale ad esso riprende e modifica l’impostazione classica di Gaetano Mosca (1994), che definisce la classe politica dirigente della società e sotto di essa uno strato di servizio funzionale.
Il secondo strato, la classe creativa (usiamo qui il termine classe in senso più ampio introducendo principi diversi dalla posizione economica, e soprattutto quello di ‘capitale culturale’), comprende le classi occupazionali tipiche dell’economia della conoscenza, la knowledge economy orientata alla progettazione, invenzione o ampliamento delle conoscenze negli ambiti della produzione scientifica, tecnica e culturale che richiedono elevati livelli di competenze. Questo strato include specialisti delle scienze ‘dure’, economisti e specialisti di management e finanza, scienziati sociali e delle discipline storico-umanistiche, medici, architetti e ingegneri, le occupazioni a maggior qualificazione nella sfera artistica, culturale e del leisure, e il nuovo segmento dei professionisti indipendenti, gli independent professionals e i freelancers ad alto contenuto di conoscenza. A questo strato si è scelto di aggiungere gli imprenditori di aziende di piccola dimensione nei settori economici knowledge intensive e ad alto valore aggiunto (chimica, farmaceutica, fabbricazione di computer, biomedicale e altri prodotti elettronici, autoveicoli, meccanica di precisione, attività editoriali e di informazione, telecomunicazioni, ricerca e sviluppo, marketing). Questo segmento sta pienamente dentro la knowledge economy, e per questa via esercita impatti rilevanti sul sistema socio-economico nel suo insieme e risulta in genere associato a stili di management e produzione (forse anche a stili di vita) molto vicini a quelli delle attività creative. Anche la classe creativa ha un suo segmento di servizio: come per le élites, si tratta di figure di supporto, di razionalità tecnica applicata alle sfere più propriamente scientifiche e culturali, che richiedono capitale culturale istituzionalizzato ed esperienza. La principale di esse è la figura degli insegnanti, che alimentano l’istruzione e la formazione: in qualche modo forniscono la materia prima della classe creativa.
Il terzo strato, la neoplebe, è una galassia che comprende: i vecchi ceti medi, la new and old petty bourgeoisie, la nuova classe operaia legata ai processi di digitalizzazione e automazione, l’ormai ridotto segmento degli imprenditori della piccola impresa tradizionale, i mestieri tradizionali, il ceto impiegatizio a modesta qualificazione e le ‘burocrazie di strada’, il proletariato dei servizi (e, in misura minore, i salariati agricoli e le mansioni non qualificate nel manifatturiero). Insieme lavoro dipendente e indipendente, manuale e non manuale, protetto e non protetto (soprattutto in relazione alle sfere del pubblico e del privato), occupazioni tradizionalmente maschili o femminili investite, nel corso del tempo, da incertezza, insicurezza, impatti della digitalizzazione, effetti delle migrazioni, declino del prestigio sociale e dell’identità di classe o ceto.
All’interno di questa galassia molto eterogenea si rintracciano gradi diversi di esposizione. Massimamente esposti sono gli occupati nei mestieri e produzioni tradizionali, laddove le loro credenziali educative, esperienze, capitale relazionale e propensione al rischio non li mettono nelle condizioni di connettersi alle nuove domande di consumo (come invece avviene per i ‘nuovi contadini’ o i produttori di beni singolari e/o di lusso). Molto esposte sono le mansioni specifiche del ceto impiegatizio ormai rese obsolete dalla digitalizzazione. Così come in crescita è un proletariato dei servizi sul crinale tra lavoro regolare e irregolare, stabilità e precarietà, sussistenza e povertà, classe e underclass. In definitiva, sono i servants degli strati del potere economico, burocratico o dei creativi, e persino degli strati a medio-basso reddito, in forma di supporto domestico e di cura degli anziani. Di questa galassia è parte, infine, il lavoro operaio. Sono i conduttori e operatori di impianti e macchine, da quelli più tradizionali e in crisi (costruzioni, agricoltura) a quelli investiti dall’innovazione tecnologica: digitalizzazione, automazione, robotizzazione. Un segmento che appare problematico, con modeste capacità di adattamento ai processi socio-economici contemporanei e tuttavia – in particolare nel segmento operaio dell’innovazione tecnologica – non privo della possibilità di stabilire una relazione politico-sociale non subalterna in una coalizione di interessi o in alleanza con la classe creativa nel contesto delle trasformazioni della knowledge economy.
Questa la fisionomia generale dei tre strati. La domanda da porci ora è come si trasmette e, prima ancora, come si forma, come muta nel tempo la visione del mondo di un’élite, di una classe creativa intermedia, di una classe non privilegiata, se non ai margini? È il tema classico della sociologia, eppure disatteso e abbandonato perché sommerso da un infinito, inutile e dannoso predominio dei media che costruiscono stereotipi più che pensiero critico. Proviamo ad approfondire la questione, analizzando, più in dettaglio, la natura, la storia e la composizione di ciascuno strato.
2.1. Élite
Contare, contarsi, annettersi sono per Bourdieu (1988) le caratteristiche dell’élite, la sua ricerca di distinzione e il suo habitus, che si interiorizza e insieme si indossa come una divisa. Sapere di essere al proprio posto, con le proprie iniziali sulla biancheria esteriore e su quella interiore della coscienza, è nelle parole ironiche di Robert Musil (1974) l’attributo della classe superiore. Inoltre, essa possiede un senso del piazzamento, cioè sa porsi, se necessario, al centro della scena pubblica con ogni mezzo. Ma sa, in virtù di quel tratto di riserbo e a volte di segretezza che caratterizza da sempre i detentori del potere, anche ritrarsi e velare la propria influenza e le proprie relazioni. Le reti di cui fa parte sono professionali, lobbistiche, finanziarie, sportive. Sono la connessione e le conoscenze dirette, capillari, di ambienti economici e politici privilegiati a fare la differenza: non tanto la competenza, ma l’appartenenza, l’essere connessi a un sistema interorganizzativo di potere e ‘sentire’ di farne parte (Pizzorno 1970). Le società di consulenza, come ad esempio McKinsey & Company, sono l’officina delle élites. Da lì provengono i dirigenti delle banche, delle compagnie di assicurazione, delle imprese e dei ministeri, coloro che hanno sostenuto senza particolari scrupoli la globalizzazione, certi di trarne vantaggio.
L’élite è sostenuta da ricche famiglie iperprotettive, da una competizione basata sull’accesso a strumenti di potere. L’élite crede e si riproduce in miti, fedi, network, autorappresentazioni. La sua nuova etica è meritocratica. Il merito è uno dei miti, il più diffuso, dell’élite, pur essendo il meno verificabile. Lo spiega bene Michael Sandel nel suo libro The Tyranny of Merit (2020): entrare alla Bocconi o a Sciences Po, o acquisire un Mba a Londra o a Boston è fatto legato al denaro più che al merito. Ciò nonostante è la via maestra per far avanzare un’élite tanto nelle democrazie liberali quanto nelle autocrazie illiberali.
L’autorappresentazione delle élites è affidata a modelli culturali e forme di consumo, insieme ‘vistoso’ e fonte di arricchimento esclusivo (Boltanski, Esquerre 2019). Come risultava già dalle analisi di Thorstein Veblen, un marchio dell’élite è, infatti, il consumo a cui ne è strettamente connesso un altro: il solido senso di sicurezza derivante dall’abitudine a dirigere una grande azienda e a disporre di ingenti risorse finanziarie.
A volgere lo sguardo indietro alla storia, si potrebbe sostenere che l’autocoscienza e il progresso hanno fatto parte del bagaglio occidentale e ideologico dell’élite. In questa direzione ha giocato un ruolo essenziale il rapporto tra élites e chierici, i detentori del sapere e – spesso – sapienti interessati. Nella città occidentale del Medioevo il mestiere dell’intellettuale produceva corporazioni al pari di altre attività economiche, sciogliendo il legame con le scuole cattedrali e con le sfere religiose. Nell’Ottocento le classi della conoscenza prodotta per via accademica divennero anche un segmento di funzionari pubblici. Il nesso tra credenziali educative e formazione delle élites viene rafforzato in Francia e in Germania dove, a inizio secolo, si afferma l’università humboldtiana, come formazione delle classi dirigenti tratte da tutti gli strati sociali (Cassese 1990). Questa autonomia delle istituzioni formative nello sviluppo politico europeo si declina in modo ancora diverso nel Regno Unito, con la riforma di Oxford e Cambridge a metà Ottocento, e negli Stati Uniti dove, negli stessi anni, si afferma il modello del land-grant college da cui nascono le università politecniche come il Mit, con finanziamento federale. Così trova spazio il modello dell’università privata: per prima Harvard, nata per coltivare i ‘nuovi mandarini’, quei Boston Brahmins che hanno dato presidenti, industriali e governatori alla nazione. Non diversamente in Europa: il peso dell’impresa economica, finanziaria e globale, nella gestione dei programmi formativi è sempre maggiore.
Ma ormai l’élite è largamente inconsapevole di un tale retaggio illuminista e borghese. In Italia, soprattutto. Qui, almeno dagli anni ’90 in poi, l’élite economica e quella politica si sono identificate con una variante locale del populismo, che crede nel denaro e nel privilegio come modello ostentato per mettere il popolo, la neoplebe, in condizione di servitù volontaria (Viroli 2010). Nell’acquiescenza di gran parte dell’élite politica, questo modello ha generato un ‘sistema di corte’ i cui premi più diffusi sono il denaro e la cooptazione dei ‘cortigiani’ in incarichi ufficiali e istituzionali. Per un ventennio abbiamo assistito alla progressiva trasformazione dell’Italia in una grande corte (con una correzione parziale a partire dal 2011 dovuta però più a fattori esogeni, quali gli effetti della grave crisi finanziaria, che a virtù endogene).
Così, nonostante la globalizzazione richieda alla politica e all’economia un orizzonte per lo meno europeo e una relazione dinamica con altre élites, tra tutte quelle orientali, noi viviamo la paradossale ripresa di un rapporto padrone-servo che è premoderno e pre borghese, portato di un modello di populismo sovranista.
Del resto, l’élite economica italiana appartiene a una storia minore, di ‘piccolo capitalismo’. Non compare tra i super ricchi del Pianeta, il famoso 1%. Su 100 super ricchi mondiali, 12 sono degli Stati Uniti, 9 della Svizzera e 9 di Singapore, 7 di Lussemburgo e altrettanti del Canada, 6 sono del Giappone, 5 del Regno Unito, 3 della Francia e altrettanti della Norvegia, 2 di Taiwan, Corea, Olanda, Irlanda, Germania, Cipro, 1 di Russia, Brasile, Sud Africa. I restanti Paesi non raggiungono il valore di 1.
A spiegare la natura più introversa e a bassa crescita dell’élite economica italiana è il capitalismo familiare, assai più forte in Italia che altrove. Quello della famiglia è un valore appariscente, a lungo indagato soprattutto dal Censis. Famiglia e borgo, radici locali e piccola scala sono stati esaltati o criticati, a seconda dei punti di vista, come fattore chiave della crescita o della mancata crescita italiana. Giuseppe Berta (2016) ha messo in evidenza che – tramontata la grande impresa dinastica – il capitalismo italiano non può che essere di piccola dimensione, quella studiata da Giorgio Fuà (1980) una generazione fa. Si aggiunge a questo il fatto che non c’è un ricambio della classe dirigente, la stessa da quarant’anni («Dialoghi Internazionali» 6/2007), la quale blocca l’accesso ai media e alla visibilità in generale dei talenti che lavorano a progetti innovativi di grande valore, fungendo da grande cappa generazionale.
La nostra élite è locale, radicata, tradizionalista, non aperta e cosmopolita come accade in altri paesi. Di certo c’è una buona mobilità sovraregionale, soprattutto delle élites imprenditoriali. Tuttavia, le élites imprenditoriali sono molto più che altrove connesse a una località, anche nel caso di grandi imprese multinazionali: Ferrero resta ad Alba in provincia di Cuneo, anche se la sua sede finanziaria e logistica è da tempo in Lussemburgo; Del Vecchio resta nel Bellunese, nonostante il suo impero sia mondializzato nella produzione, distribuzione e finanziarizzazione. Più travagliato è il cammino della Fiat, poi Fca, poi Stellantis, verso un orizzonte globalizzato. Se però prendiamo in considerazione le 3.500 medie imprese del Nord Italia, scopriamo che sono chiari esempi di un ‘capitalismo di territorio’, anche laddove hanno avviato la delocalizzazione delle produzioni in Asia o altrove. Un esempio tra tanti, la Curti Industries. Azienda ravennate di meccanica che opera dalla componentistica all’aerospazio, fondata da un semplice dipendente, ora leader nel settore, che resta radicata a Castel Bolognese per scelta e per cultura. O Bonfiglioli, un gruppo familiare con proiezioni globali, essendo il quinto player mondiale nel suo settore, attivo nella meccatronica dei riduttori e ben radicato nella sua sede bolognese di Lippo di Calderara di Reno, riprogettata secondo i dettami di industria 4.0. Una scelta di fedeltà che in parte si spiega con il fatto che il territorio in cui queste imprese sono inserite è ricco di poli tecnologici, ricerca pubblica, cultura tecnica, istituti professionali. In realtà, secondo Luciano Gallino (1982), abbiamo a che fare con un’identificazione radicata in sottosistemi più interni della personalità (etnica, regionale, religiosa) che massimizza il successo riproduttivo bioculturale dell’individuo, una identità più stabile di quella – elusiva – che passa attraverso l’appartenenza a diverse associazioni.
C’è da dire che l’élite economica italiana che è stata sin qui capace di coniugare progettazione e produzione, disegno e manifattura, ha avuto un’impronta – per così dire – più culturale rispetto ad altre élites nazionali. Su tutti vale l’esempio di Milano: qui si è formata una élite che ha fatto da ponte tra industria e classe creativa, e non tanto grazie al Politecnico e alle altre Università che certamente hanno dato un innegabile contributo, ma che sono istituzioni che esistono in ogni grande città del mondo. Il quid in più cui abbiamo assistito nel dopoguerra (1950-1970) è stato l’incontro tra imprenditore e artista. Ci riferiamo, ad esempio, all’incontro tra un imprenditore del design e della luce come Ernesto Gismondi, fondatore di Artemide, e designer come Gio Ponti, Vico Magistretti, Richard Sapper, persino il regista Luca Ronconi. Non a caso l’Encyclopedie definiva artisti “gli operai che eccellono in quelle arti meccaniche che richiedono intelligenza” (Supiot 2020). Un ponte che si è interrotto, ma che andrebbe ricostruito, tanto più nell’epoca dell’economia cognitiva guidata dal digitale.
La domanda è: può l’attuale élite alzare lo sguardo oltre sé stessa? Nutriamo qualche dubbio al riguardo. Le recenti crisi finanziarie e quelle bancarie hanno evidenziato aspetti oscuri dell’intreccio tra le élites economiche e le élites politiche. Coloro che siedono nei consigli di amministrazione delle banche e delle imprese sono gli stessi che offrono al mondo politico servizi e ricevono consenso e potere di influenza. Persino la filantropia dell’élite, da Bill Gates in giù, serve a influire sulla sfera del potere e a ribadire la superiorità di una rete di interessi.
Mentre un secolo fa il cosmopolitismo delle élites era circoscritto a un club esclusivo di pochi, oggi una densa rete di società di consulenza, imprese multinazionali, finanza e tecnologia avvolge il Pianeta e fa delle società nazionali un ambito troppo ristretto per le élites stesse. Esse perdono il senso dello Stato in nome di credenze globaliste: la tecnologia, l’interconnessione, l’appartenenza a uno spazio cosmopolitico, la città globale ecc.
Questo serve a dirci che l’aristocrazia finanziaria ha preso possesso del mondo, attraverso le banche internazionali, le multinazionali e le società di consulenza – come sostenne per tempo Sylos Labini già negli anni ’70? Sylos Labini ne elencava i settori e le aree: speculazioni edilizie, esportazioni di capitali, petrolio sono le aree del profitto speculativo. Per Karl Marx, che ne scriveva nel 1848-1850, l’aristocrazia finanziaria non era altro che la riproduzione del sottoproletariato alla sommità della società borghese: i suoi guadagni e i suoi piaceri erano malsani e sregolati, come quelli della plebe. Una chiave interessante, questa, per capire la paradossale alleanza tra élite e neoplebe contemporanea. Guardiamo alla caduta del linguaggio della classe dominante: è una cartina di tornasole anche per capire il declino dell’élite economica e politica. Quell’habitus linguistico che si apprende nel mercato specializzato della famiglia e della scuola e si sviluppa con la frequentazione precoce e costante dei mercati specializzati dell’economia e della politica non si manifesta più con la sicurezza e il distacco cui abbiamo assistito nel passato. Il linguaggio dell’élite basato su un’elevata censura, sulla messa in forma e sull’eufemizzazione (Bourdieu 1988), cioè su aspetti distintivi di ‘norma realizzata’, oggi si scompone in un linguaggio dei media di comunicazione che rende tutto indistinto e omogeneo, l’opposto della ‘distinzione’.
In questo linguaggio comune si trova l’estrema conseguenza prevista da Alexis de Tocqueville nella sua opera Democrazia in America, per cui quando gli uomini non più costretti al proprio posto nella società si vedono e comunicano costantemente l’uno con l’altro, tutte le parole del linguaggio si mescolano. Ma Tocqueville riferiva questo fenomeno a una società, quella democratica, che ha abolito le caste e in cui le classi si riempiono di nuove reclute e diventano indistinguibili. L’opposto, quindi, della distinzione di Bourdieu. Questa ‘discussione impossibile’ tra il liberale ottocentesco Tocqueville e il radicale novecentesco Bourdieu mostra come la democrazia si sia nel frattempo imbastardita e immobilizzata. In Italia più che altrove, prima la televisione commerciale e poi i media digitali hanno espresso un livello di volgarità che unifica verso il basso élite, piccola borghesia e neoplebe in un unico metalinguaggio pratico. L’insulto pronunciato in televisione e nei social media, che Bourdieu definisce idios logos, sostituisce l’atto ufficiale di nomina con cui si concede un titolo, che egli definisce homologein. Entrambi, l’insulto e la nomina, sono atti di istituzione o di destituzione fondati socialmente.
D’altra parte, concetti astratti, non visibili, come nazione, Stato, sovranità, democrazia, rappresentanza, burocrazia, che secondo Giovanni Sartori (2000) caratterizzano la cittadinanza libera, sfuggono del tutto a homo videns.
2.2. Classe creativa
Prima dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, l’individuo creativo è il Faust di Goethe, colui che ha un pensiero e una volontà volti a uno scopo. Il suo alter ego è Prometeo, il titano che porta la tecnica utile agli uomini. E da quando è Prometeo a primeggiare è la creazione come impresa tecnica a occupare pienamente la scena.
In sociologia il termine “creativo” è stato introdotto da William Thomas e Florian Znaniecki con il loro lavoro The Polish Peasant in Europe and America (1918-1920). Nella grande trasformazione sociale prodotta dall’immigrazione e dall’urbanizzazione di inizio Novecento emergono tre tipologie di individuo: il filisteo, il bohémien e il creativo. Rispetto ai primi due, rigidamente tradizionalisti o incoerenti, l’individuo creativo trova in sé le risorse per un avanzamento sociale, per la ricerca di scopi definiti, esprime una maggiore capacità di adattamento che lo aiuta ad avere successo nella vita. La personalità più sistematica del creativo lo avvicina all’individualismo strumentale, a colui che domina la società industriale attraverso istituzioni e norme sociali ben precise. Così, il tipo creativo appartiene alla moderna divisione sociale del lavoro e ha la forma di un tipo auto-diretto, rivolto a uno scopo, inserito in istituzioni e agenzie di socializzazione che agiscono in tal senso.
Se le società industriali avanzate hanno prodotto numerosi individui creativi è perché esse favoriscono una personalità acquisitiva e strumentale. Le istituzioni stimolano e premiano l’indipendenza, la competenza, la responsabilità individuale. Questa visione alla Talcott Parsons (1983) spiega bene a nostro avviso perché il tipo creativo americano abbia trovato ampi spazi di prevalenza rispetto a società più chiuse e castali come quelle europee o asiatiche.
Creativo è sin qui un individuo, un tipo: l’inventore contrapposto all’uomo che tira a campare, l’innovatore (che risale al pensiero economico di Joseph Schumpeter), il professionista della conoscenza applicata (un’idea più recente che dobbiamo a Peter Drucker). Ma da qui a diventare una classe il salto è grande. Presuppone una autosostituzione, cioè la trasformazione di un ordine sociale dato o di suoi sistemi parziali ad opera di processi interni (Luhmann 1983). Occorrerebbe che il primato funzionale della creatività di origine tecnico-scientifica e professionale fosse in grado di autonomizzarsi e perfino di sostituire il primato funzionale della società economica avvenuto nella modernità. Il primato funzionale dell’economia è correlato con l’individualismo dell’uomo economico, mentre il primato della società creativa dovrebbe reggersi su un individuo sociale con specifiche caratteristiche.
E allora: quali fattori possono promuovere un tale processo di autosostituzione? In primo luogo fattori di tipo esogeno, come eventi dirompenti esterni a ciascuno di noi che impongono di rivedere le priorità e le scelte di ciascuno. La crisi climatica ambientale globale consente di capire ciò che intendiamo. ‘Noi sapevamo’ (grazie alla scienza e alla tecnica), ma non abbiamo potuto evitare il processo di degradazione naturale in corso. Avremmo potuto farlo solo autonomizzando la scienza e la tecnica, dando ad esse, cioè, il potere di affermare la propria riflessività pratica, scongiurando gli esiti catastrofici cui il primato funzionale dell’economia ha spinto il Pianeta.
Poi ci sono fattori di tipo endogeno. Tecnologia, tolleranza e talento sono stati presentati come i drivers funzionali della classe creativa. I creativi sono aperti, liberal, progressisti. Ma non hanno ancora acquisito una responsabilità che li ponga al centro della vita politica. Non si impegnano in azioni collettive. Questo è quanto sostiene Richard Florida nel suo libro The Rise of The Creative Class (2019), coniando anche la definizione di classe creativa. Ciò anche se rappresenta circa 1/3 delle forze di lavoro della società americana, cui si contrappongono 2/3 di classi di servizio postindustriali, a bassi salari e precarie. Una quantità non troppo dissimile da quanto da noi calcolato per l’Italia.
La ragione è forse spiegata da Tocqueville e illustrata da Jon Elster (2009) con la domanda: “Ci sono classi in America?”. Sembrerebbe di no. Il continuo turnover individuale, la mobilità sociale e geografica non favoriscono la formazione di una ‘classe per sé’ che si impegni nell’azione collettiva. La classe creativa ha un altro padre nobile rivendicato da Florida, quel Peter Drucker che, forte della sua formazione mitteleuropea e poi approdato in America, per primo (nel lontano 1959) definisce il lavoratore della conoscenza come il futuro manipolatore di informazione. Una categoria però sfuggente e – ancora una volta – non una ‘classe per sé’.
Più circoscritta e tecnocratica è la categoria di ‘esperti’, quelli che posseggono cioè una specifica e certificata expertise. Molte teorie li hanno considerati detentori di un potere tecnocratico, scambiando, in realtà, per potere quella che è solo competenza (cum petere, chiedere insieme). I ricercatori e gli esperti hanno rispetto alla classe creativa un profilo più nettamente tecnico, meno socialmente visibile. Anche se da loro dipendono le prossime generazioni di innovazioni, i vaccini che ci salveranno dai virus, le macchine intelligenti che ci faranno muovere in auto a guida autonoma, i prossimi devices che guideranno il lavoro e il consumo di interi continenti.
È dunque vistosa la sproporzione tra il grande ruolo professionale e il più modesto ruolo sociale dei creativi. Se essi rimarranno ‘artisti’ usati dal capitalismo della conoscenza, ‘inventori’ a disposizione del capitalismo delle piattaforme digitali, è difficile immaginarne un ruolo da classe generale. Se invece prenderanno coscienza che la loro capacità di innovare ha un’utilità sociale estesa, di ciò potrà beneficiare anche la neoplebe, la parte più grande e svantaggiata della società. Per assumere tale ruolo il primo passo da compiere è la messa in discussione dell’attuale distribuzione dei diritti di proprietà nelle filiere produttive. Sebbene i creativi, i freelancers, i lavoratori della conoscenza, i fornitori di input siano figure che concorrono alla creazione del valore, allo stato attuale non è loro riconosciuto alcun accesso a diritti di proprietà condivisi. Essi restano in capo alle élites proprietarie e agli azionisti finanziari. Questo il primo, principale interesse da intaccare da parte della classe creativa per ritagliarsi un nuovo ruolo sociale.
2.3. Neoplebe
Non c’è nulla di spregiativo nel termine che qui usiamo. Piuttosto, c’è insoddisfazione per gli altri modi di nominare lo strato basso della società. Sottoproletariato, Lumpenproletariat (proletariato degli stracci) è, sì, termine spregiativo che indica una classe pericolosa. In sociologia il più usato è sottoclasse (underclass). Tutti questi termini presuppongono un sotto rispetto a un sopra: per esempio, la classe operaia che sta sotto e la classe media che sta sopra, o più sopra. Questa è una prospettiva non più attuale, una visione che altera la realtà del processo di scivolamento in corso dell’intera ‘società di mezzo’ verso il basso. Non si possono più confinare i fenomeni della povertà alla sola underclass.
Non più protetta dai sistemi assicurativi e di welfare, certo mescolata a fenomeni diversi come l’evasione fiscale e il lavoro nero o grigio, la povertà affiora dall’intera società. In questo senso la ‘società dei due terzi’, quella garantita, contrapposta a un terzo non garantito, va aggiornata e, per certi versi, rovesciata. Sembra più esplicativa l’idea di “proletaroide” usata da Max Weber (1981) e da Theodor Geiger (1932) nella Germania di inizio Novecento: uno strato che cresce ai margini, ma include la classe media impoverita, il lavoro intellettuale precario e malpagato, accanto al proletariato dei servizi.
Il progresso tecnologico legato all’intelligenza artificiale affiderà alle macchine il lavoro qualificato e ciò andrà a nutrire su larga scala la neoplebe, fasce di popolazione prive di formazione adeguata, di skills e conoscenze oggi necessarie. La tecnologia è selettiva e ingegnerizzata, funziona per le società avanzate, ma rischia di escludere una parte significativa del mondo. Per fare solo un esempio: un tempo c’erano più linee telefoniche fisse a Manhattan che in tutta l’Africa sub-sahariana. Oggi la diffusione di Internet segue la stessa dinamica selettiva. Ecco perché nei paesi avanzati la neoplebe è destinata a crescere.
Ma come si vede e si rappresenta la neoplebe? Finora è stata rappresentata da altri: il pensiero classico e poi quello borghese l’hanno stigmatizzata come pezzenti (Platone) o poveri, Pöbel (Hegel); il pensiero marxista e quello leninista l’hanno elevata a proletariato. Tocqueville parla della ‘razza’ dei poveri come uno strato permanente e fisso, con poche vie di scampo, contrapposto ai ricchi, uno strato fluido i cui componenti sono sempre a rischio di diventare poveri.
“Il lavoro forma”, sostiene Hegel: è il lavoro che permette al servo di uscire fuori da sé e di assumere una permanenza. Ma cosa accade se non c’è lavoro, o esso è esercitato in forme tali da non garantire permanenza ma solo precarietà? Gran parte del lavoro contemporaneo è di questa natura.
2.
Le linee di frattura
1. Inclusi/esclusi
Prima di iniziare l’analisi quantitativa della triade sociale che abbiamo delineato fin qui, è necessario guardare alla trasformazione radicale da cui siamo investiti dal punto di vista delle nuove fratture sociali.
Con lo sfaldamento delle società nazionali del passato, che avevano un carattere stabile e duraturo, e con l’avanzata di nuove società globali planetarie si stanno formando delle nuove falde, degli strati sociali che non corrispondono più a tradizionali classi, ceti o gruppi. Sembra prendere corpo la visione di Friedrich Nietzsche (2000) secondo cui non siamo affatto materiale per una società: lo si capisce guardando da vicino le nuove linee di frattura della società contemporanea.
La prima linea di frattura è certamente quella tra inclusi e esclusi. Non è unanime il giudizio sull’ampiezza di questa frattura. Secondo i sostenitori della tesi della convergenza di lungo periodo, il XXI secolo è più equo e meno diseguale, basta valutare l’uscita dalla povertà di ampie aree del mondo in via di sviluppo. Secondo altri la distanza tra inclusi ed esclusi è, invece, aumentata: le diseguaglianze, le distanze, si sono accresciute rispetto al XX secolo, che aveva visto diminuire le differenze grazie al welfare state, alle politiche sociali e al ruolo dei sindacati. Come ha dimostrato Thomas Piketty (2019), i meccanismi di mercato inevitabilmente producono e dilatano le distanze sociali se non si interviene correggendoli. Lasciati liberi di operare sul lungo periodo non possono che far crescere le disuguaglianze poiché incuranti della platea degli esclusi dal mercato del lavoro, dalla distribuzione dei redditi, dalla ricchezza finanziaria e immobiliare. Se la politica non opera delle correzioni spostando reddito da una classe all’altra, sostenendo i più poveri, redistribuendo la ricchezza, allargando l’accesso alla conoscenza e alla sanità, l’esclusione sociale è destinata a crescere. Guardiamo per un momento a cosa è accaduto al nostro paese dal dopoguerra per intervento politico: negli anni ’60 si ottiene l’istruzione pubblica per tutti ed è dei ’70 la realizzazione di un servizio sanitario nazionale. A partire dagli anni ’80, questo processo virtuoso si è interrotto: neoliberismo e terza via e, negli anni ’90, l’inizio delle privatizzazioni, sono stati fatali alle classi medie e basse della società.
Il risultato su grande scala del processo che abbiamo sinteticamente descritto è stato proprio l’assottigliamento della classe media, quella in cui si riconosceva la maggioranza della popolazione (il 60% secondo molte stime) e a cui aspirava di appartenere la restante parte. Si è assottigliata notevolmente, ed è scivolata verso il basso andando a alimentare appunto un’estesa neoplebe. Contestualmente l’élite, l’1% dei ricchi mondiali, ha aumentato le sue posizioni di vantaggio grazie agli Stati fiscalmente generosi, al predominio della ricchezza finanziaria e delle rendite, al peso della successione ereditaria.
Ma non è tutto. Quella classe creativa di cui abbiamo parlato nel precedente capitolo è anch’essa coinvolta in un processo di inclusione/esclusione. La disconnessione tra sapere e potere è, infatti, il fenomeno emergente del nostro tempo: chi è incluso nella conoscenza non è affatto incluso nel potere, che segue una logica propria, autoreferenziale. Il potere si impossessa del sapere e lo utilizza ai propri fini: l’algoritmo ne è la principale espressione. Quindi, nonostante la sua crescita progressiva, la classe creativa, sapiente ma priva di potere, erede della società civile hegeliana, è messa in una posizione che rende difficile la sua trasformazione in ‘classe generale’. Facciamo un esempio utilizzando la triangolazione che si viene a creare tra proprietari delle piattaforme, providers di contenuti e utenti. Risulta immediatamente evidente che il potere è distribuito in modo asimmetrico: l’utente usa la piattaforma, ma è da essa usato per i dati che fornisce e che sono alla base della profilazione; il provider, dal canto suo, fornisce i contenuti ma è pagato solo sulla base di contratti iniqui (lavoro intellettuale sottopagato e privo di garanzie) (Stark, Pais 2020).
Da questo punto di vista, l’utente delle piattaforme è un caso estremo di ‘servitù volontaria’ nei confronti del dominio tecnico e il provider un caso altrettanto estremo di ‘autosfruttamento’ delle proprie capacità lavorative e cognitive. I diritti di proprietà intellettuale non tutelano affatto i sapienti, ma i potenti, almeno fintanto che una modifica degli intellectual property rights potrà consegnare a chi esercita la conoscenza, cioè la classe creativa, la effettiva titolarità di quanto essa ha saputo produrre. Ma di questo abbiamo già detto.
Che fare? Occorre lavorare per una prosperità inclusiva, come sostengono alcuni economisti. Dani Rodrik e Stefanie Stancheva (2021) ci offrono uno schema semplice e chiaro (tab. 2.1) per correggere il divario tra inclusi ed esclusi, rappresentando la società come suddivisa in tre strati secondo dei criteri più tradizionali dei nostri, ovvero bassi redditi, classe media, redditi elevati. Osserviamolo insieme.
Tab. 2.1. Uno schema per la prosperità inclusiva
| A quale stadio dell’economia interviene la politica | ||||
| Pre-produzione | Produzione | Post-produzione | ||
| Di quale segmento di reddito deve prendersi cura | Bassi redditi | Istruzione primaria, formazione professionale | Salario minimo, apprendistato | Trasferimenti sociali, reddito minimo garantito, politiche di pieno impiego |
| Classe media | Scuola pubblica secondaria e terziaria, formazione continua | Politiche industriali, licenze professionali, training, contrattazione collettiva | Assicurazioni contro la disoccupazione, pensioni | |
| Redditi elevati | Eredità, tassazione di donazioni e di immobili | Crediti fiscali su ricerca e sviluppo, politiche antitrust | Politiche fiscali su redditi elevati, ricchezza, impresa | |
Fonte: Rodrik, Stancheva 2021.
La colonna più importante della tabella 2.1 è la prima, poiché riguarda lo stadio che precede la fase della produzione. È qui che si possono ottenere i più importanti progressi verso una prosperità inclusiva. Una politica pubblica efficace può ridurre l’esclusione sociale e limitare la creazione di bad jobs, di cattivi lavori a bassa o nulla qualificazione elevando l’istruzione e la formazione della neoplebe. Questo strato, infatti, è andato ingrossandosi non tanto a causa del prevalere di mansioni elementari di cura, assistenza, pulizia o produzione, quanto per la mancanza di politiche che elevano la qualità del lavoro, a partire dalla sua qualificazione. Va da sé che un simile processo di educazione, se declinato a livello di istruzione superiore e terziaria (universitaria e post-universitaria), può aiutare la classe media a divenire classe creativa, estendendo e approfondendo la sua capacità di elaborare innovazioni e soluzioni responsabili. Uno studio americano ha stimato che in 50 anni la quota del reddito nazionale che va ai laureati è passata negli Stati Uniti dal 5% al 18%, mentre quella che va al lavoro dequalificato è scesa dal 57% al 40%. È importante tenere presente che, tanto quando parliamo di innalzamento dell’istruzione primaria quanto di quella superiore e terziaria, stiamo parlando non solo di educazione, ma di inclusione nella cittadinanza sociale.
C’è poi da considerare l’effetto che avrebbe una reale politica di intervento sulla ricchezza dell’élite, lo strato sociale superiore. Si tratta di ricchezza ereditata, frutto di rendite, parassitaria, non di ricchezza creata dal lavoro. Negli ultimi quattro decenni, lo squilibrio a favore di questo strato privilegiato della società è pesante.
In questa tabella non viene considerato un aspetto tra i più essenziali ai fini di una prosperità inclusiva: quello dei diritti di proprietà. Includere i creatori di valore – i creativi, i lavoratori intellettuali, gli scienziati applicati – nella proprietà oggi esclusiva degli imprenditori e degli azionisti, rovesciando la prassi dello shareholder value, rappresenterebbe una riforma dell’impresa e del diritto societario di enorme importanza. E includere i lavoratori nella gestione dell’impresa attraverso propri rappresentanti nei consigli (come accade in Germania) o mediante altre forme di partecipazione agli utili (come è avvenuto in Giappone e altri paesi avanzati specie tra gli anni ’50 e’80 del Novecento) sarebbe un potente incentivo per accrescere la produttività sociale dell’impresa – ormai stagnante in molti paesi – e per stabilizzare la domanda di lavoro da parte delle imprese, oggi sottoposta a un eccesso di fluttuazioni e a una frammentazione contrattuale insostenibile.
Ma passiamo ad esaminare la seconda colonna della tabella: quella relativa allo stadio della produzione, quello che ha subìto i maggiori cambiamenti nel passaggio da XX a XXI secolo. Qui si sono affermati quei processi mondiali di dislocazione che hanno portato interi comparti dell’industria a trasferirsi dai paesi avanzati ai paesi arretrati mediante colossali investimenti di capitale. Una neoaccumulazione primitiva ha interessato dapprima la Corea e le tigri asiatiche, poi la Cina, grazie all’enorme afflusso di capitali Occidentali. Un processo che ha modificato per sempre la geografia della forza-lavoro mondiale. In termini concreti: in Occidente si sono persi milioni di posti di lavoro stabili e ben retribuiti nell’industria ed è emersa una neoplebe dequalificata nei servizi; in Oriente è aumentata a dismisura una forza-lavoro a basso costo che lavora in condizioni semi-schiavistiche nelle fabbriche cinesi, vietnamite, malesi, indiane, pakistane, bangladesi nella piena violazione dei diritti umani e sociali.
Precarietà, degradazione del lavoro, nuovi regimi di sfruttamento: questi gli ingredienti qualificanti della ‘grande trasformazione’. Se si vuole seriamente invertire la marcia introducendo forme di stabilità, di qualificazione e di tutela minima universali, il salario minimo è uno degli strumenti per stabilizzare i mercati del lavoro, ma la via maestra per sottrarre il lavoro alla precarietà e all’arbitrio rimane la contrattazione collettiva. Il tanto temuto aumento dei costi del lavoro per le imprese sarà più che compensato da un forte aumento di produttività.
Un ruolo inclusivo rilevante potrebbero giocarlo le politiche industriali di orientamento delle scelte imprenditoriali e di investimento verso produzioni più qualificate e ambientalmente sostenibili. Il carbon footprint, l’impronta del carbonio di un’impresa o di una città, andrebbe esteso all’intera catena globale del valore includendo i fornitori e i paesi in via di sviluppo (come raccomanda il Parlamento Europeo). In questo modo interi settori sarebbero riqualificati e lo spettro delle nostre produzioni sarebbe spostato verso l’alto di gamma. I risultati sarebbero una ridislocazione mondiale della produzione (il cosiddetto reshoring delle produzioni in passato delocalizzate ne sarebbe solo un esempio, perché molti settori nuovi sono ancora da creare) e un aumento della qualità e della affidabilità dei prodotti e dei mercati. A questo si riferiscono, nella seconda colonna della tabella 2.1, i crediti alla ricerca e sviluppo che devono spingere verso queste nuove direzioni tutte le imprese – grandi e piccole – e le filiere – composte di imprese, fornitori, clienti. Inoltre, le grandi piattaforme digitali (ad esempio, Amazon o Google) vanno ricondotte alla logica della concorrenza, grazie a una nuova politica antitrust che, impedendone la concentrazione e il monopolio, persegua non l’ideologia del benessere del consumatore, ma l’analisi strutturale dei settori.
Infine, esaminiamo la terza colonna della tabella 2.1, quella più tradizionale della redistribuzione, che abbraccia le classiche politiche di welfare e le politiche fiscali che dovrebbero riequilibrare, a favore degli esclusi, la distribuzione del reddito e della ricchezza. È il reddito minimo universale l’orizzonte nuovo e necessario del XXI secolo: un orizzonte che davvero può aiutare gli esclusi, quell’ampia neoplebe che si è formata nell’epoca del lavoro automatizzato e digitale. Altrimenti si realizzeranno le peggiori profezie e distopie che da Aldous Huxley (1991) in poi hanno prefigurato una società futura di ‘uomini alfa’ e sotto di loro un iceberg sommerso di individui ‘beta’, ‘gamma’, ‘delta’, ‘epsilon’: la fabbricazione scientifica pianificata di uomini standardizzati (Schmitt 2001) in una gigantesca struttura castale di esclusi che finirebbe per significare la perdita di ogni umanità.
2. Cosmopoliti/locali
Dopo la caduta del muro di Berlino, all’inizio degli anni ’90, si iniziò a parlare di una ‘cultura mondiale’. I più avvertiti osservarono che, a guardar bene, non era in atto alcun processo di uniformazione: semplicemente la diversità si presentava organizzata. Per la prima volta il mondo appariva come un unico network di relazioni sociali e tra le varie regioni – ma sarebbe meglio dire continenti – si era creato non solo un flusso di persone o di beni, ma anche una condivisione di significati (o almeno di conoscenze). Per la verità, erano le città a integrarsi attraverso fitti scambi economici e a costituire una rete di città globali, come hanno mostrato Zbigniew Brzezinski (1970), Saskia Sassen (1991) e poi molti altri. Prima di allora, cosmopolita si definiva colui che scavalcava i confini locali per spaziare in un ambito nazionale. Uno studioso della metropoli come Simmel, a inizio Novecento, si esprimeva in questo senso e più avanti la ricerca di Robert Merton (1957) sui ‘modelli di influenza’ in una media città americana confermava questa visione: cosmopolita era colui che adottava un orizzonte più ampio, quello nazionale, rispetto a chi viveva nel ristretto ambito locale. Tanto che è stato proprio Merton a introdurre nel vocabolario sociologico la coppia di termini cosmopoliti/locali.
…
Redazione
Ultimi post di Redazione (vedi tutti)
- APPELLO PER LA SALVAGUARDIA E LA RIGENERAZIONE DEI PAESI - 8 Luglio 2025
- Le case dei sogni. Inchiesta sul turismo nel centro di Napoli - 25 Giugno 2025
- L’entrata in guerra degli USA - 24 Giugno 2025






