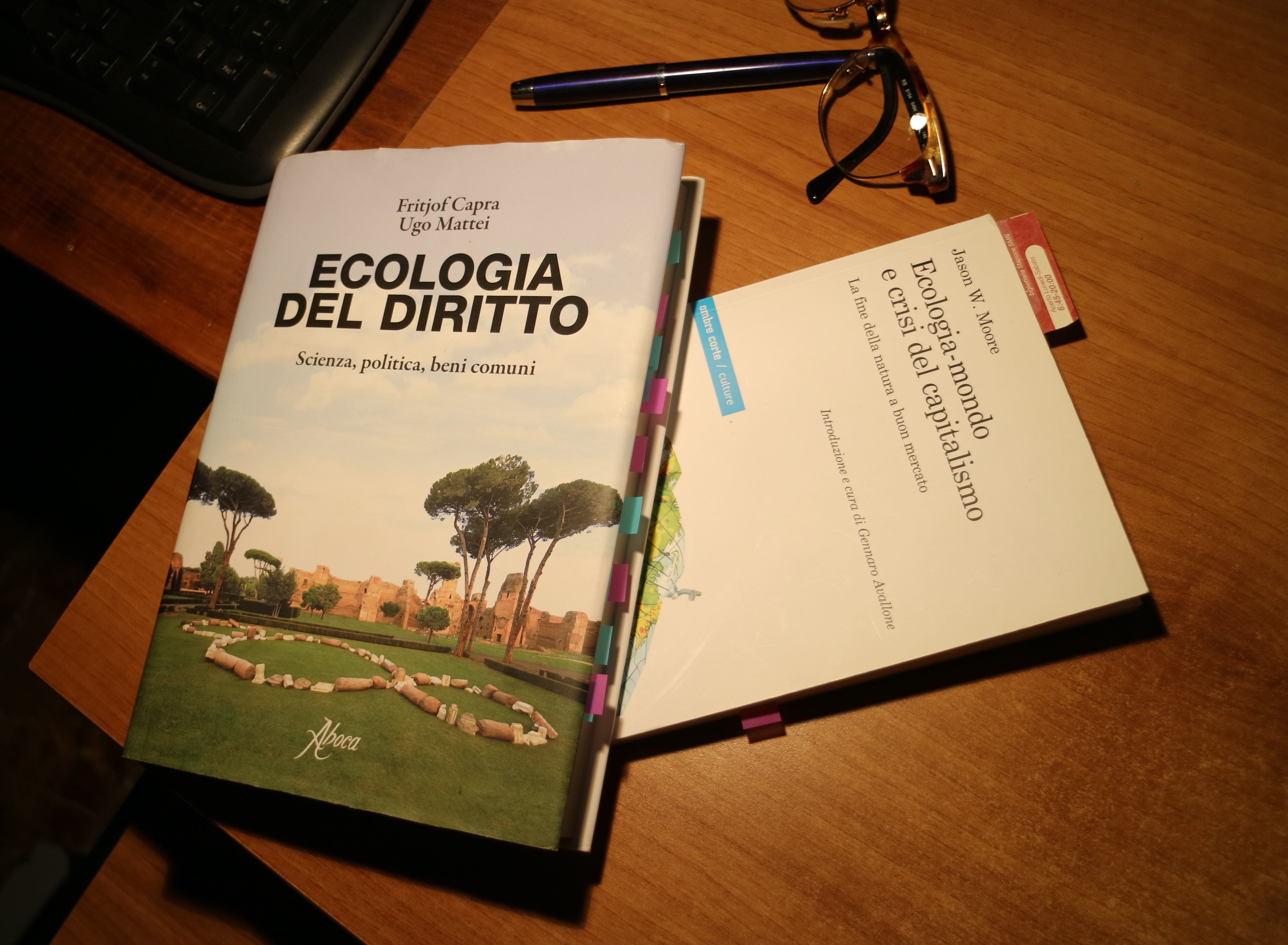Se con diversi degli altri testi da noi recensiti abbiamo visto come il capitale si stesse, tra le altre cose, appropriando dei beni comuni, con il lavoro di Silvia Federici vediamo come la loro ri-appropriazione sia non soltanto un atto dovuto di legittima difesa, ma anche una forma di risposta e di lotta. Beni comuni dunque come strategia da mettere in campo per resistere all’avanzare dei rapporti capitalistici in vista di una vita degna di essere vissuta. Scoprire che il mondo è un luogo ormai del disincanto, trovando però, in questo nuova consapevolezza, le forze e le motivazioni per “reincantarlo”.
L’autrice usa il termine anglosassone di commons che la traduzione mantiene in riferimento a un senso più complessivo rispetto a quelli che in italiano vengono denominati “beni comuni”; data questa puntualizzazione useremo qui beni comuni nell’accezione dell’inglese commons.
C’è una discrepanza, una crepa, una frattura tra il sentire della maggioranza delle popolazioni del mondo e le politiche istituzionali, tra interessi di tutti e egemonia del privato, tra terreni comuni (in senso astratto, ma anche concreto) e espropriazioni-appropriazioni tramite enclosures, quelle recinzioni indispensabili all’accumulazione originaria, che così si rinnova riproducendo il sistema. E in questa crepa, dice Federici, come l’erba che cresce tra quelle del cemento urbano, nascono e devono moltiplicarsi le nostre capacità di cooperazione in difesa dei beni comuni, commons che occorre anche rigenerare ri-mettendo in comune ogni riappropriazione e ogni nuova conquista. Ma non è questa una prospettiva da costruire tutta ex novo, perché è in questa direzione che, a partire dagli anni Novanta, si sono sviluppate innumerevoli lotte. E il punto di vista con il quale l’autrice guarda a queste lotte è globale con esempi dall’Africa, dall’Asia e dalle Americhe.
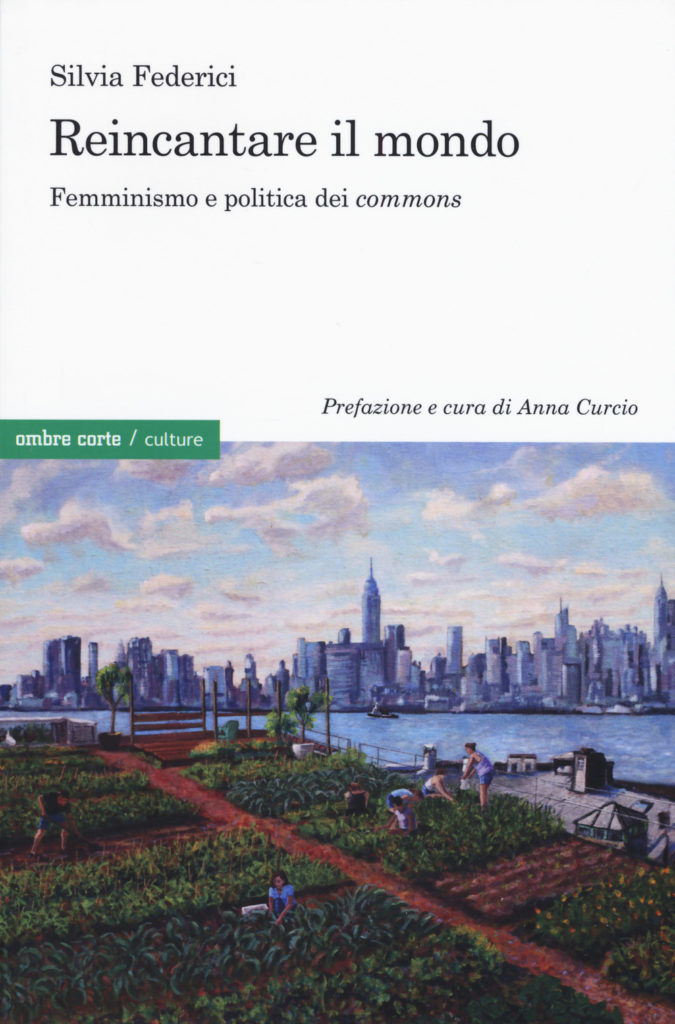
Il testo raccoglie articoli scritti in un lasso di tempo abbastanza ampio, ma i contributi più vecchi non sono “datati”, tendono invece a restituirci un apparato concettuale utile anche per il proseguo della lettura. Così è del concetto di enclosures citato sopra che per Federici non può fare soltanto riferimento al fenomeno delle recinzioni delle terre comuni avvenute in Inghilterra tra il XVII e il XIX secolo, ma a più fenomeni che si ripetono e che hanno in comune la capacità di disarticolare il corpo sociale e la produzione di differenze e diseguaglianze utili al sistema. Pertanto la storia dell’accumulazione originaria non è soltanto quella inerente al lavoro salariato, ma deve essere letta anche dal punto di vista degli schiavi, degli indigeni espropriati e delle tante vittime del potere capitalista che dividendo, isolando, inquisendo, trova gli elementi della sua perpetuazione. È, ad esempio, nel campo specifico della riproduzione della forza lavoro, che emergono le vittime designate di questa operazione: le donne e i loro corpi come dimostrano le altre ricerche della stessa Federici a proposito della caccia alle streghe sia in Europa, sia, in epoca più recente, nelle nazioni colonizzate e cristianizzate (su questo l’autrice aveva già scritto un importante saggio “Calibano e la strega” pubblicato da Mimesis nel 2015). Ma il contributo di Federici non si limita a questa espansione del concetto e dei soggetti dell’accumulazione, tramite essi critica anche gli errori derivati da questo tipo di miopia. Quelli, ad esempio, relativi alle piantagioni statali in Mozambico e le fattorie a conduzione centralizzata in Zimbabwe, che sono state facile preda dei contras non riuscendo a mettere in campo una forte opposizione espletata attraverso il possesso comune delle terre tramite il quale poter esprimere una forma di autonomia e di autosufficienza autarchica. Questo anche a sottolineare la valenza vincente in termini di opposizione e resistenza che i beni comuni esprimono. Bene comune che traduce quindi un potenziale rivoluzionario in sé, diventando strumento e fine di una trasformazione egualitaria.
Anche qui, come per altro negli altri saggi di questa rassegna del pensiero intorno alla ecologia politica, uno dei punti fondamentali è quello di uno spostamento dell’asse principale intorno al quale si esprime la lotta di classe e cioè dal sistema di produzione in generale, a quello della riproduzione della forza lavoro. Elemento questo che è uno dei meriti più fruttuosi del movimento femminista internazionale; perché è qui che si produce vita e resistenza alla sua espropriazione.
Dice giustamente Federici a proposito dell’uso del debito nei paesi africani quale dispositivo estrattivo: «La crisi del debito è un tentativo sistematico di distruggere questa capacità del villaggio e del comune di produrre vita, per sostituirla con la capacità di produrre plusvalore» (p. 67). Ma c’è un capitolo specifico sui rapporti tra comune e debito che, anche per Federici come abbiamo più volte sottolineato, «è usato dai governi e dalla finanza non solo per accumulare ricchezza ma per indebolire la solidarietà sociale e gli sforzi che i movimenti stanno facendo a livello internazionale per creare alternative al capitalismo» (p.90). Il debito diviene allora il luogo in cui le difficoltà e le transizioni economiche assumono anche un carattere moralistico che maschera una realtà profonda per la quale povertà e miseria non dipendono da una mancanza di capitale ma da una ingiusta redistribuzione della ricchezza.
Il contributo femminista alla riflessione sulla riproduzione della forza lavoro è incentrato su una considerazione di base per la quale non possiamo considerare la vita sociale interpretata da un soggetto astratto, universale e asessuato che non risente delle differenze e delle gerarchie insite nella divisione del lavoro, con un discrimine da non poter più sottacere che è quello tra il lavoro salariato e quello non salariato. Non si può cioè ignorare «che nella società capitalista la riproduzione della vita quotidiana sia stata sussunta alla riproduzione della forza lavoro e costruita come lavoro “femminile” non retribuito» (p.159). Elemento questo rivendicato dai movimenti delle donne sin dagli inizi degli anni ’70 del secolo scorso e che ci permette di poter mettere in campo un concetto quale quello di “patriarcato del salario” che non rispecchia semplicemente una rivendicazione di genere, ma che esprime una ennesima contraddizione del capitale.
Occorre poi ricordare i tagli allo stato sociale, quelli ai servizi e in particolare quelli relativi all’istruzione e alla sanità, che hanno riportato nelle case, di nuovo con un carico di genere, i lavori relativi alla cura dei bambini, degli anziani e dei malati cronici. In questo scenario la risposta non può semplicemente essere figlia del conflitto tra capitale e forza lavoro salariato. La lotta, meglio le lotte si devono articolare perciò su fronti i più variegati comprendendo forme di mutualismo e assistenzialismo che hanno però in comune la ricostruzione dei beni comuni; come se – pur potendo apparire poca cosa – si volesse lasciare un segnale che racconta che un altro mondo è possibile e che da subito possiamo iniziare a costruirlo.
Si tratta in definitiva di mettere in atto il potenziale che scaturisce dalla nostra capacità di trasformare le pratiche della vita quotidiana in una lotta collettiva. Si tratta anche di gestire questa nuova consapevolezza per metterla a disposizione delle lotte e delle resistenze. Occorre allora adoperarsi per l’ampiamento della sfera delle conflittualità a partire dai modi della produzione e dal lavoro salariato, per finalmente comprendere tutto l’ambito della riproduzione. A questo proposito, c’è uno splendido XIII capitolo intitolato: “Marx, il femminismo e la ricostruzione dei commons”, dove – in un gioco che va oltre Marx con gli strumenti di Marx – la natura, le donne e i corpi riescono a esprimere, urlare, la loro smisurata voglia di reincantare il mondo.
Abbiamo già parlato dell’azione attuale del capitale che anche e proprio dai beni comuni cerca di estrarre profitto, facendo diventare i beni comuni stessi lo strumento con i quali poter ricostruire le sue fortune, ma il messaggio che il movimento femminista e l’autrice cercano di fare passare è quello che proprio in essi, nella loro difesa, nella messa in atto delle potenzialità anti sistema che essi esprimono, che possiamo trovare un terreno di lotta che recuperi e potenzi l’efficacia delle grandi lotte che la classe operaia ha messo in atto sino a ora.
L’autrice non trascura poi un terreno a noi caro quando racconta il tentativo del capitale di privatizzare lo spazio urbano. «Da Nuova Delhi a New York, da Lagos a Los Angeles […] è sempre più proibito vendere in strada, sedersi su un marciapiede o stendersi in spiaggia senza pagare» (p. 174). Cosa che noi non ci stanchiamo di mettere in evidenza constatando che quello che noi denunciamo non è soltanto una perversione locale o personale, ma un preciso disegno del capitale per questo ben riconoscibile anche da parte di una ricercatrice che pur essendo nata in Italia vive e lavora negli Stati Uniti.
Forse il contributo più originale è quello per il quale si ha che se i commons – i beni comuni – pur essendo sotto l’attacco del capitalismo finanziario e post fordista, la loro conservazione o  riappropriazione possono anche essere uno strumento di lotta, possono cioè essere essi stessi modi alternativi al capitale stesso, almeno come forme transitorie. I commons, non sono cioè soltanto il fine di una lotta contro il capitale, ma ne sono anche i mezzi. In questa chiave, però, i beni comuni devono avere determinate caratteristiche, eccone alcune: i beni comuni non sono dati, ma sono prodotti, perché non si tratta di beni o cose esistenti di per sé, ma frutto di pratiche sociali costitutive. Devono garantire la riproduzione della vita e basarsi sul lavoro collettivo. Si basano su una forma di ricchezza sociale o naturale condivisa utilizzata da tutti e non a scopo commerciale. Non bisogna poi confondere il “comune” e il “pubblico” essendo quest’ultimo gestito dallo Stato e fuori dal nostro controllo. Il comune fa sì riferimento a una comunità, ma non a un’identità, si riferisce in particolare soltanto a quella comunità che si adopera per la sua riproduzione.
riappropriazione possono anche essere uno strumento di lotta, possono cioè essere essi stessi modi alternativi al capitale stesso, almeno come forme transitorie. I commons, non sono cioè soltanto il fine di una lotta contro il capitale, ma ne sono anche i mezzi. In questa chiave, però, i beni comuni devono avere determinate caratteristiche, eccone alcune: i beni comuni non sono dati, ma sono prodotti, perché non si tratta di beni o cose esistenti di per sé, ma frutto di pratiche sociali costitutive. Devono garantire la riproduzione della vita e basarsi sul lavoro collettivo. Si basano su una forma di ricchezza sociale o naturale condivisa utilizzata da tutti e non a scopo commerciale. Non bisogna poi confondere il “comune” e il “pubblico” essendo quest’ultimo gestito dallo Stato e fuori dal nostro controllo. Il comune fa sì riferimento a una comunità, ma non a un’identità, si riferisce in particolare soltanto a quella comunità che si adopera per la sua riproduzione.
Quando Max Weber parlava di disincantamento si riferiva alla scomparsa dal mondo di ciò che è magico, misterioso, incalcolabile, ma anche, sostiene l’autrice, come a una perdita della capacità di riconoscere una logica diversa da quella del capitale. Reincantare il mondo significa per Silvia Federici smascherare le seduzioni apparenti da parte di alcune tecnologie che sembrano ampliare le capacità umane, ma che intervengono sul tempo, rubandoti tempo, stornando il tuo tempo. Per recuperare invece un tempo che possa soddisfare «al bisogno di sole, vento, cielo, al bisogno di toccare, sentire gli odori, dormire, fare l’amore, stare all’aria aperta invece di essere circondati da pareti chiuse. […] Produrre cibo ed esseri umani è infatti un’esperienza e una pratica qualitativamente diversa dal produrre macchine» (pp. 211- 217).
Silvia Federici, Reincantare il mondo – Femminismo e politica dei commons, ombre corte, Verona 2018, pp. 222, € 19.00.
*Gilberto Pierazzuoli
Gilberto Pierazzuoli
Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)
- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024
- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023
- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023