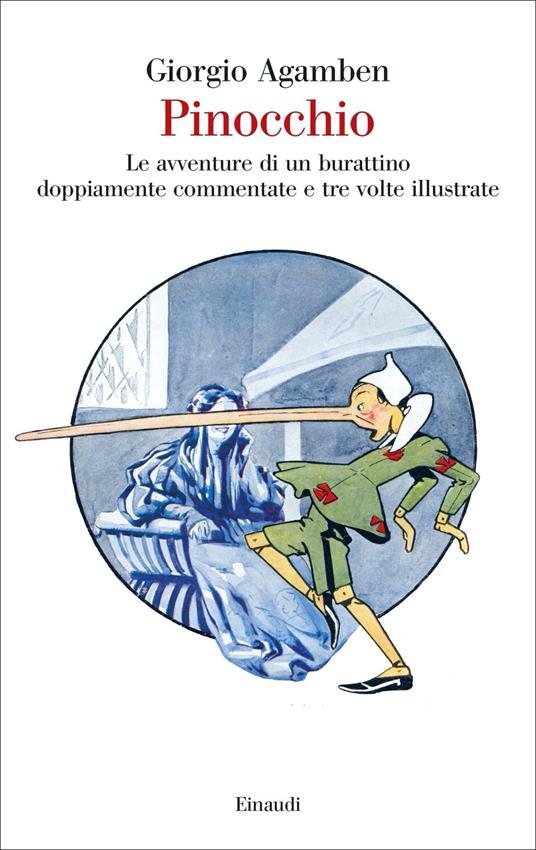Giorgio Agamben, dopo Giorgio Manganelli, ri-commenta Pinocchio. Ma la bocca ce l’avevano messa anche altri, tirando il burattino ora di qua, ora di là di un’ermeneutica del testo volta a suffragare tesi spesso preconfezionate. Un esempio su tutti è la lettura esoterica che ne dà Elémire Zolla per il quale la storia sarebbe l’espressione della cultura della cerchia massonica cui Collodi apparteneva. Il libro sarebbe perciò la storia di un’iniziazione i cui personaggi sarebbero la vulgata di quelli mitologici originali. Una per tutti la fata dai capelli turchini che impersonerebbe Iside.
Dal mio punto di vista invece l’idea di una forma di iniziazione non è così campata in aria e arriva a Pinocchio da lontano. Secondo Propp – l’autore del conosciutissimo testo sulla “Morfologia della fiaba” – le fiabe avrebbero infatti delle radici storiche proprio nei riti di iniziazione. Collodi non era un antropologo ma un autore che stava scrivendo una storia per bambini su un giornaletto dedicato all’infanzia. Così un rimando, anche se indiretto, alla struttura delle fiabe, gli sarebbe potuto venire anche inconsapevolmente. Il fatto poi che il testo venisse pubblicato a puntate permetteva all’autore di correggersi e prendere la mira facendo in ogni puntata “mente locale” in direzione dell’universo fiabesco di riferimento. D’altra parte è vero anche il suo contrario. Collodi con Pinocchio vuole scrivere una storia d’autore e non un’ennesima fiaba con la sua struttura canonica. La straordinarietà di Pinocchio probabilmente è tutta in questo fare il verso a quest’ambito per sperimentare però esiti inediti. Se poi pensiamo alla prima ipotesi di chiusa, il Pinocchio collodiano sarebbe stato una fiaba nera. «La storia di Pinocchio è una fiaba che esordisce negando di esserlo», dice Agamben (p. 12). E in questo movimento di avvicinamento e di allontanamento che il testo collodiano trova le sue ragioni, quasi che l’autore avesse in mente di scrivere un’ anti-fiaba che lo costringeva a fare comunque i conti con l’universo favolistico, le sue strutture e i suoi personaggi. Si ripete qui l’opposizione tra le espressioni delle culture orali con quelle della cultura scritta. Agamben fa riferimento al lavoro di Jakobson e Bogatyrëv per i quali il racconto fiabesco – pur nella sua interpretazione da parte del recitante – farebbe riferimento a un qualcosa di già dato, di già condiviso, in un certo senso alla langue, al codice comune, mentre invece l’autore di un’opera letteraria farebbe riferimento alla parole, alla sua articolazione legata all’uso, letteralmente prenderebbe/darebbe la parola ai propri personaggi che non sono più semplici recitanti ma individui ai quali l’autore mette in bocca il testo. Una polarità, un campo magnetico, tra mito e opera letteraria che condiziona il comportamento di Collodi e che, per Agamben, è unico e riguarda l’immaginazione e la lingua. E se c’è opposizione (polarità) tra mito e letteratura, c’è anche, nello stesso tempo, una relazione di debito. Per Kerényi il romanzo antico avrebbe infatti un rapporto genetico nei confronti dei “misteri”, i rituali iniziatici, espressioni, figurazioni, non tanto di un culto ma della vita stessa in qualunque modo essa si dipani (la stessa posizione che Agamben aveva sostenuto in un altro cammeo interpretativo, quello della Kore).
E l’oscillazione, l’ondivagare di Collodi puntata dopo puntata, prosegue tra presenze mortuarie e spinte vitalistiche. «Lo statuto della morte nella fiaba di Collodi è equivoco e controverso: tutti o quasi i personaggi sono insieme vivi e morti come le ombre dell’Ade pagano […]» (p. 32). D’altronde lo statuto esistenziale di Pinocchio costituisce proprio quell’ente di confine tra materia inanimata e quella biologica sui quali si basa il perturbamento originario e caratteristico della dimensione umana. Burattini e marionette animati ma non vivi eppure, appunto, non inerti. Burattini, marionette (oggetti spesso sinonimici), ma anche giocattoli: oggetti “inutili”, attrezzi che sfuggono alla loro destinazione d’uso, oggetti che si ostinano a perseguire la propria inutilità. E non ditemi che i giocattoli sono utili, certo, ma sono attrezzi di un’umanità infantile, etimologicamente “senza parola”. E Pinocchio più che un bambino mancato, un bambino incompiuto, è probabilmente un giocattolo prestato alla scrittura dove dimostra la sua indole nel momento in cui la scrittura stessa si presta all’intrattenimento. Giocattolo che usa la bocca non per parlare ma per ridere e fare linguacce; che usa gli arti appena sbozzati per rubare la parrucca a Geppetto e i cui primi passi sono quelli della sua fuga dalla casa che Collodi chiama “paterna” quasi a sottolineare l’ambiguità esistenziale e sostanziale del burattino, che poi si complica in «un inqualificabile ibrido fra il tipo della Commedia dell’arte e il personaggio di un romanzo» (p.65).
L’ipotesi di essere dei burattini in mano a entità creatrici divine o aliene è un nodo topico dei racconti di fantasia, della sci-fi dove siamo soltanto enti virtuali che animano una simulazione al computer o, in ambito fantasy, vittime di un incantesimo che ci obbliga a ubbidire. Pinocchio non è fautore del suo destino e soltanto il finale – con le buone azioni volte a conquistare la rinascita – lo vede esserne interprete e non vittima. D’altronde il prototipo è antico: «L’assimilazione dell’uomo a una marionetta è un ricorrente tema platonico» (p.59) dice Agamben e il burattino ha un che di sostanzialmente “meraviglioso” (il thauma che Platone associa al burattino), che poi rimanda a quello spiazzamento di chi vede della materia inerte animarsi. Una meraviglia che per essere mantenuta assegna a Pinocchio un destino nel quale il burattino non può assurgere a una identità definita. E la materia animata ha poi la possibilità di eseguire compiti in maniera così precisa che segnano la sua appetibilità o il suo contrario. L’automa esente da errore, l’automa così tanto esente da errore da mancare di grazia, di affettazione, in un gioco di attrazione e rifiuto che segna il destino della marionetta da Kleist a Hoffmann. Pinocchio è un manufatto umano peraltro fallace e bugiardo. Pinocchio – e il suo destino sciolto dalla incarnazione che però segna obbligatoriamente la fine della storia – è il nodo, la proiezione e il capro espiatorio della condizione umana che oscilla tra materia e spirito, tra animalità e divinità.
Anche gli ambienti sono polarizzati ma non c’è l’inferno della condizione materiale dell’essere legno del burattino contrapposto con il desiderato e quindi desiderabile mondo edenico dei bambini in carne e ossa, ci sono l’inferno delle sventure mondane e il paradiso del paese dei balocchi. Ma anche di quest’ultimo il burattino è defraudato, è un paradiso a tempo: dopo un po’ la metamorfosi in asino fa crollare il meta balocco. I giochi infatti avvengono tutti in un luogo ben definito: nel regno del “si fa finta”. Ma la disillusione, il disincanto, non è provocato dai giocatori, è il frutto di un processo narrativo e della periodizzazione della festa. Il tempo della chiesa, la sacralità del tempo è circolare, il tempo del mercante è lineare, è un vettore che punta in avanti e in alto. La festa e il paese dei balocchi non sono segmenti di un tempo lineare, sono picchi dell’onda relazionale che fonda le comunità. In Pinocchio (nel testo) non ci sono comunità se non quelle dei teatranti del circo di Mangiafuoco e di qualche combriccola di delinquentucoli che popolano le osterie. Il testo è infatti anch’esso un luogo così “per finta”. Il mondo è fuori e può accogliere soltanto burattini in carne e ossa. Per questo il paese dei balocchi viene strappato da sotto i piedi a Pinocchio e dai suoi amici, Lucignolo in primis.
La trasformazione in ciuchi di retaggio scolastico non rimanda i nuovi ciuchi nel paese dei balocchi, semplicemente lo fa sparire sostituito dal suo opposto: un mondo dove si lavora e dove ai ciuchi tocca il lavoro pesante e le frustate. Nel mondo educativo delle Stregofate e dei Grilli parlanti, invece della cuccagna dilagante in ogni paese dei balocchi, c’è infatti: «un pane di gesso, un pollastro di cartone e quattro albicocche di alabastro, il tutto servito in un vassoio di argento» (p.114). Un pasto “per finta”, sublimato nella forma, ma questa volta punitivo.
Il tempo della festa è finito e inizia il tempo dell’operosità. Agamben, sulla scia di Levis Strauss, fa un ragionamento che in una certa chiave non condivido. Probabilmente si tratta soltanto dell’accezione di un termine. L’autore contrappone gioco e rito dove il rito crea il calendario e il gioco lo scombussola: «Entrambi intrattengono un rapporto decisivo col calendario e col tempo, ma mentre il rito fissa e struttura il calendario, il gioco, al contrario, lo scombina e distrugge» (p. 121). Ma la ritualità rimanda alla festa e questa è fatta di gioco. È il lavoro come concetto oppositivo alla festa che cerca di estirpare il gioco dai contenuti festivi. È quello che intende anche Han nel suo: “La scomparsa dei riti” dove, per rito, intende non le abitudini, ma il succedersi calendariale delle feste. Di quella sacralità che fa da condimento al divenire del tempo che è fatta della stessa materia dei giochi e della creazione artistica, tutte attività il cui contrario è la fatica del lavoro, il suo dis-piacere. Il paese dei balocchi è al di fuori del tempo, perché nel paese dei balocchi è sempre festa. È un luogo impermeabile al tempo del lavoro. Un luogo dove il ritualismo calendariale ha come orizzonte il mito di un Eden a misura d’uomo. Un Eden materiale e immanente la condizione umana e la ricerca del piacere. E il gioco non è una forma di profanazione o, al limite, lo è ma di profanazione del sacro dogmatico, non del simbolico. Il gioco duplica simbolicamente il reale attraverso il suo “fare finta”. Si nutre di doppi, di avatar; crea simulacri infondendo valori simbolici alle cose. Dove per simbolico si intende quel mettere insieme, quel raccogliere, contenuto nell’etimologia del termine, come per allargare il loro alone semantico. La festa – e quindi il gioco come contenuto della festa – non è la fissazione del calendario, ma la possibilità della sua ripetizione.
E anche intendere il gioco come memoria lacunosa del sacro, dove ogni gioco sarebbe la parte rituale di un mito del quale si è perso il senso (p. 124), può portare a mistificare il gioco. Forse è il contrario: è il gioco che è mitopoietico. Il gioco quella attività senza scopo, al di là dei bisogni, che marca il senso della vita degli umani che si dovrebbero adoperare per fare un calendario come quello del paese dei balocchi. Un luogo dove il Giovedì e i giorni festivi (il sabato e la domenica) non si va a scuola (e, per estensione, non si lavora) e dove di Giovedì ce ne sono 5 alla settimana. Che è diverso da dire che è un posto dove è sempre festa. Questo è così per il calendario, perché anche la prossima settimana sarà così. Così il prossimo mese e il prossimo anno. È il gioco che fonda il calendario degli umani, ma non quello dei mercanti. «Il paese dei balocchi è un paese i cui abitanti sono occupati dalla mattina alla sera a celebrare riti, a manipolare oggetti e a compitare formule sacre, di cui però hanno felicemente dimenticato il senso e lo scopo» (pp. 124-125). E qui Agamben mette quel “felicemente” che decostruisce la smemoratezza. Non è infatti mancanza di memoria, ma è il suo spostamento su quel piano ludico che è “il fare finta”. Potersi permettere non soltanto di evocare ritualmente una condizione meno oppressa, ma adoperarsi per cercare di viverla. Ecco il sogno relativo al paese di Cuccagna «in questione in questo sogno è una libertà senza limiti appunto perché maccheronica e una felicità tanto più incondizionata quanto più giocosa e senza obblighi calendariali» (Ibidem). Anche qui ci sarebbe il contrasto tra due modi di intendere il calendario, chiarito il quale, le mie letture si allineano a quelle di Agamben.
Ecco infatti l’aprirsi a un’altra temporalità: la temporalità del giocattolo: «Il balocco, questo oggetto familiare e a un tempo inquietante […] è il testimone di quest’altro mondo e di questa altra temporalità: qualcosa che ha appartenuto – una volta, ora non più – alla sfera del sacro o dell’utile economico». Dove si ricorda che «l’ “una volta” e l’ “ora non più” sono contemporanei, coincidono integralmente nell’istante del gioco» (p. 126). L’una volta, ora non più svela anche l’impertinenza dell’oggetto. «La constatazione di una mancanza di questo genere, in quanto esperienza del non utilizzabile, scopre l’utilizzabile in un certo essere-soltanto-semplicemente-presente. Nell’esperienza della non utilizzabilità, l’utilizzabile si presenta nel modo della importunità. […] Esso si rivela solo come semplice presenza e tale da non poter sopperire alla mancanza di ciò che manca […] ma anche come non utilizzabile che non manca e non è inidoneo, ma che, rispetto al prendersi cura, è “fra i piedi” come un ostacolo» (Heidegger, p. 100). È quello che Agamben chiama il lato “inquietante” del giocattolo, quell’oggetto che ha perso, ma forse, ancora meglio, che ha così conquistato una sua indipendenza dall’utile. È per questo che i bambini non amano i giocattoli troppo strutturati, quelli che richiamano una funzione d’uso specifica. È per questo che i bambini rompono volontariamente i giocattoli. Il giocattolo è allora ed infatti quella cosa che si presta a far finta di essere questo o quest’altro.
Il burattino sarà infine sottoposto a un processo di ominazione. «Nella nostra cultura è, infatti, incessantemente al lavoro una macchina antropologica che distingue e, a un tempo, connette e articola strettamente insieme l’animale e l’umano, la natura e l’esistenza storica. La macchina definisce l’umano sospendendo e catturando dentro di sé l’animale irrazionale e, inversamente produce l’inumano circoscrivendo puntigliosamente l’uomo parlante» (p. 152). Ma in Pinocchio, nella sua fiaba, la macchina viene metodicamente sabotata tanto che le distinzioni tra umano e animale si perdono o si ingarbugliano – Agamben gioca l’opposizione tra ligneo e silvano – per un finale nel quale non c’è una metamorfosi ma una specie di transustanziazione, una epifania di un nuovo soggetto matericamente diverso. Il burattino, materia inerte miracolosamente e inquietantemente animata e parlante, non si trasforma in un bambino. Semplicemente le due anime, quella cosale e quella umana, si separano tanto che il Pinocchio bambino può dare un’ultima occhiata al burattino ora inerme in un angolo della stanza.
«Il burattino non è una terza natura, che le appaia e connette – è, piuttosto, soltanto un vuoto, un varco fra di esse, in cui si infila e sgattaiola lesta una natura né naturante né naturata, un’ innaturalezza perpetuamente innaturata e insostanziale, per la quale i nomi ci mancano e continueranno – fino a quando ancora? – a mancarci» (p.155). L’universo Pinocchio contiene il burattino, gli animali e gli umani. La cosalità macchinica della marionetta eterodiretta dagli umani, gli animali parlanti equamente divisi tra “scherani grilleschi” e “affabili sodali”, dice Agamben, con poi gli umani dalle sfumature magiche e ctonie come la fata bambina. Il burattino non è allora «una sostanza, né una persona – una maschera – non è un “che”, ma solo un “come”: è, nel senso più stretto della parola, [allora] una via di uscita o di fuga» (p. 157).
___________________________________
Martin Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976.
Giorgio Agamben, Pinocchio. Le avventure di un Burattino doppiamente commentate e tre volte illustrate, Einaudi, Torino 2021, pp. 167, € 20.00.
Gilberto Pierazzuoli
Gilberto Pierazzuoli
Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)
- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024
- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023
- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023