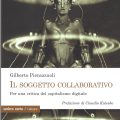Il Tecnocene non è un’era geologica, ma l’articolazione contemporanea dell’Antropocene. O, per essere più fedele all’autore, il tempo che sembra sostituire l’Antropocene nel quale “la nozione di artificiale e di post umano si presenta sempre di più in alternativa a quella di essere biologico e antropomorfo” (p. 11). Un tempo che non contrasta con i possibili esiti disastrosi delle scelte che caratterizzano l’Antropocene stesso ma che, proseguendo sulla propria strada, gli lascia via libera.

Siamo di fronte a due partizioni, due scale temporali diverse. Cosa che, d’altra parte, era stata già percorsa in una prospettiva diversa da Chakrabarty per il quale la critica al capitalismo, seppur necessaria, sarebbe insufficiente per comprendere a pieno l’epoca degli sconvolgimenti ambientali, perché costringerebbe l’interpretazione storiografica a un approccio ancora una volta centrato solo sull’uomo e non sulla storia profonda della Terra e della specie umana. Presa di posizione discutibile ma non per questo vuota di esiti positivi. Ma la prospettiva di Grossi guarda in un’altra direzione. Da una parte c’è il macro problema ambientale, dall’altra delle forme sociali insoddisfacenti e profondamente criticabili perché veicolano ingiustizia sociale, marginalizzazione, discriminazione, sopraffazione che il modello di sviluppo digitale non solo è incapace di contrastare ma che, in qualche modo, riproduce e amplifica, aprendo la strada anche agli esiti più nefasti che la crisi ambientale comporta. In questa chiave si parla spesso di cambio di paradigma per l’analisi e la descrizione di quelle trasformazioni antropologiche prodotte dal sistema e in questo il lavoro di Grossi è fondamentale.
Il progetto tecno-scientifico attuale che passa per la digitalizzazione del mondo, crea una trasformazione profonda dell’antropologia umana; una accelerazione della co-evoluzione che sostituisce l’umano nella governance sociale con le macchine digitali. L’ibridazione biomacchinica dei cyborg contemporanei viene così tutta spostata dalla materialità biologica a quella silicea. Serve per questo una nuova sociazione bio-tecno-sociale contro l’iper-evoluzione digitale, non tanto e non solo per i danni che questo uso della tecnologia provoca, ma anche e soprattutto perché lascerebbe via libera alle minacce catastrofiche che un uso scellerato delle tecnologie ha provocato. Dietro alla critica puntuale e puntigliosa che l’autore fa alle ideologie iperevoluzioniste e iperprogressiste ci sarebbe infatti questo convitato di pietra: un disastro che metterebbe a repentaglio la stessa sopravvivenza della specie. In questo l’autore individua un’urgenza tanto da mettere in primo piano un elenco di pratiche per riuscire a scongiurare sia la tragedia ultima, sia le ingiustizie attuali. Per questo il soggetto che dovrebbe mettere mano a questi cambiamenti rimane indefinito, nel senso che quelli che individua Grossi sono problemi avvertiti e subiti dalla maggioranza della popolazione tanto da doverla, in ultima istanza, interessare tutta. Personalmente, anche dal punto di vista più pessimistico, non vedo così probabile l’estinzione totale della specie – forse quello di molte altre specie – ma un esito distopico dove pochi ricchi, con la loro corte di tecno-scienziati, vivranno in roccaforti accoglienti mentre il resto della popolazione vivrebbe in un ambiente tossico, sterile e ostile. Un orizzonte alla Mad Max oppure simile a quello del film Elysium. Per questo le raccomandazioni dell’autore paiono a volte dei ragionamenti etici che rimanderebbero più “alla buona volontà” che non a un soggetto impegnato politicamente che individua e contrasta il suo avversario. Nel libro non si parla di lotta di classe se non immaginandoci una classe così tanto estesa da essere onnicomprensiva. Non per questo si fa mancare critiche severe all’attuale sistema individuando poi come più perniciosa la svolta digitale dello stesso: “[…] è indispensabile non solo cambiare il modello di sviluppo globale ma soprattutto impedire che la rivoluzione digitale alimenti e favorisca l’enchancement [il suo rinforzo] cancellando l’emancipazione e promuovendo una esistenza non solo extra-terrestre ma anche anti-terrestre” (p. 96).
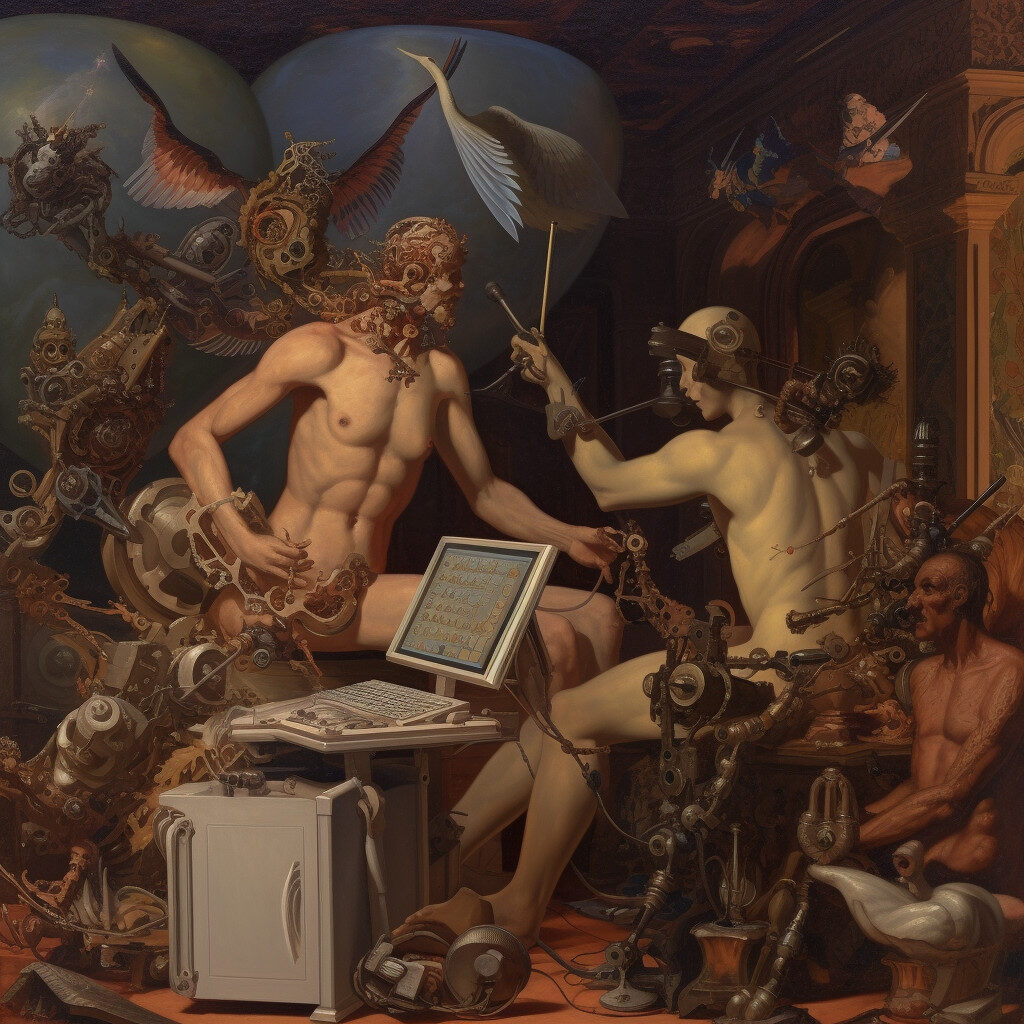
Sì perché un soggetto c’è e Grossi lo prende in prestito dall’ultimo Latour: ecco il Terrestre con l’iniziale maiuscola. Un soggetto ibridato che non si pone al centro e in cima alla piramide evolutiva, Grossi parla continuamente di co-evoluzione; non un soggetto antropocentrico ma un ibrido che incorpora materiali sia organici che inorganici; un cyborg particolare, situato e non astratto dal contesto, un terrestre-inforg. Ecco, tra le altre cose, l’embricatura, una forma particolare di ibridamento. Il Sapiens è sempre stato anche “artificiale”, dice Grossi. Ma, in questo caso, l’artificiale non è soltanto qualcosa di esterno, oggi è soprattutto interno. Forse è qui che si manifesta la presa sistemica del piano cognitivo ed è qui che il concetto di embricatura lavora rallentando e supervisionando il processo di metamorfosi del soggetto. Si tratta di complementarietà e non di surrogazione, sostituzione, siliconizzazione e automazione. Questo cambia anche gli ambiti nei quali agisce il politico che non è più soltanto la polis o lo stato, ma è diventato “l’intero ambiente materico e, perciò, il nuovo attore politico di questo secolo non è più il tradizionale animale politico [zoon politikon, Aristotele] ma, come lo abbiamo chiamato in precedenza, è il terrestre-inforg” (p. 103). Situazione che apre a una nuova formulazione dell’agency politico che Grossi chiama cosmo-politica. Riprendendo il fortunato termine adottato da Isabelle Stengers.
La cosmo-politica deve non solo allargare il campo di azione ma riconfigurare gli stessi obiettivi della lotta politica come percorso inclusivo e trasversale a tutte le entità organiche e inorganiche (il politico soprattutto come common cosmico) al fine di garantire non solo la sopravvivenza della nostra specie ma anche di emanciparla e svilupparla per migliorare la vita di tutti gli esseri viventi e del mondo intero nel quale tutti costoro esistono e si trasformano. (p. 128)
Grossi, in un excursus minuzioso e ricco, esplora il condizionamento digitale della vita, i lati negativi della digitalizzazione del mondo asserviti alla massimizzazione del profitto da parte di pochi a scapito degli interessi di molti: fa in questo una critica spietata e puntigliosa al capitale senza poi nominarlo più di tanto (pochissimo), ma non perché non lo riconosca ma perché è interessato ad altro. C’è un’urgenza ed è quella che sembra andare in direzione contraria all’accelerazionismo, ad ogni accelerazionismo, sia quello dei post-umanisti tecnoentusiasti, ma indirettamente anche a quello di sinistra. Il concetto di embricatura non è infatti altro che un modo di frenare la corsa tecnologica. Sa perfettamente che l’innovazione, l’automazione, asservita agli interessi di pochi, non verrà usata per liberare la specie dal lavoro, ma che semplicemente creerà più disoccupazione, più precarizzazione, più proletarizzazione. Non verrà usata per mitigare l’impatto umano sul pianeta, ma verrà lasciata là, come possibilità potenziale della scienza, a poter trovare un rimedio.
 Il nodo centrale del libro forse è tutto nel denunciare le false promesse dello sviluppo digitale, individuando in esso un pericolo fondamentale, non soltanto per il suo potere fuorviante e per quello di sottrazione di risorse e ricchezze sia al resto dell’umanità che all’ambiente, ma anche per la capacità annichilente nei confronti della specie. Questo lo fa rimettendo al centro della questione il carattere ambivalente dell’esistenza umana che l’infosfera digitale vorrebbe ridurre alla univalenza. Per questo è un testo di critica del modello di sviluppo tutto incentrato sull’infatuazione digitale. Ma non è una critica alla scorciatoia tecnologica basata sulla estrazione e trattamento di enormi quantità di dati, è una critica al riduzionismo epistemologico intrinseco al passaggio dall’analogico al digitale. Un passaggio che non sarebbe negativo in sé ma che lo diventa nel momento in cui pretende di essere totalizzante.
Il nodo centrale del libro forse è tutto nel denunciare le false promesse dello sviluppo digitale, individuando in esso un pericolo fondamentale, non soltanto per il suo potere fuorviante e per quello di sottrazione di risorse e ricchezze sia al resto dell’umanità che all’ambiente, ma anche per la capacità annichilente nei confronti della specie. Questo lo fa rimettendo al centro della questione il carattere ambivalente dell’esistenza umana che l’infosfera digitale vorrebbe ridurre alla univalenza. Per questo è un testo di critica del modello di sviluppo tutto incentrato sull’infatuazione digitale. Ma non è una critica alla scorciatoia tecnologica basata sulla estrazione e trattamento di enormi quantità di dati, è una critica al riduzionismo epistemologico intrinseco al passaggio dall’analogico al digitale. Un passaggio che non sarebbe negativo in sé ma che lo diventa nel momento in cui pretende di essere totalizzante.
Ecco allora pagine dedicate a mostrare le differenze tra intelligenza biologica e intelligenza macchinica. A recuperare e analizzare il concetto di coscienza; a spiegare l’irriducibilità della mente umana a unità centrale di calcolo. Al recupero della emozionalità e del suo valore. Ma anche qui lo fa non tanto per recuperare l’umano in quanto tale o per una nostalgia umanistica. Non propone di tornare indietro, a prima della rivoluzione digitale. Lo fa mantenendo viva l’operazione del decentramento dell’antropo, anch’essa, in definitiva, minacciata dalla pervasività digitale.
Nel libro c’è tutto: la società della sorveglianza, le tecnologie predittive, i bias cognitivi che inquinano di default i data set. L’effetto discriminante e escludente di certi algoritmi. Ma l’intento non è soltanto quello di metterci in guardia di fronte a questi “malfunzionamenti” della tecnologia digitale asservita al profitto. C’è anche un’urgenza più generale e più profonda, quella di cambiare paradigma. Quella di indirizzare e costruire una alternativa al sistema. A un’analisi spietata dello stato di cose presenti e del percorso che queste avranno nel futuro, fa seguito allora il tentativo di costruire una alternativa. Di mettere insieme quegli strumenti epistemici per riuscire a maneggiare la tecnica dal punto di vista del bene comune.  Certo non può fare la rivoluzione da solo. E poi quale rivoluzione? Forse questo è anche il tempo di chiedersi di quale rivoluzione abbiamo bisogno ed è questo che Grossi prova a fare. Quanto efficientemente lo faccia, nessuno lo può dire adesso. In questa chiave le critiche non sono poi così produttive. I dialoghi, gli aggiustamenti, il lavoro collaborativo (anche quello intra specie), ben vengano. Intanto Grossi ci fornisce un bel po’ di materiale per metterci al lavoro.
Certo non può fare la rivoluzione da solo. E poi quale rivoluzione? Forse questo è anche il tempo di chiedersi di quale rivoluzione abbiamo bisogno ed è questo che Grossi prova a fare. Quanto efficientemente lo faccia, nessuno lo può dire adesso. In questa chiave le critiche non sono poi così produttive. I dialoghi, gli aggiustamenti, il lavoro collaborativo (anche quello intra specie), ben vengano. Intanto Grossi ci fornisce un bel po’ di materiale per metterci al lavoro.
Le immagini sono state generate da Midjourney su prompt dell’autore
Gilberto Pierazzuoli
Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)
- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024
- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023
- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023