Sentieri nell’Antropocene futuro
L’ecopessimismo è un punto di vista. “Se l’ecologia rappresenta la modalità attraverso la quale il pensiero umano si prende cura dell’ambiente (naturale, psicologico e socioculturale), elaborando una critica economico-politica dell’esistente, l’ecopessimismo prende le mosse da quest’ultima per isolare quello che è ormai tristemente conosciuto come il “worst case scenario” – il peggiore dei mondi possibili”. Dichiara Claudio Kulesko. Lo sguardo prospettico che indugia sugli scenari più orrifici. Su quegli scenari che alimentano il rimosso che nutre a sua volta l’angoscia che caratterizza la condizione degli umani in quanto sapiens. L’orrifico, come il perturbante, non è la catastrofe in sé, né la natura svelata, l’evidenza che si mostra. È fare i conti con alcuni aspetti del possibile stesso che, se anche inaspettato, si attuano. Non alla meraviglia del rimosso che si mostra, ma nel suo nascondimento che così rimane in agguato. Il modo di abitare dei sapiens è consistito nella domesticazione del selvatico secondo un doppio movimento: inglobare il selvatico nel domestico – strada intrapresa appunto dal pensiero selvaggio – o da una separazione dal selvatico. Di quest’ultima, l’urbanesimo occidentale ne è un primo sintomo, la rimozione dell’orrifico il secondo. L’angoscia quotidiana ne è infine la palesazione.

Il libro di Kulesko poteva limitarsi ad un excursus su questo altro mondo e la cosa poteva avere una sua valenza. In realtà è un testo ricchissimo, un testo di metafisica nel senso più profondo del termine. L’autore, pur sottolineando la valenza del concetto di naturcultura, recupera la polarità che vige tra i due termini; quel concetto per il quale la natura, così come gli organismi che la animano, emergerebbero da «processi discorsivi» come sostiene Haraway. Un concetto che non ci può fare dimenticare che ci sono enti la cui esistenza è data proprio “al di fuori di qualsiasi apparato discorsivo” (p. 9). Gli enti non domesticati, quelli che sfuggono alla presa dei sapiens, alla presa logica, tassonomica, sociologica. Ma anche a un’esistenza in sé che pervade le cose. Foreste che esistono “fuori dai libri mastri delle aziende di silvicoltura, dalle pubblicazioni scientifiche e dagli articoli nelle fanzine ambientaliste” (ibidem). Esistono a prescindere e questa loro esistenza a prescindere, è quella che ci permette di avere l’esperienza dell’incontro con il bosco. L’autore riesuma la natura e di pari passo la cultura, facendo sì che si possa dire che “quando un habitat scompare, o viene irrimediabilmente compromesso dall’attività umana, ciò avviene proprio a causa della cultura, dei discorsi, dei rapporti sociali e delle idee” (p. 10). Un’operazione che ha un che di leopardiano trasformando la natura, “madre accogliente”, in una matrigna. Questo presuppone anche una critica alla serie delle ontologie piatte, quelle che restituiscono agengy alle cose, ma non è una critica conservativa, è un espediente per permettere anche un altro sguardo, un’altra prospettiva. Permette la riemersione del rimosso, del selvatico.
 È un lavoro metafisico anche dove l’autore lascia lo spazio alla narrazione, ai racconti che si intra-mezzano nel testo speculativo per supplire alle mancanze espressive che esso comporta. Se la filosofia, divenendo “cultura”, divenendo tecnica, bisturi e grimaldello per operare sulla natura, aveva abbandonato la narrazione – le storie degli dèi e dei mortali e dei loro habitat, della magia delle cose, l’orrido stesso delle cose – il racconto ci restituisce qui, gli strumenti giusti per fare alfine i conti con il selvatico. Quell’ambito fondato sulla incapacità della cultura, dei sapiens, di farci presa.
È un lavoro metafisico anche dove l’autore lascia lo spazio alla narrazione, ai racconti che si intra-mezzano nel testo speculativo per supplire alle mancanze espressive che esso comporta. Se la filosofia, divenendo “cultura”, divenendo tecnica, bisturi e grimaldello per operare sulla natura, aveva abbandonato la narrazione – le storie degli dèi e dei mortali e dei loro habitat, della magia delle cose, l’orrido stesso delle cose – il racconto ci restituisce qui, gli strumenti giusti per fare alfine i conti con il selvatico. Quell’ambito fondato sulla incapacità della cultura, dei sapiens, di farci presa.
Splendido il capitolo sul paesaggio o meglio sulla sua percezione. Un paesaggio è tale in base a dei pattern riconoscitivi. E questi cambiano con la storia, sono sguardi storicamente, socialmente, linguisticamente e culturalmente determinati. “Tra il Sedicesimo e il Diciassettesimo secolo, la fruizione estetica del paesaggio naturale avrebbe soppiantato la visione utilitaristica degli ambienti non antropizzati” (pp. 54-55) Con la possibilità di postulare “che esso non sia esistito prima dell’invenzione della pittura paesaggistica” (ibidem). I pattern culturali si sovrappongono così alla percezione di origini più antiche anche dal punto evoluzionistico, per la quale esso era meramente il contenitore di minacce o di opportunità, trasportando quest’ultime nella percezione del paesaggio stesso. L’operazione che fa il sapiens è quella di ricucire i singoli pattern percettivi in uno unico, in una visione di insieme dove però adesso le singole parti acquistano reciprocamente senso. Un assemblaggio dice Kulesko, un agencement, in francese aggiungerei, un termine che allora evoca etimologicamente la sua agency e tutte quelle che operano al suo interno in un movimento generativo che emerge dal caos (dal caosmo diceva Guattari) dell’indistinto, ma che può avere esiti anche opposti. Le agency infatti possono essere «simbiosi, cooperazione e mutuo appoggio», ma anche «rivalità, antagonismo o conflittualità pura». I risultati possono così essere più o meno stabili, più o meno consolidati in una specie di pregiudizio o essere «dominati dal disordine, dal decadimento e dalle avversità». È dentro questa messa in ordine (un ordine può anche essere disordinato) che consiste la nostra percezione. Qualcosa che eccede i singoli contenuti. Il paesaggio ci sollecita, ci eccita e ci placa. A volte non è l’evento a metterci in guardia: è il paesaggio stesso ad allarmarci. “Tutto quello che è rimasto delle antiche paure si è riversato nella percezione, tanto vaga quanto irrazionale, di un pericolo di ordine soprannaturale” (p. 56) come dimostrano la figura prima indoeuropea, poi greca e latina di Ecate o il mito norreno della «caccia selvaggia». “Rielaborazioni immaginifiche del paesaggio stesso; astrazioni che rimandano a concetti quali la predazione, l’eterotrofia, lo smarrimento, la sfortuna, l’alterità non umana e tutte le minacce che costellano l’uscita dalla sfera del quotidiano e il corrispettivo ingresso nell’ignoto” (p. 57). Il paesaggio dell’Antropocene ha così una sua connotazione già abbastanza presagita in tanta letteratura e in tanta narrazione cinematografica. Un presagio di sventura, una visione tossica e desolata che avvolge lo spettatore, lo cattura nel paesaggio stesso.
 Anche la «radura» heideggeriana e i sentieri nel bosco, il concetto stesso di «aperto» come presaghi oppositivi dell’ignoto. Non a caso il capitolo sul paesaggio è preceduto da un racconto che vede come protagonista l’anziano filosofo. E il riferimento è proprio ai suoi ultimi saggi che per alcuni testimoniano una sua ultima svolta. Una ontologia ultima che il carattere della tecnica svela. Per Heidegger le cose, nel mondo della tecnica moderna, sono subordinate alla possibilità di essere usate, alla loro funzionalità e alla loro utilità. Ma questa utilità non è un concetto astratto, un attributo immanente alle cose, ma il suo contrario: la subordinazione delle cose al disegno storico sociale. La guardia forestale, dice il vecchio filosofo, se prima aveva una funzione volta a darci una visione dei cambiamenti e degli equilibri del bosco, adesso è impiegata strumentalmente dall’industria del legname che a sua volta deve fare riferimento alla domanda di carta destinata ai giornali e alle riviste. “Questi a loro volta, spingono il pubblico ad assorbire le cose stampate, in modo da divenire ‘impiegabile’ per la costruzione di una ‘pubblica opinione’ costruita su commissione”. L’asservimento funzionale al modo di produzione domina allora il mondo della tecnica. Ma quello che è ancora più interessante dal punto di vista dell’Antropocene, del rapporto cioè che gli umani intrattengono con il mondo, è il contributo che questo ultimo Heidegger ci dà nel saggio “Costruire abitare pensare”. È un gioco di posizionamento tra i mortali e gli dèi e tra terra e cielo. Senza stare qui a illustrare i passaggi e le conseguenze dei ragionamenti di un filosofo non facile da maneggiare e per di più filtrato dalla lettura che ne fa Kulesko, cito soltanto le conclusioni di quei ragionamenti: “Da tale prospettiva, infatti, rinunciare a metà della terra significa, al contempo, rinunciare alla modernità, all’utile, alla metafisica e al dominio, ma anche aver riconosciuto l’essenza divina al cuore di ogni cosa” (p. 41). Ragionamento che culmina con la citazione di due brevi brani dal saggio di Heidegger che illustrano il rapporto tra i mortali e la terra e il cielo. Riporto qui quello riguardo alla terra rimandandovi alla lettura dell’originale per quanto riguarda l’altro.
Anche la «radura» heideggeriana e i sentieri nel bosco, il concetto stesso di «aperto» come presaghi oppositivi dell’ignoto. Non a caso il capitolo sul paesaggio è preceduto da un racconto che vede come protagonista l’anziano filosofo. E il riferimento è proprio ai suoi ultimi saggi che per alcuni testimoniano una sua ultima svolta. Una ontologia ultima che il carattere della tecnica svela. Per Heidegger le cose, nel mondo della tecnica moderna, sono subordinate alla possibilità di essere usate, alla loro funzionalità e alla loro utilità. Ma questa utilità non è un concetto astratto, un attributo immanente alle cose, ma il suo contrario: la subordinazione delle cose al disegno storico sociale. La guardia forestale, dice il vecchio filosofo, se prima aveva una funzione volta a darci una visione dei cambiamenti e degli equilibri del bosco, adesso è impiegata strumentalmente dall’industria del legname che a sua volta deve fare riferimento alla domanda di carta destinata ai giornali e alle riviste. “Questi a loro volta, spingono il pubblico ad assorbire le cose stampate, in modo da divenire ‘impiegabile’ per la costruzione di una ‘pubblica opinione’ costruita su commissione”. L’asservimento funzionale al modo di produzione domina allora il mondo della tecnica. Ma quello che è ancora più interessante dal punto di vista dell’Antropocene, del rapporto cioè che gli umani intrattengono con il mondo, è il contributo che questo ultimo Heidegger ci dà nel saggio “Costruire abitare pensare”. È un gioco di posizionamento tra i mortali e gli dèi e tra terra e cielo. Senza stare qui a illustrare i passaggi e le conseguenze dei ragionamenti di un filosofo non facile da maneggiare e per di più filtrato dalla lettura che ne fa Kulesko, cito soltanto le conclusioni di quei ragionamenti: “Da tale prospettiva, infatti, rinunciare a metà della terra significa, al contempo, rinunciare alla modernità, all’utile, alla metafisica e al dominio, ma anche aver riconosciuto l’essenza divina al cuore di ogni cosa” (p. 41). Ragionamento che culmina con la citazione di due brevi brani dal saggio di Heidegger che illustrano il rapporto tra i mortali e la terra e il cielo. Riporto qui quello riguardo alla terra rimandandovi alla lettura dell’originale per quanto riguarda l’altro.
I mortali abitano in quanto essi salvano la terra […] Salvare non significa solo strappare da un pericolo, ma vuol dire propriamente liberare qualcosa per la sua essenza propria. Salvare la terra è più che utilizzarla o, peggio, sfiancarla. Il salvare la terra non la padroneggia e non l’assoggetta. (Heidegger, p. 100).
 Ma dove sta il pessimismo? Proviamo a ragionarci sopra. Se l’animale umano, il sapiens in particolare, si caratterizza per l’uso smodato della tecnica, e se questo aspetto ha portato a una crisi climatica che minaccia la sopravvivenza anche della sua specie, il tecno-ottimismo è allora una cura omeopatica sovradosata e coincide con la credenza che l’apparato tecnoscientifico troverà una soluzione alle problematiche sollevate. Se la visione ottimistica è questa, forse la soluzione andrà cercata in un atteggiamento epistemologicamente opposto. E qui Kulesko ci offre un ampio ventaglio di proposte che vanno dal sabotaggio violento della tecnica operato da Theodore J. Kaczinsky (Unabomber), agli antinatalisti, ai primitivisti, passando per l’atteggiamento intermedio quello dei survivalisti che si organizzano solipsisticamente per sopravvivere in un pianeta infetto, ma in maniera ben diversa dalla ricerca di pratiche di cura di sé e del mondo (abitanti compresi) sottesa alla proposta di Donna Haraway e di Anna Tsing. Questi lo fanno armandosi e costruendo bunker.
Ma dove sta il pessimismo? Proviamo a ragionarci sopra. Se l’animale umano, il sapiens in particolare, si caratterizza per l’uso smodato della tecnica, e se questo aspetto ha portato a una crisi climatica che minaccia la sopravvivenza anche della sua specie, il tecno-ottimismo è allora una cura omeopatica sovradosata e coincide con la credenza che l’apparato tecnoscientifico troverà una soluzione alle problematiche sollevate. Se la visione ottimistica è questa, forse la soluzione andrà cercata in un atteggiamento epistemologicamente opposto. E qui Kulesko ci offre un ampio ventaglio di proposte che vanno dal sabotaggio violento della tecnica operato da Theodore J. Kaczinsky (Unabomber), agli antinatalisti, ai primitivisti, passando per l’atteggiamento intermedio quello dei survivalisti che si organizzano solipsisticamente per sopravvivere in un pianeta infetto, ma in maniera ben diversa dalla ricerca di pratiche di cura di sé e del mondo (abitanti compresi) sottesa alla proposta di Donna Haraway e di Anna Tsing. Questi lo fanno armandosi e costruendo bunker.
La problematica gira intorno a una prima osservazione. Un conflitto originario tra natura e cultura. Se il fatto di pensare a questa separazione è all’origine dei molti degli atteggiamenti predatori nei confronti dell’ambiente perpetuati sicuramente da quella parte degli umani che appartengono a quella categoria astratta chiamata Occidente, il fatto di non occultarla completamente ci permette – permette all’autore – di confezionare un pharmakon pessimista che si spera abbia una sua efficacia. Il non occultamento parte da una prima lettura che non può non citare la pratica degli incendi boschivi finalizzata alla caccia praticata anche da popolazioni per altri versi pensabili immuni da questo peccato originario. Ovviamente c’è un tratto distintivo che lo ridimensiona a peccato veniale, il fatto che la pratica era comunque reversibile e non impediva la rinnovabilità del bosco. Il fatto è che nella contemporaneità che vede un mondo dominato dal sistema capitalistico che esprime il massimo della predazione possibile essendo un sistema cieco a tutto ciò che non produce profitto, non si può non imputargli lo stato disastroso che l’accelerazione capitalista, legata allo sfruttamento di energie non rinnovabili, ha prodotto. Il nodo è proprio questo. Il capitalismo non è ineluttabile, se lo fosse, acquisterebbero valenza le soluzioni pessimistiche più radicali come quella dell’estinzionismo, ma come un po’ tutte le altre. “Il decentramento dell’umano, la messa in discussione dei suoi caratteri che lo fanno percepire anche come ontologicamente superiore, non ci possono esimere dal dover prendere in considerazione l’eccezionalità umana pur ridimensionandone il valore che essa può assumere nei confronti con le altre specie e con il mondo tutto”, dicevo qui. Sarebbe una forzatura, seppur a fin di bene. E i modi per abitare il mondo in termini non distruttivi sicuramente esistono. In “L’alba di tutto”, Graeber e Wengrow ci dicono che l’evoluzione delle civiltà umane non si svolge lungo una linea che va da un inizio ben preciso al capitalismo contemporaneo che diviene così, ci piaccia o meno, il punto di arrivo. Le cose non stanno così perché all’alba di tutto le società umane hanno praticato innumerevoli comportamenti. La nascita della agricoltura non ha significato solamente la stanzializzazione e il successivo inurbamento. C’erano popoli nomadi che praticavano saltuariamente l’agricoltura, così come c’erano e ci sono popolazioni che quella strada non l’hanno mai intrapresa ma non perché erano più primitive, semplicemente, pur conoscendola, hanno deciso di non praticarla. Il vettore occidentale è una possibilità seppur malaugurata, ma non è il solo. Ha vinto perché è all’origine aggressivo. Lo è perché dietro la scelta prometeica che poteva comunque permettergli di confezionare strumenti collaborativi, ha scelto invece strumenti di competizione tra cui il più efficiente di tutti: le armi.
 Il racconto dell’opposizione pessimista allo scempio contemporaneo è svolto dall’autore in maniera elegante e documentata, capace di estrarre dalle teorie meno intuitive quelle ragioni che le innervano di osservazioni non banali che il nostro sguardo, che rimane ottimisticamente occidentale, non era stato capace di cogliere. Con la capacità anche di decostruire gli strumenti di condizionamento e disciplinamento che si sono opposti alla possibilità di avere una visione diversa. La stessa visione che Kaczynski dimostra di aver avuto come in questa sua citazione riportata anch’essa da Kulesko (p. 78):
Il racconto dell’opposizione pessimista allo scempio contemporaneo è svolto dall’autore in maniera elegante e documentata, capace di estrarre dalle teorie meno intuitive quelle ragioni che le innervano di osservazioni non banali che il nostro sguardo, che rimane ottimisticamente occidentale, non era stato capace di cogliere. Con la capacità anche di decostruire gli strumenti di condizionamento e disciplinamento che si sono opposti alla possibilità di avere una visione diversa. La stessa visione che Kaczynski dimostra di aver avuto come in questa sua citazione riportata anch’essa da Kulesko (p. 78):
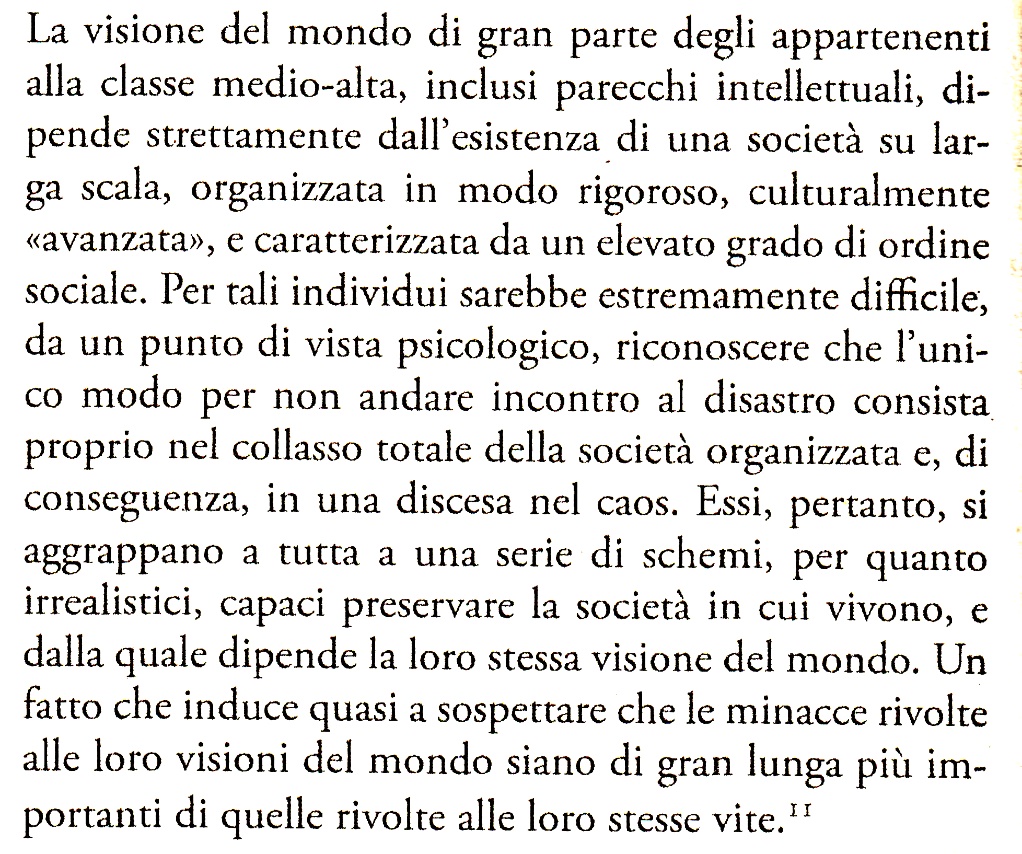
Molte delle nostre posizioni e delle nostre prese di coscienza a proposito dei risultati, anche catastrofici, che la nostra civiltà ha prodotto, sono debitrici delle opere di sci-fi. È quando la visione e la descrizione-rappresentazione, meglio di qualunque spiegazione razionale, veicolano meglio gli esiti spesso nefasti del nostro modo di abitare il mondo. Kulesko è maestro anche nel maneggiare questo materiale. I capitol IV, V e VI incentrati su dei “racconti”, delle parti narrative che molto ci ricordano il lavoro di Ursula Le Guin, di Stanley Robinson e di Liu Cixin. Ad esempio le operazioni di terraformazione che sono il massimo della visione antropocentrica e di dominio sulla natura che sia possibile pensare, ma che si fanno evidenti se osservate da un occhio esterno; come se un occhio alieno che abita il suo mondo ci vedesse arrivare con l’intento di terraformarlo.
Ma il pessimismo non è la cifra in sé e per sé. Non è l’altra faccia dell’euforia prometeica. Richiama anche figure ontologicamente bistrattate come il fantasma e la traccia. Dare agency alle cose non significa infatti darla a enti ben individualizzati nel senso di ben dividuati, ma più proficuamente al movimento di emersione e di continua trasformazione degli enti stessi che non abbandonano lo sfondo, non abbandono i legami che hanno con lo sfondo e con gli altri. Occorre smorzare la luce, scrutare nell’oscurità del magico divenire delle cose. Amare e temere l’oscurità così ricca e fertile.

E conclude: “In tal senso, l’ecopessimismo si rivela la forma più produttiva di pensiero speculativo, un modo per anticipare e metabolizzare i pericoli futuri, per prepararsi al peggio e smettere di sperare nell’intervento di un qualche deus ex machina” (p. 186).
Tutte le immagini sono state generate da una AI (intelligenza artificiale) text to image, dandogli in input citazioni che Kulesko mette in esergo ad ogni capitolo. Citazioni da Conrad, Emerson e Cormac McCarthy.
____________________
Altre indicazioni bibliografiche:
Martin Heidegger, Costruire abitare pensare, in idem, Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976
Klaudio Kulesko, Ecopessimismo. Sentieri nell’Antropocene futuro, Piano B Edizioni, Prato 2023, pp. 187, € 15.00
Gilberto Pierazzuoli
Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)
- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024
- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023
- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023


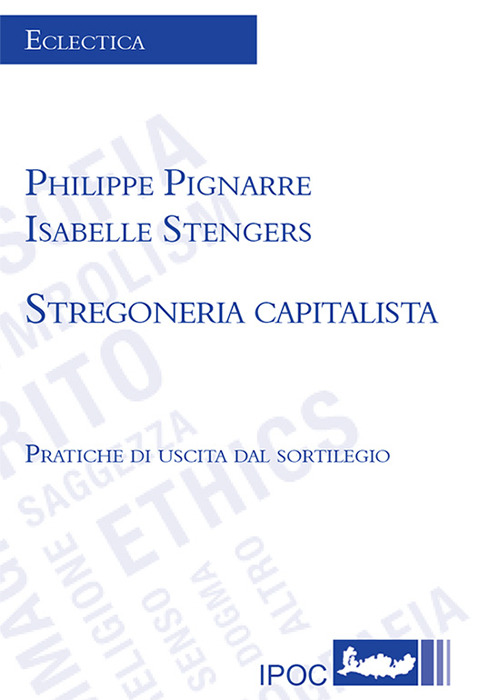




Pingback: Ecopessimismo -Sentieri nell’Antropocene futuro – Materia Impersonale