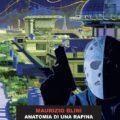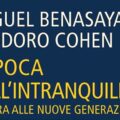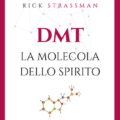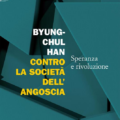Al centro c’è la relazione, che “precede l’individuazione e configura una dimensione del noi nella quale si individua il soggetto.” Prima viene il noi, la noità, poi viene l’individuo: “prima di essere individui apparteniamo ad uno spazio noicentrico” da cui si individua quel processo dinamico, chiamato Io. Siamo cablati per connetterci gli uni con gli altri, non siamo individui ma condividui. Parlare di condividui significa sostenere che in ognuno di noi coesiste una somiglianza con l’altro, che precede e determina la diversità e che a definire l’umano è la dimensione sociale e non quella individuale.
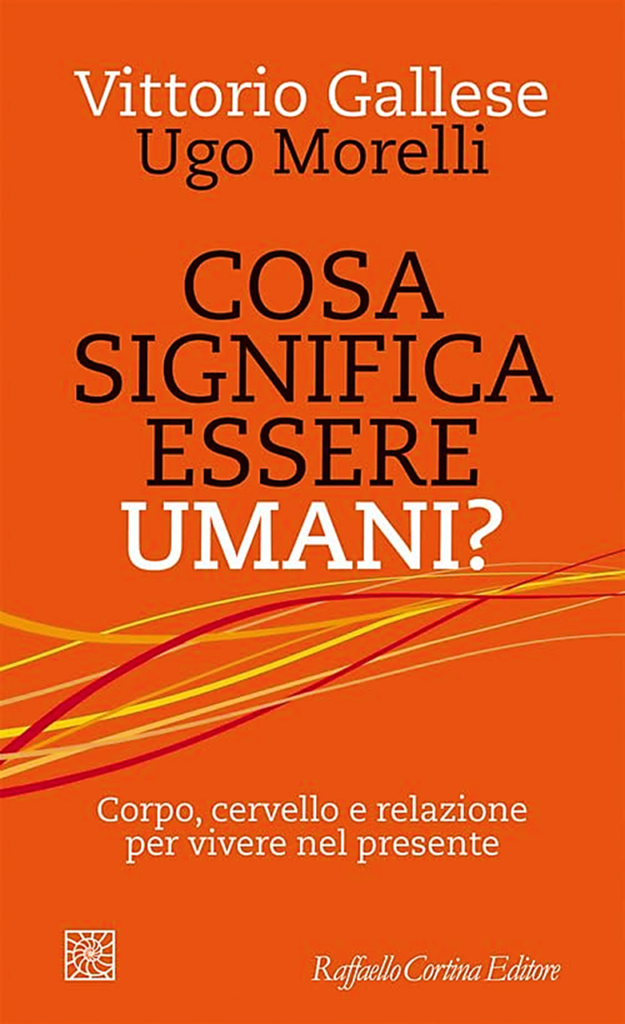 Sono alcune delle prospettive del libro Cosa significa essere umani?, scritto a quattro mani da Vittorio Gallese, neuroscienziato collegato alla scoperta dei neuroni specchio, e da Ugo Morelli, psicologo e studioso di scienze cognitive. Il sottotitolo è: “Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente”. Il punto interrogativo del titolo, racconta di tante domande aperte, e non di ricette. Il corpo è un punto centrale: “Un corpo che ‘si muove’ anche quando sta fermo. Il nostro ‘cervello sensorimotorio’ e affettivo, infatti si attiva non solo quando agiamo o proviamo delle emozioni o sensazioni, ma anche quando solo le immaginiamo, o le vediamo negli altri, o nelle rappresentazioni del mondo che dal paleolitico in poi abbiamo prodotto.” (“L’essere umano è corpo in movimento”, Avvenire, 30 giugno 2024, intervista a Vittorio Gallese).
Sono alcune delle prospettive del libro Cosa significa essere umani?, scritto a quattro mani da Vittorio Gallese, neuroscienziato collegato alla scoperta dei neuroni specchio, e da Ugo Morelli, psicologo e studioso di scienze cognitive. Il sottotitolo è: “Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente”. Il punto interrogativo del titolo, racconta di tante domande aperte, e non di ricette. Il corpo è un punto centrale: “Un corpo che ‘si muove’ anche quando sta fermo. Il nostro ‘cervello sensorimotorio’ e affettivo, infatti si attiva non solo quando agiamo o proviamo delle emozioni o sensazioni, ma anche quando solo le immaginiamo, o le vediamo negli altri, o nelle rappresentazioni del mondo che dal paleolitico in poi abbiamo prodotto.” (“L’essere umano è corpo in movimento”, Avvenire, 30 giugno 2024, intervista a Vittorio Gallese).
Un libro per sopravvenienti: “Noi esseri umani con ogni probabilità non siamo riducibili a quelli che esistono solo per sopravvivere, ma ci distinguiamo per sopravvenire: è la sopravvenienza, l’andare oltre se stessi, a costituire lo strato archeologico del nostro sistema corpo-cervello-mente, e a rendere possibile lo strato architettonico e costruttivo della nostra trascendenza creativa.” Un libro per “investire in eccedenza rispetto alle attuali modalità di rapportarci ai contesti delle nostra vita, alla nostra casa comune, in eccedenza rispetto a ciò che ognuno di noi farebbe spontaneamente, in eccedenza rispetto alla storia e alla tradizione […] Quando la realtà, qualunque essa sia, riesce, accoppiandosi con noi, a rivelare un’eccedenza di significato rispetto al significato che consuetamente le attribuiamo, ci porta a un lampo nel buio della continuità, facendoci vivere una tensione rinviante verso una ulteriorità di senso.”
Indispensabile per accedere a questi cosiddetti lampeggi dell’essere, è avere una mente sgombra, senza muri, senza ostacoli. “Ma questa è appunto la cosa più difficile e rara, perché la mente degli umani è sempre ingombra e come murata.” (Agamben, La mente sgombra) “Fare un’operazione di sgombero, fare posto, non solo potrebbe essere la vera tradizione che, anziché conservare, finalmente sgombra lo spazio, si apre e ci parla, ma assume il superamento della soglia in cui arcaico e contemporaneo, teoria e prassi, coincidono senza residui. Il ritorno al vuoto originario ci consente di riconoscere che conviviamo dalla nascita alla morte con un elemento impersonale e pre-individuale”.
“In un libro importante*, Simondon ha scritto che l’uomo è, per cosí dire, un essere a due fasi che risulta dalla dialettica fra una parte non individuata e impersonale e una parte individuale e personale. Il preindividuale non è un passato cronologico che, a un certo punto, si realizza e risolve nell’individuo: esso coesiste con questo e gli resta irriducibile.” (Agamben, op.cit) L’uomo non è soltanto Io e coscienza individuale, ma dalla nascita alla morte serba in sé una carica variabile di quell’apeiron (il pre-individuale) da cui Anassimandro fa scaturire ogni forma individuata, e da cui sorgerebbero anche le emozioni: “Emozionarsi significa sentire ciò che ci precede, il non essere, l’impersonale che è in noi, facendo esperienza contemporaneamente di angoscia o letizia, di sicurezza o tremore. Si fa strada, quindi, prima ancora del mondo fuori di noi come nostro antecedente evolutivo, ciò che meraviglia e stupisce, ovvero la presenza in noi di una parte per sempre immatura, infinitamente adolescente, che esita sulla soglia di ogni individuazione. Noi adultescenti, diceva sempre Luigi Pagliarani. Il rapporto con l’impersonale e l’originario si configura come un ritorno al futuro, ovvero come una tensione verso il possibile.”
Gli autori propongono anche la necessità di un’altra educazione, per formare giovani e adulti a sviluppare le proprie potenzialità creative, perché: “Fino a quando la bellezza rimarrà identificata con un canone esteriore, non riusciremo a sentirla agire in noi per quello che effettivamente può fare: estendere e aumentare le nostre possibilità, le nostre azioni e la concezione di noi stessi.”
Vittorio Gallese e Ugo Morelli, Cosa significa essere umani?, Raffaello Cortina, Milano 2024,pp. 291, euro 16
Giorgio Agamben, La mente sgombra, Einaudi, Torino 2023, pp. 212, euro 24
*Gilbert Simondon, L’individuazione psichica e collettiva, Derive-Approdi, Roma 2021, pp. 227, euro 18.
Gian Luca Garetti
Ultimi post di Gian Luca Garetti (vedi tutti)
- Dal papà supereroe al gemello digitale - 27 Maggio 2025
- Il partigiano che divenne imperatore - 13 Maggio 2025
- Dall’Ipnocrazia all’Ateismo cristiano - 15 Aprile 2025